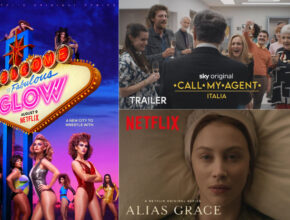Il 10 novembre è uscito su Netflix il nuovo film del regista statunitense David Fincher (famoso per pellicole come Fight Club e anche premiato per Il curioso caso di Benjamin Button e The Social Network): The Killer, già presentato in concorso all’80° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che con l’uscita ha definitivamente scatenato un mix di reazioni del pubblico e della critica tra elogi e condanne.
The Killer e la sua incompletezza
Un sunto può essere che, se da una parte fin dai primi secondi appare la critica dell’autore verso l’umanità e la società attuale attraverso gli occhi apatici del killer protagonista (tipica per lo sguardo disincantato e addirittura pessimista del cineasta, come in Seven, per esempio), dall’altra proprio la freddezza del personaggio di Michael Fassbender e del racconto (per la maggior parte soggettivo di quest’ultimo) porta il mondo rappresentato lontano dalla realtà e dallo spettatore. In pratica, il lungometraggio passa dall’essere un’opera di Fincher, in cui l’uomo “perfetto” per il mondo è un killer professionista, razionale al punto da assumere sembianze animalesche, ad un film crime apprezzabile per l’estetica curata nei dettagli ma con un ritmo inutilmente sostenuto. I difetti del film sono ampliati dagli evidenti pregi legati principalmente alla fotografia e in parte alla regia e al montaggio della pellicola, ma sono gli stessi lungometraggi precedenti a far inevitabilmente sorgere dei confronti, ed è dunque proprio in occasione di questi confronti che è utile parlare di 3 film, che possono essere giudicati più riusciti dell’ultimo (se non proprio i migliori della filmografia del regista).
Vediamo adesso i 3 migliori film di Fincher:
1. Seven (1995), dal genere all’autore
La prima pellicola da vedere è Seven del 1995, famoso soprattutto per la grande interpretazione di Kevin Spacey nei panni dell’antagonista serial killer, ma anche per il tema sotteso dei sette peccati capitali che dà il nome al lungometraggio e per il colpo di scena finale, forse più forte per l’aspetto emotivo che per quello narrativo. La storia è quella di un giovane e impulsivo detective (Brad Pitt), il quale viene affiancato contro il suo volere da un collega vicino alla pensione (Morgan Freeman) per indagare su una serie di delitti sempre più brutali, commessi da un misterioso omicida intenzionato a firmare ogni suo crimine con un messaggio riguardante un peccato capitale. La vera genialità del film di Fincher non è tanto nel colpo di scena o nella struttura della sceneggiatura, quanto nella scrittura dei personaggi e quindi dei loro dialoghi, di cui la bravura di Spacey è “la ciliegina sulla torta”, per non parlare del rapporto di odi et amo tra i due detective protagonisti, simboli di due caratteri eterni ed opposti della condizione umana, ovvero l’istinto e la ragione. Di simboli ce ne sono molti, in particolare legati alla religione e alla letteratura, ma ancora una volta il cineasta stupisce per come li rappresenta: la città di ambientazione, in cui si riassume tutto il pianeta per il detective razionale ed anziano, è l’Inferno dell’uomo che ha perso tutti i propri valori tornando allo stato animale, con colori freddi e ombre che rimandano al noir, ma che si fondono con immagini raccapriccianti di derivazione horror. In questo modo, il noir sul conflitto tra la polizia e un serial killer diventa l’horror sulla brutalità di un serial killer prodotto da un mondo in rovina, così come quello che sembra un comune film di genere si trasforma in un’opera d’autore.
2. Fight Club (1999): il postmodernismo
Del 1999 è quello che può essere considerato un capolavoro del regista, se non il capolavoro: Fight Club, basato sull’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. Il film di Fincher narra con una focalizzazione ampiamente soggettiva la monotona vita di un comune impiegato di una metropoli, che viene stravolta improvvisamente dall’incontro con l’eccentrico Tyler Durden, produttore e venditore di saponette, il quale lo incita a combattere la noia e l’ipocrisia della società dando voce ai propri impulsi primordiali nel modo più bizzarro possibile: facendo a pugni con lui. Seppur ferito e stanco, il protagonista sembra essere soddisfatto e vede lo stesso negli occhi di Tyler, dunque, avendo scoperto in precedenza che il suo appartamento era stato fatto esplodere, senza la minima idea di chi fosse stato o per quale motivo, accetta l’invito di andare a dormire dal “nuovo amico”, e così l’iniziale lotta di sfogo tra i due si trasforma, con l’aggiunta di conoscenti, nel segreto “Fight Club”. Anche qui lo strabiliante colpo di scena, la gestione della tensione e la fusione dei generi grottesco, crime e thriller sono testimoni della grande consapevolezza cinematografica del regista, che ai massimi termini rimanda a suoi idoli classici come Alfred Hitchcock. Non a caso, quello che ne esce fuori è un thriller-psicologico (come appunto Psycho del maestro britannico), che ancor più della pellicola precedente costituisce una grande critica alla società contemporanea, in particolare al consumismo e al capitalismo: tutta la messa in scena offre uno spettacolo raccapricciante per rappresentare la grande città, manifestando tutta l’apatia e il degrado morale attraverso colori sempre freddi, inquadrature piene di ombre e un senso di “sporcizia” costante nell’aspetto di personaggi e luoghi (in cui predomina il rosso scuro, quasi tendente al nero, del sangue). Il simbolismo fa comprendere infine che l’autore non compie una mera ripresa del classicismo, ma è definitivamente parte del postmodernismo – nel senso che si rifà alla cultura pop sfruttando la sua intermedialità più che alla cultura tradizionale come in Seven – tutto per criticare la stessa cultura ormai devota al consumo (basti pensare alle saponette nella locandina e alle immagini pornografiche di Tyler unite al montaggio).
3. Mank (2020), tra vita e cinema
Sebbene appaia molto diversa da tutto il repertorio del cineasta, Mank del 2020 è il terzo film di Fincher da guardare assolutamente. Prima di analizzare la sua importanza, è giusto riassumere la trama: a partire da fatti realmente accaduti e dall’articolo “Raising Kane” (“New Yorker”, 1971) di Pauline Kael, si seguono le vicende dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz (interpretato da un grandissimo Gary Oldman) durante la stesura di Quarto potere, capolavoro del 1941 di Orson Welles, e attraverso i frammenti della sua vita precedente che hanno portato al suo contemporaneo trionfo e declino. Le differenze sono a vista d’occhio nella sceneggiatura del film, che in questo modo si presenta senza alcuna connotazione di genere(vagamente biografico, ma anche per quello bisognerebbe ignorare la parecchia libertà del regista) e senza alcuna tematica simile alle pellicole precedenti; tuttavia, se si analizza nei dettagli, si può trovare l’intreccio come forma migliore di racconto di una vita e di un’idea, nonché la riflessione sul media del cinema come materia: entrambi i fattori emergono in altri due film, il primo in The Social Network, mentre il secondo nel già citato Fight Club. Proprio sulla materia è lecito soffermarsi, perché apparentemente la somiglianza è poca, eppure proprio il punto cruciale e meno considerato del lungometraggio precedente è indice del possibile paragone: Fincher utilizza nel suo film il racconto soggettivo del protagonista sia per analizzare la società sia per analizzare la sua psiche, che di fatto corrisponde al racconto e al cinema stesso, poiché lo spettatore guarda senza accorgersene il funzionamento di quella psiche e così anche il funzionamento del cinema. Dopo questa apparentemente complessa considerazione, è semplice affermare che in Mank si ha un identico proposito del cineasta, ma ancora più esplicito ed efficace grazie al protagonista, ovvero uno sceneggiatore. Lo studio dei mezzi cinematografici è caratteristica portante del postmodernismo, che qui di fatto si ritrova di nuovo. Al di là di questo, il bianco e nero aiuta grandiosamente nel ricordare lo stile del capolavoro di Welles, unito a una sceneggiatura e a un montaggio che si arricchiscono a vicenda grazie all’intreccio: è chiaro che ci si trova di fronte a un tributo a Welles, come ci si trova pure ad ammirare Mank più del suo regista (proprio come nell’articolo su cui è basato il film), però non manca assolutamente la profondità in ogni dissolvenza, inquadratura e battuta dell’opera, dal momento che la sceneggiatura, in stesura, è solo il presupposto per evocare esperienze personali del protagonista, la cui vita è quasi impossibile da descrivere nella sua totalità. In pratica, Fincher comprende la lezione di Mank e Welles in Quarto potere, applicandola alla vita di Mank (probabilmente il vero fautore del capolavoro) in un’opera complessa, come la vita e come il cinema.
Fonte dell’immagine per “Film di Fincher: i 3 migliori”: Wikipedia