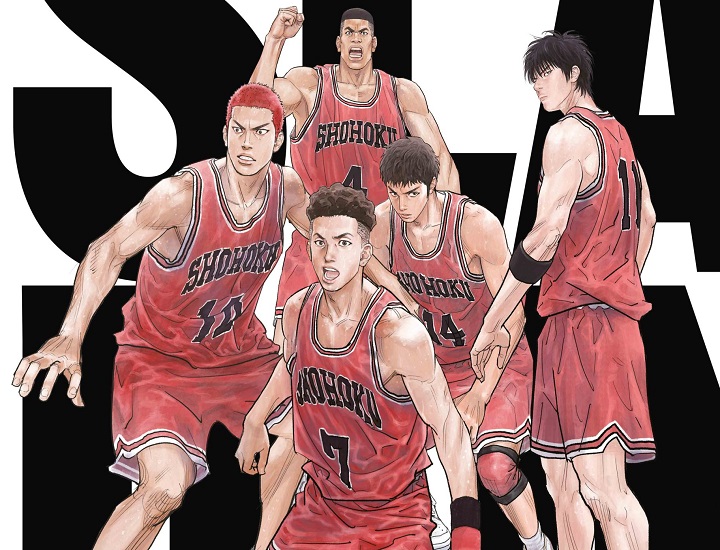Nel tentativo di fornire una definizione su cosa si intenda per jidai-geki, è necessario fare una premessa sul concetto di genere stesso in cinematografia, in quanto il jidai- geki è oggetto di analisi all’interno degli studi accademici e viene percepito da critici e studiosi non come una categoria statica, bensì come un elemento attivo e in costante evoluzione.
Sulla base di questo presupposto iniziale, secondo il critico Richard T. Jameson il concetto di genere, pur non emergendo esplicitamente in ogni conversazione o recensione cinematografica, è profondamente radicato sia nella natura stessa del cinema che nella percezione che il pubblico ha di esso. Egli sosteneva appunto che “I film appartengono ai generi più o meno come le persone appartengono alle famiglie o ai gruppi etnici”, suggerendo dunque che la categorizzazione dei generi non è solo un aspetto tecnico, ma un processo intrinsecamente culturale e cognitivo. Quando viene evocato un genere classico e consolidato come il western, la commedia, il musical o l’horror, persino il pubblico meno esperto è in grado di richiamare mentalmente un’immagine che combina elementi visivi e concettuali. Questo dimostra come i generi non siano soltanto categorie di analisi, ma veri e propri sistemi simbolici che organizzano e influenzano l’immaginario collettivo.
Quanto detto dimostra che la relazione di genere non è unicamente un’interpretazione complessa e unificata. Non esiste dunque una definizione univoca e definitiva di genere poiché ogni tentativo di categorizzazione è inevitabilmente influenzato da prospettive mutevoli e da contesti specifici. Gran parte della teoria dei generi si è concentrata proprio su queste strutture interne, cercando di identificare schemi predefiniti e relazioni tra testi simili, che produrrebbero letture e interpretazioni simili.
Che cosa s’intende per jidai-geki?
Dal punto di vista linguistico e semantico, il termine jidai-geki è composto da tre kanji: 時 (ji), che può essere tradotto come “tempo” o “ora”; 代 (dai), che si riferisce a un’era o a una generazione specifica; e 劇 (geki), utilizzato per esprimere il concetto di “rappresentazione teatrale o drammatica”. Questa combinazione etimologica evidenzia l’aspetto narrativo e performativo intrinseco al termine, sottolineando la sua funzione di ricostruzione simbolica e drammatica di un determinato periodo storico. L’etimologia di jidai-geki evidenzia pertanto l’intenzione primaria del genere e cioè quella di rappresentare attraverso una narrazione drammatica vicende ambientate in un determinato contesto storico. Nonostante queste storie siano spesso fittizie, il loro scopo è quello di offrire una ricostruzione storicamente contestualizzata, mirata a esplorare le dinamiche sociali, culturali e politiche del Giappone premoderno.
Questo modo di descrivere il genere di film spada, specifico della tradizione giapponese, iniziò a diffondersi principalmente tra gli appassionati di cinema durante il periodo d’oro del cinema samurai, attorno agli anni Trenta e Quaranta. Nonostante l’esatta origine del termine non sia chiarissima, è noto che si trattava inizialmente di un’espressione informale, spesso usata per designare i film d’azione focalizzati su combattimenti spettacolari e drammatici. Successivamente, il termine divenne popolare e accettato anche nell’ambito critico e accademico per descrivere un suo specifico sottogenere : il chambara, distinguendolo per la centralità delle scene di duelli con spade e il loro dinamismo. Pur essendo anch’esso inerente al contesto storico del jidai-geki, il chambara rappresenta comunque una declinazione più specifica e “dinamica del genere”. Diversamente dal jidai-geki, che può spaziare da narrazioni drammatiche a rappresentazioni di vita quotidiana, il chambara quindi si focalizza prevalentemente sull’azione e sul conflitto fisico, configurandosi come il filone dello “sword fighting”. Malgrado il termine abbia avuto in origine un uso informale, venendo adottato prevalentemente tra gli appassionati e nei circoli di critica cinematografica, esso è stato successivamente oggetto di studi accademici che ne hanno analizzato le peculiarità stilistiche e la funzione narrativa.
Qual è la differenza trai due generi?
Si potrebbe dire che la differenza sostanziale tra i due termini risiede a questo punto non tanto sull’ambientazione che rimane storicamente radicata in un Giappone feudale o premoderno quanto piuttosto nella vera e propria modalità di rappresentazione stessa: mentre il chambara incarna il lato più spettacolare e fisicamente espressivo del genere, ponendo l’accento su scene di combattimento e su una messa in scena dinamica che, per analogia, richiama il cinema d’avventura occidentale, il jidai-geki abbraccia una gamma eterogenea di narrazioni che possono includere sia riflessioni sociali e storiche sia elementi di introspezione psicologica.
Sebbene spesso associato al dramma storico, il jidai-geki si distingue infatti per “l’attenzione a conflitti morali psicologiche complesse”, come quello tra giri e ninjo, che non rappresentano dicotomie assolute ma tensioni contingenti che riflettono la necessità di compromesso nella vita reale. Oltre ai duelli e alle battaglie chambara sono molto comuni nei jidai-geki gli omicidi e questi e devono essere vendicati. Gli assassini raramente vengono sottoposti a giustizia legale: la morte di qualsiasi tipo raramente arriva come “giustizia poetica” o come punizione dai piani alti. Le implicazioni morali o simboliche della morte sono rare e quando un personaggio principale muore alla fine di un film, l’evento può non avere alcun significato trascendentale. La morte è spesso poco più di un espediente formale per terminare la storia.
Al centro del tutto vi è l’eroe, un samurai, un ronin, un kyokaku o un membro yakuza, figure che incarnano il dilemma tra responsabilità sociale e libertà personale, talvolta conducendo a un nichilismo autodistruttivo mentre invece il chambara incarna il lato più spettacolare e fisicamente espressivo del genere, ponendo l’accento su scene di combattimento e su una messa in scena dinamica che, per analogia, richiama il cinema d’avventura occidentale. Nel contesto delle trasformazioni stilistiche e tematiche del jidai-geki, è possibile osservare come il genere continui a funzionare all’interno di una tradizione narrativa giapponese caratterizzata da un atteggiamento fenomenologico di accettazione del mondo.
Le opere di questo genere tendono a presentare il mondo come un tutto, piuttosto che analizzarlo o definirlo, privilegiando la descrizione rispetto alla spiegazione. Questo approccio porta talvolta a una costruzione formale meno rigida, in cui il flusso drammatico si interrompe per riflettere su un momento specifico o per assaporare un’atmosfera, spesso al di fuori di una trama strettamente definita. Tale struttura narrativa, più incline a un eccesso di dettagli, rende difficile individuare un ordine preciso o una coesione formale, oscurando i motivi semplici che caratterizzano l’opera.
Un aspetto particolarmente interessante di questa estetica risiede nel fatto che la maggior parte dei jidai-geki si fonda su archetipi e convenzioni che sono immediatamente riconoscibili da un pubblico giapponese, il quale arriva al film con una comprensione condivisa di questi elementi. La vera sfida per il cineasta non è quella di introdurre elementi nuovi o sorprendenti, ma piuttosto di giocare con quelle piccole sottigliezze nell’esecuzione e nell’arrangiamento di materiali già familiari, proprio come avviene con la ceramica raku. Quest’ultima, infatti, pur essendo limitata a una forma di base e a pochi smalti, permette comunque una varietà di combinazioni che riflettono le diverse potenzialità di elementi già dati.
La familiarità visiva ed estetica di un film giapponese non deriva solo dai suoi contenuti narrativi, ma anche dalle modalità con cui le immagini e i suoni sono presentati. Nel cinema giapponese, le unificazioni non riguardano più di tanto la trama, il tempo, lo spazio, i personaggi o un punto di vista ma piuttosto l’atmosfera, il tono, il ritmo e l’effetto. Mentre i cineasti occidentali, soprattutto quelli statunitensi, tendono a privilegiare la coerenza della trama, i registi giapponesi pongono la narrazione al servizio di questi valori più sottili e fluidi. In questo contesto, la motivazione, la plausibilità e le relazioni causali diventano meno rilevanti rispetto alla ricerca di un’efficace trasmissione del tono e dell’atmosfera, che scivolano nella realtà stessa della vita. La trama, quindi, funziona come un supporto agli altri elementi narrativi, piuttosto che come un fine in sé.
Questa impostazione comporta un tipo di realismo che non si preoccupa di rispettare i criteri drammatici di verosimiglianza, ma cerca piuttosto di restituire l’impressione di un’esperienza viva e tangibile. La psicologia dei personaggi non è motivata dalla logica delle azioni, ma è descrittiva, come quella proposta dal filosofo William James. L’emozione spesso segue il gesto, piuttosto che esserne la causa, come dimostrano le frequenti scene in cui un personaggio scoppia a ridere (basti pensare a Rashōmon di Akira Kurosawa) senza apparente motivo, per poi rendersi conto del proprio dolore.
Ultima ma non priva di importanza, la caratteristica distintiva della narrazione giapponese è la sua struttura non lineare e modulare: e connessioni tra gli eventi sono associative piuttosto che sequenziali e un elemento si collega a un altro come anelli di una catena, senza un disegno preciso che attraversi l’intera opera (torna l’esempio di Rashōmon). Questo approccio contrasta molto la tradizione europea, dove le trame sono costruite in modo da intessere fili unificanti che collegano l’inizio e la fine. Se Godard affermava che “i film possono avere un inizio, una metà e una fine, ma non necessariamente in quest’ordine”, i film giapponesi, al contrario, potrebbero non avere né inizio né fine, ma piuttosto tre mezze parti, disposte in un ordine che non segue una logica convenzionale.
Fonte immagine in evidenzia: Wikipedia dal film I Sette Samurai di Akira Kurosawa, 1954. {{|Descrizione = Screen dal film I sette samurai |Fonte = Screenshot catturato da me |Data = 09/06/2013 |Autore = Jc88 | |Detentore copyright = Toho |EDP = [[Wikipedia:Copyright…]