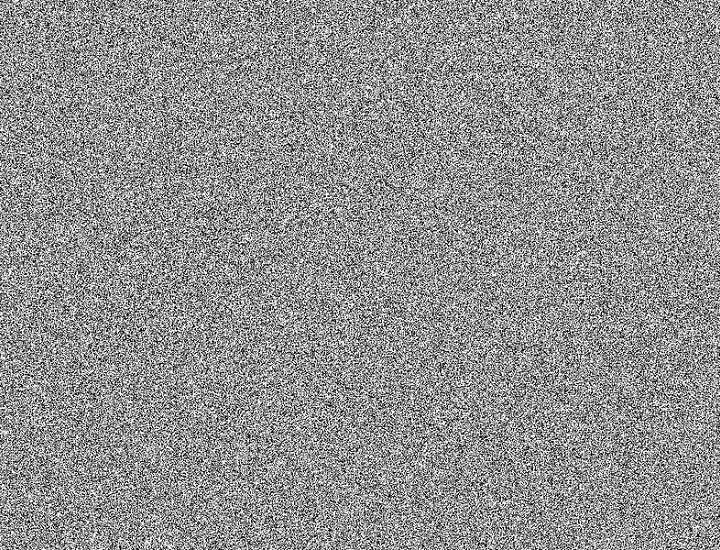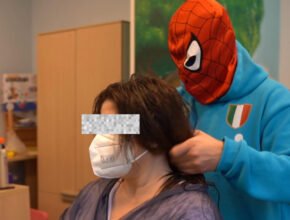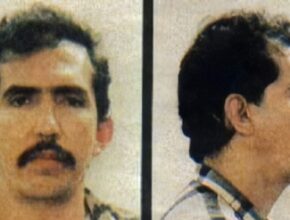Il paradosso del gatto di Schrödinger: un esperimento mentale tra fisica quantistica e filosofia
Il paradosso del gatto di Schrödinger è uno degli esperimenti mentali più celebri e discussi della fisica quantistica. Ideato dal fisico austriaco Erwin Schrödinger nel 1935, questo esperimento illustra in modo provocatorio le apparenti contraddizioni che emergono quando si applicano i principi della meccanica quantistica a un sistema macroscopico, come appunto un gatto. Il paradosso del gatto di Schrödinger, in realtà da lui chiamato “esperimento”, ha stimolato un intenso dibattito tra fisici e filosofi, contribuendo a mettere in luce le peculiarità e le questioni ancora aperte nell’interpretazione della meccanica quantistica. Il paradosso del gatto di Schrödinger non è un semplice gioco intellettuale, ma un esperimento mentale che tocca questioni fondamentali sulla natura della realtà, sulla misurazione quantistica e sul ruolo dell’osservatore. La sua apparente semplicità nasconde una profondità concettuale che continua ad affascinare e a stimolare la riflessione a distanza di quasi un secolo dalla sua formulazione. La sua rilevanza è tale che, in un certo senso, ha oltrepassato i confini della fisica per diventare un riferimento culturale condiviso, come testimonia la citazione, in chiave comica, nella serie tv The Big Bang Theory.
Cos’è il paradosso del gatto di Schrödinger?
Il paradosso del gatto di Schrödinger, come detto, è un esperimento mentale, ideato per illustrare le conseguenze paradossali dell’interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica quando applicata a oggetti macroscopici. Schrödinger, già premio Nobel per la fisica nel 1933 per i suoi contributi alla meccanica quantistica (in particolare per l’equazione che porta il suo nome), con questo esperimento mentale volle evidenziare i limiti di tale interpretazione, e sottolineare l’incertezza degli studi in quel momento.
L’esperimento mentale di Erwin Schrödinger
L’esperimento, descritto nel saggio “La situazione attuale della fisica quantistica“, immagina un gatto chiuso in una scatola d’acciaio insieme a un dispositivo costituito da un rilevatore Geiger, un martelletto, una fiala di cianuro e una piccola quantità di sostanza radioattiva. La quantità di sostanza è scelta in modo che, in un’ora, ci sia il 50% di probabilità che un atomo decada, emettendo una particella, e il 50% di probabilità che non decada. Se un atomo decade, il rilevatore Geiger lo rileva e aziona il martelletto che rompe la fiala di cianuro, uccidendo il gatto. Se, invece, nessun atomo decade, il gatto rimane vivo. Il punto fondamentale è che, secondo le leggi della meccanica quantistica, finché non si apre la scatola e non si osserva il sistema, l’atomo si trova in uno stato di sovrapposizione quantistica, ovvero è contemporaneamente decaduto e non decaduto. Di conseguenza, anche il gatto si trova in uno stato di sovrapposizione, in cui è contemporaneamente vivo e morto.
Il paradosso del gatto di Schrödinger e l’interpretazione di Copenaghen
L’interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, sviluppata principalmente da Niels Bohr e Werner Heisenberg negli anni ’20 del XX secolo, è stata la prima e più diffusa interpretazione dei postulati quantistici. Essa si basa sul concetto di dualismo onda-particella, di sovrapposizione quantistica e di probabilità, e afferma che le proprietà di un sistema quantistico non sono definite fino a quando non vengono misurate.
Principi della meccanica quantistica e il problema della misurazione
Secondo l’interpretazione di Copenaghen, un sistema quantistico può trovarsi in una sovrapposizione di più stati possibili. Solo al momento della misurazione, la funzione d’onda del sistema “collassa” in uno stato definito, e solo in quel momento si può parlare di una realtà oggettiva. Questo concetto è strettamente legato al principio di indeterminazione di Heisenberg, che afferma l’impossibilità di conoscere con precisione assoluta, contemporaneamente, alcune coppie di variabili, dette coniugate, di una particella, come posizione e quantità di moto. Inoltre, per la fisica quantistica il comportamento di una particella elementare, come un neutrone, un elettrone, un protone o un fotone, non è prevedibile con esattezza, ma solo in modo probabilistico: si può dire cosa accadrà alla particella, ma non quando. Invece, per i sistemi macroscopici, composti da milioni di atomi, una volta conosciuti alcuni dati, si può sapere con esattezza cosa e quando accadrà qualcosa in essi.
La sovrapposizione quantistica e il gatto “vivo e morto”
Il paradosso del gatto di Schrödinger mette in luce l’apparente contraddizione tra la descrizione quantistica del mondo microscopico e la nostra esperienza quotidiana del mondo macroscopico. Se applichiamo l’interpretazione di Copenaghen al gatto nella scatola, dobbiamo concludere che, prima dell’osservazione, esso si trova in uno stato quantistico di sovrapposizione, in cui è contemporaneamente vivo e morto. Solo l’apertura della scatola, e quindi l’atto di misurazione, fa collassare la funzione d’onda in uno stato definito (vivo o morto). Il fatto che il rilascio della dose di cianuro, e quindi la morte del gatto, sia legato al decadimento radioattivo, che è casuale, rende il destino del gatto incerto fintantoché la scatola rimane chiusa: non si può dire né quando il gatto è deceduto (se ciò accade), né se sia vivo o morto. In realtà, il fisico non chiamò mai “paradosso” l’esperimento del gatto, e il contrasto col determinismo della fisica classica è una considerazione anch’essa “classica”: Schrödinger volle sottolineare l’allora incertezza degli studi, e di come la meccanica quantistica fosse applicabile anche ad un essere vivente, non solo ad un sistema.
Interpretazioni alternative al paradosso del gatto di Schrödinger
Il paradosso del gatto di Schrödinger ha stimolato la formulazione di diverse interpretazioni alternative della meccanica quantistica, che cercano di risolvere le apparenti contraddizioni poste dall’esperimento.
L’interpretazione a molti mondi (MWI) di Hugh Everett III e Bryce Seligman DeWitt
Una delle interpretazioni più radicali e discusse è l’interpretazione a molti mondi (MWI), proposta da Hugh Everett III nel 1957 e successivamente sviluppata da Bryce Seligman DeWitt. Secondo la MWI, ogni volta che si verifica un evento quantistico con più esiti possibili, l’universo si divide in tanti universi paralleli quanti sono gli esiti possibili. Nel caso del gatto di Schrödinger, nel momento in cui l’atomo decade, l’universo si dividerebbe in due universi: in uno l’atomo è decaduto e il gatto è morto, nell’altro l’atomo non è decaduto e il gatto è vivo. In questo modo, la MWI elimina il concetto di collasso della funzione d’onda e risolve il paradosso, sostenendo che tutti gli esiti possibili si realizzano effettivamente, ma in universi diversi. Un’altra interpretazione è quella della decoerenza quantistica, secondo la quale l’interazione tra un sistema quantistico e l’ambiente circostante porta alla rapida dissipazione della sovrapposizione quantistica, facendo emergere un comportamento di tipo classico.
Il paradosso del gatto di Schrödinger: implicazioni filosofiche e applicazioni nella vita quotidiana
Il paradosso del gatto di Schrödinger non ha solo implicazioni per la fisica, ma anche per la filosofia, in particolare per la filosofia della scienza. Esso mette in discussione concetti come la realtà oggettiva, il determinismo e il ruolo dell’osservatore nella definizione della realtà fisica. Alcuni filosofi hanno utilizzato il paradosso per sostenere una visione antirealista della scienza, secondo cui le teorie scientifiche non descrivono una realtà oggettiva, ma sono solo strumenti per fare previsioni. Altri hanno invece difeso una posizione realista, cercando di reinterpretare la meccanica quantistica in modo da renderla compatibile con una realtà oggettiva e indipendente dall’osservatore. In un certo senso, il paradosso del gatto di Schrödinger può essere applicato a eventi della vita quotidiana, o meglio, alla nostra percezione di essi. Schrödinger, in un certo senso, ci invita a cambiare prospettiva, e a riflettere sui continui dubbi che ci assillano quando dobbiamo compiere una scelta: perché immaginare tutti gli scenari possibili di un determinato evento, se non possiamo sapere come davvero andranno i fatti?
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/gatto-gattino-marocco-1072241/