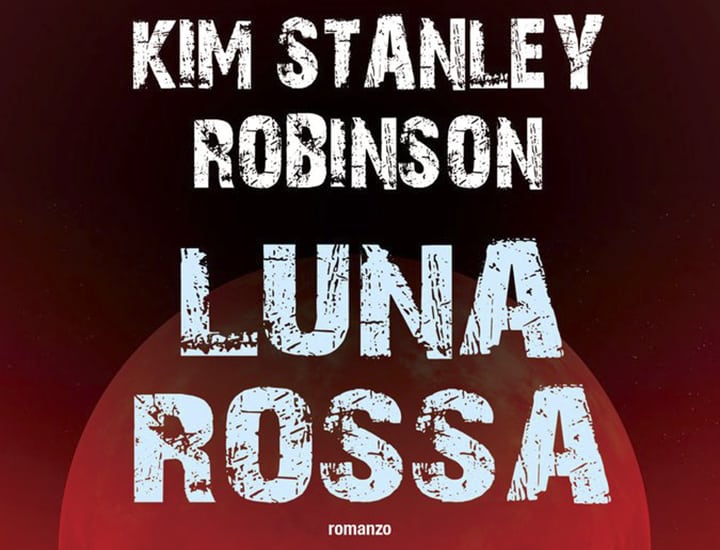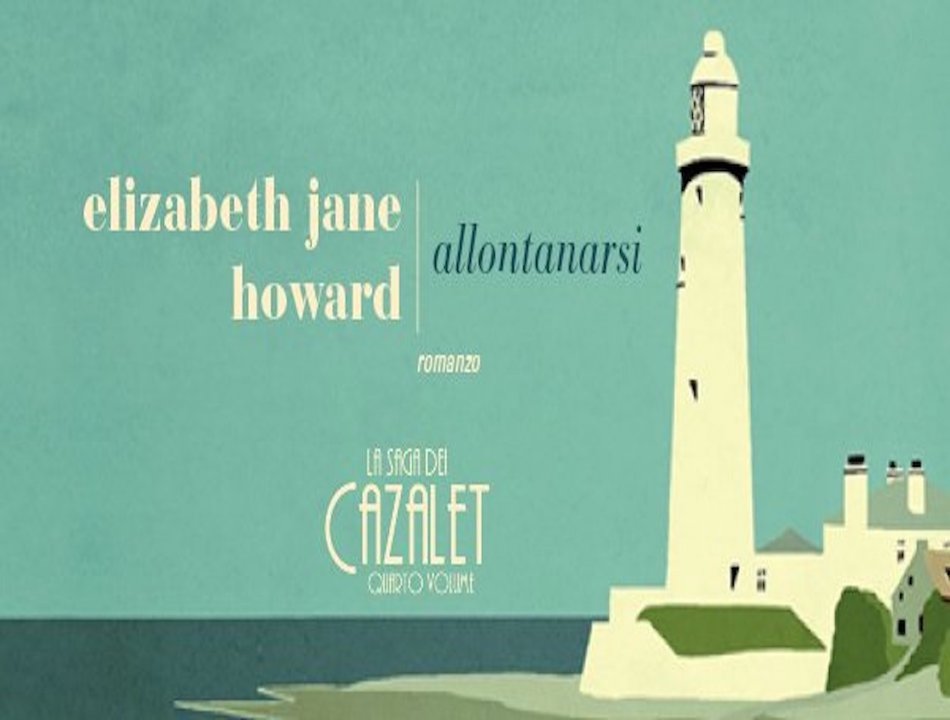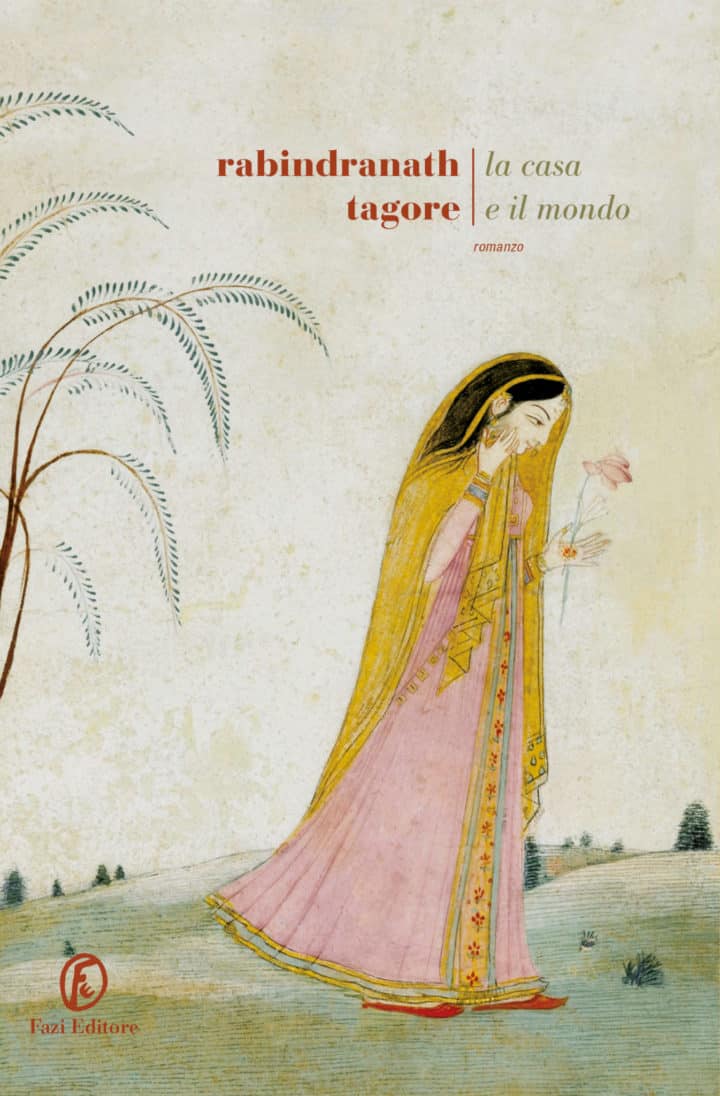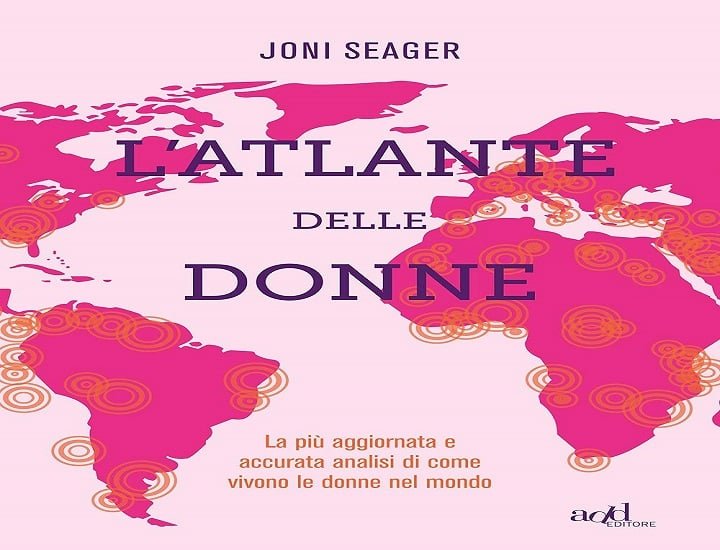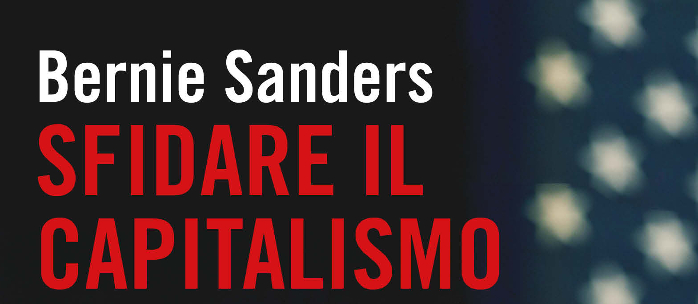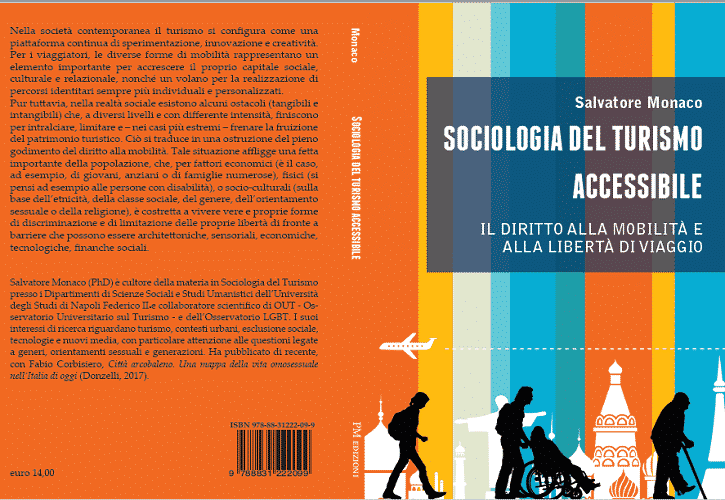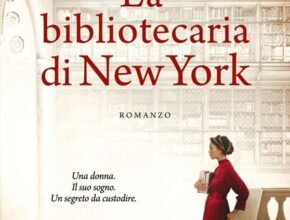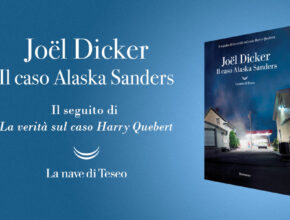Shikabane no machi (屍の街, Città di cadaveri, 1950) è l’opera più conosciuta di Ōta Yōko (大田洋子, 1906-1963), pubblicata in pieno periodo di censura da parte dello SCAP in un Giappone totalmente sconfitto e vittima degli occupanti. Rispetto ai lavori di Hara Tamiki (原民喜, 1905-1951), quello della scrittrice appare più freddo e analitico. Le spiegazioni tecniche e scientifiche abbondano, come nel caso della descrizione dell’emorragia causata dalla malattia acuta da radiazione. Il sangue non appare più rosso ma «nero, polposo e marcio», simbolo della tremenda natura dell’atomica, capace di decostruire e deturpare l’anatomia delle sue vittime.
Anche se, più di una volta, ha sostenuto di non essere stata in grado di scrivere di Hiroshima come faceva Hara, e pur soffrendo l’impossibilità di raggiungere i suoi livelli di lirismo, Ōta riesce comunque a dar prova di grande talento e profondità espressiva. L’autrice sembra rifugiarsi nelle statistiche, nelle pubblicazioni sugli avanzamenti medici e nelle analisi scientifiche del bombardamento per razionalizzare l’accaduto e sfuggire alla paura spaventosamente reale di poter morire da un momento all’altro. Città di cadaveri è un racconto dalla straordinaria intimità, scritto da una donna che, nonostante lo shock e le condizioni incredibilmente avverse, sceglie di riportare gli avvenimenti che ha vissuto nella maniera più sincera possibile. Non manca, infatti, di rivelare anche il suo lato più umano ed egoista, in più momenti.
Tenere in vita una città di cadaveri
Dopo essersi imbattuta nella terribile visione del giovane Gin-chan, un parente della famiglia che la stava temporaneamente ospitando dopo gli avvenimenti di Hiroshima, scrive: «Avevo sentito dire che era tornato due o tre giorni fa. Se era davvero lui, avevo sentito che i suoi capelli stavano cadendo e che i suoi denti erano allentati nelle gengive, come se avesse la piorrea; inoltre, aveva perso così tanto peso da sembrare uno scheletro vivente». Nel mezzo di una conversazione con la scrittrice, il ragazzo, che nel momento dell’esplosione si trovava a Hiratsuka, a meno di un chilometro dall’epicentro, sostiene che sicuramente non gli sarebbe rimasto molto da vivere. Dopo averlo incoraggiato a farsi forza, Ōta torna a rivolgersi ai lettori e afferma: «Fu con emozioni complesse che parlai al giovane uomo, dato che se davvero fosse riuscito a sopravvivere nonostante le sue condizioni, allora anch’io, che non avevo ancora mostrato sintomi, avrei potuto farcela».
Oltre ai capitoli di taglio fortemente scientifico, vi sono anche sezioni dedicate alla storia di Hiroshima, dal Sengoku Jidai (戦国時代, Sengoku jidai, “periodo degli stati combattenti”, ca1467-1615) al periodo Tokugawa (徳川時代, Tokugawa jidai, 1603-1868). In altri ancora, si concentra sulla descrizione degli abitanti della città, con particolare attenzione alle donne, dalla carnagione scura e dal carattere gioviale. Nella sua cronaca, Ōta tratteggia con estrema precisione anche la topografia di Hiroshima, quasi a voler ricostruire, attraverso la storia e la geografia, l’immagine di un luogo che ormai non esisteva più.
Nonostante la sua narrazione sia più lineare rispetto a quella di Hara, risulta particolarmente lenta, quasi sospesa nel tempo. Il trascorrere delle ore e dei giorni diventa impossibile da scandire. Ōta stessa evidenzia questo spaesamento temporale tramite un passaggio in cui, rivolgendosi alla sorella e alla madre chiede: «Cosa stavate facendo voi due ieri mattina?» e riceve come risposta: «Ieri? Era questa mattina!». È una confusione che richiama quella dello scrittore di Natsu no hana, seppur con una sfumatura distinta.
La scomparsa di ogni strada
Le persone, disorientate dall’accaduto, cercavano di dare un senso a ciò che era successo. Molti credevano che una bomba incendiaria – probabilmente un Molotoffano hanakago, nome dato dai giapponesi ai grappoli di bombe ad auto dispersione lanciati dai B-29 americani, menzionati dal dottor Machii in Hiroshima di John Hersey – fosse esplosa direttamente sulle loro case.
Il senso di solitudine emerge di continuo, tramite l’immagine di esseri umani abbandonati a loro stessi, privi di qualsiasi aiuto, salvo un breve episodio in cui alcuni militari offrono del cibo alla madre di Ōta. Nuovamente, una particolare attenzione è riservata alle condizioni delle abitanti di Hiroshima. L’autrice ritrova nei loro corpi uno spettacolo angosciante, poiché, in quanto donna, non riesce a restare impassibile alla visione dei fisici privati della propria femminilità. Ormai più simili a statue bronzee del Buddha che a esseri umani: senza capelli, con il volto e i genitali gravemente sfigurati.
Alla fine del diciottesimo capitolo emerge la frustrazione, probabilmente condivisa da tutti i sopravvissuti, per l’inutilità delle esercitazioni militari a cui erano stati sottoposti durante la guerra. Nulla di ciò che avevano preparato – elmetti, secchi d’acqua, kit di primo soccorso, addestramenti antiaerei – si era rivelato utile a qualcosa. Ciò suggerisce che nessuno avrebbe potuto prevedere le conseguenze di un evento così immensamente al di là dell’immaginazione umana. Inoltre, l’autrice osserva come perfino un colpo di pistola lasci un segno più definito rispetto alle schegge scagliate dall’esplosione, rafforzando l’impossibilità di concepire appieno la devastazione atomica. Perfino la guerra, nel suo profondo orrore, conserva contorni più comprensibili e umani rispetto all’abisso insondabile della tragedia di Hiroshima.
La necessità di preservare la memoria degli eventi di Hiroshima trova una chiara espressione nello scambio tra Ōta e un ufficiale dell’Occupazione, che si presentò alla sua porta dopo il primo tentativo dell’autrice di pubblicare Città di cadaveri. Si trattava di un uomo americano bianco e alto, accompagnato, come spesso accadeva, da un interprete statunitense di origini giapponesi, facilmente riconoscibile per la discrepanza fisica con il collega. All’epoca, gli ufficiali d’intelligence del Civil Censorship Detachment non si curavano di leggere davvero i manoscritti che gli venivano sottoposti. Preferivano, invece, recarsi personalmente dagli autori per porre loro domande dirette e sbrigative: si informavano, ad esempio, se l’opera fosse già stata diffusa tra conoscenti, quali fossero le idee politiche di questi ultimi, o se nel testo comparissero riferimenti ai segreti sulla bomba atomica scoperti camminando per Hiroshima dopo il 6 agosto.
Una città di cadaveri impossibile da dimenticare
Al termine dell’incontro, l’ufficiale le ordinò di dimenticare i ricordi legati al Little Boy, sostenendo che l’America non avrebbe mai più impiegato un ordigno nucleare in ambito bellico. La scrittrice, però, rispose con fermezza: «Non penso potrò mai dimenticarlo. Anche se volessi farlo, non potrei».
Ōta, a differenza della sorella che non riusciva nemmeno a posare lo sguardo sul mare di moribondi e cadaveri che affollavano le strade, li osservava con attenzione. Quando, incredula, le chiese se mai avrebbe potuto scrivere delle vicende di Hiroshima, l’autrice rispose: «Sto guardando con due paia di occhi – gli occhi di un essere umano e gli occhi di una scrittrice […] Un giorno dovrò farlo. È la responsabilità di chi ha visto».
Scrivere di Hiroshima era, più che un diritto, un obbligo morale a cui non poteva sfuggire in alcun modo, neppure volendolo. La città aveva intrappolato nel turbinio della distruzione tutti i suoi superstiti, costringendoli, come sotto un incantesimo, a narrare del disastro per non dimenticare.
Fonte dell’immagine: Amazon, Inari Books