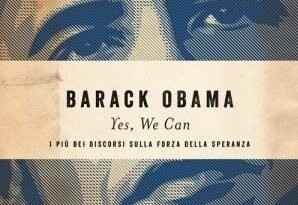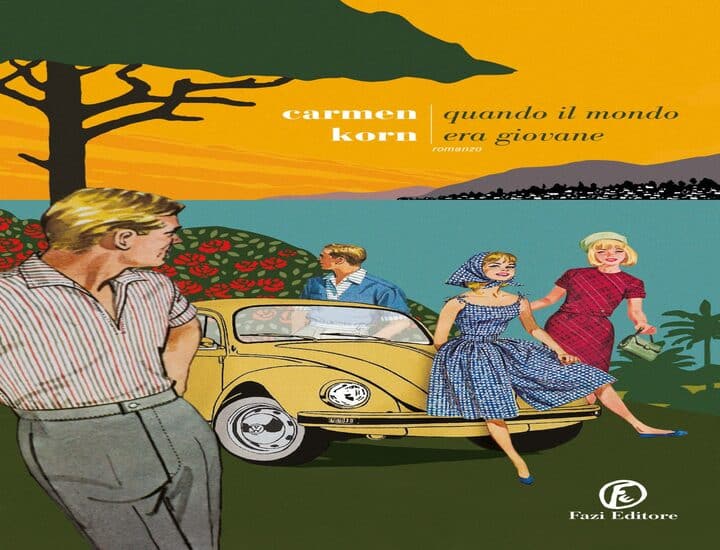È finalmente uscito presso Fazi Editori “Dipendenza”, il romanzo forse più sofferto di Tove Ditlevsen, la grande scrittrice danese morta suicida a Copenaghen nel 1976.
“Un giorno voglio scrivere tutte le parole che mi attraversano. Un giorno altre persone le leggeranno in un libro e si stupiranno che una ragazza possa nondimeno essere poeta”: così scriveva Tove Ditlevsen nei giorni in cui prometteva a se stessa che avrebbe sposato la scrittura e che le sue parole avrebbero preso la forma sacra della poesia più pura.
La giovane, complicata, insicura Tove, nata a Copenaghen nel dicembre 1917, si affaccia nel mondo letterario danese già a vent’anni. Debutta su una rivista di poesia, “Vild hvede”, con un componimento profondo intitolato “Al mio bambino morto”. Ma Tove Ditlevsen, a vent’anni, non ha ancora vissuto in prima persona l’esperienza dell’aborto, raccontata invece senza fronzoli negli anni della maturità in “Dipendenza”, ultimo capitolo di quella “trilogia di Copenaghen” che l’ha finalmente resa famosa nel mondo, a più di quarant’anni dalla morte.
DIPENDENZA di TOVE DITLEVSEN: la nostra recensione
La trilogia segue la vita stessa di Tove Ditlevsen: il primo romanzo, intitolato Infanzia, si sofferma sulle difficoltà della piccola Tove in quello che Heidegger definirebbe il suo “commercio-col-mondo”. Un mondo in cui una bambina precoce che scrive poesie viene derisa per questa sua passione ritenuta insana, inusuale e inadatta a una ragazza, ma non per questo si perde d’animo. Prova ne è il secondo capitolo della trilogia, Gioventù, nel quale Tove prende ulteriormente coscienza di se stessa e si promette di farcela, felice e sorridente davanti a una macchina da scrivere.
Diversa è la fase di vita raccontata in “Dipendenza”, edita – come i volumi precedenti – da Fazi editore nella traduzione di Alessandro Storti. Anzitutto, va segnalato un appunto sul titolo, che ricalca, sì, la traduzione inglese “Dependency”, ma perde un po’ l’ambivalenza linguistica che l’originale danese invece contiene. Nella lingua scandinava, infatti, il titolo è “Gift”, parola che è sia il participio di un verbo (coniugato al femminile, significa: “sposata”) che un sostantivo: “veleno”.
Nella vita di Tove Ditlevsen le due realtà coincidono, ed è proprio questa compresenza ad essere messa nero su bianco in “Dipendenza”. Tove ha appena vent’anni quando sposa il suo primo marito, di trentatré anni più anziano ma assai influente nel mondo culturale cittadino. Lo tradirà poco dopo e già nel mentre con un giovane di belle speranze, che poi a sua volta tradirà Tove, la quale sposerà senza indugi un coetaneo, di nome Ebbe, con il quale avrà la sua prima figlia, Helle. Ma l’idillio dura poco, poiché Tove conosce Carl, un medico. Ed è con lui che il titolo del romanzo assume anche la sfaccettatura italo-inglese della dipendenza vera e propria.
Carl è infatti un medico senza scrupoli che comincia a sedare e allo stesso tempo drogare Tove con quel rimedio – da lei visto come un’autentica panacea – chiamato petidina. Tove è già una scrittrice affermata, ma ha voglia e bisogno di scrivere, e non sempre ci riesce da sola, complice una seconda gravidanza non particolarmente desiderata se non per ragioni di sopravvivenza agiata con un medico che possa garantirle una casa, una famiglia, e, soprattutto, innumerevoli palliativi “dopanti” largamente utilizzati in medicina.
Facendosi iniettare la petidina e altre sostanze a piacimento con una siringa, Tove vive inizialmente un periodo letteralmente “stupefacente”, nel quale riesce persino a scrivere e ad esprimere se stessa, finché poi non arriva ad esagerare, a prescriversi le ricette da sola falsificando la firma del marito, contravvenendo alle raccomandazioni dei medici, allontanandosi dai figli, dai genitori e dagli amici. Qualcuno comincia a preoccuparsi per lei, nessuno vede di buon occhio lo psicotico Carl, anche lui in balia di varie ossessioni, malato, complesso e con la mania del controllo. Un controllo maniacale su Tove, che arriva a pesare meno di sua figlia e nulla ricorda delle promesse pattuite con se stessa, resasi estranea è irriconoscibile al punto tale da preferire la petidina alla scrittura.
Uno dei passaggi che causano più rabbia nei lettori di “Dipendenza” è quello in cui Tove finge addirittura una malformazione inesistente all’orecchio a condizione di essere operata e di ricevere altra petidina. Si resta inermi dinanzi alle pagine in cui si assiste al deperimento di una delle più grandi scrittrici danesi del Novecento: un’autrice più volte infelicemente sposata che – parafrasando il titolo originale – finisce colpevolmente avvelenata.
Ricoverata poi in un ospedale psichiatrico per disintossicarsi, Tove Ditlevsen divorzierà dal marito medico e, appena tornata a casa, conoscerà un nuovo uomo con cui presto convolerà a nozze. “Dipendenza” non racconta come andrà a finire con il quarto marito. Il libro termina, anzi, con un finale speranzoso, che – come Tove – quasi non vuole cedere alle tante tentazioni che la vita offre, seppur declinata in diverse ingannevoli forme.
Una trilogia da leggere tutta d’un fiato, quella costituita da “Infanzia”, “Gioventù” e “Dipendenza”. Uno stile semplice, circoscritto, spesso cinico, a tratti indifferente, egoistico, narcisistico, pur sempre specchio del sentire di una donna fragile, avvelenata, tormentata e intossicata dalle sue stesse dipendenze.
Uscirà in autunno la prima traduzione italiana di un’antologia di Tove Ditlevsen (pubblicata da Joker edizioni) con una scelta di cinquanta poesie. Il titolo ha in sé il germe della promessa che quella bambina timida fece a se stessa: “Una ragazzina che non vuole morire”.
Fonte immagine: Ufficio Stampa Fazi Editore