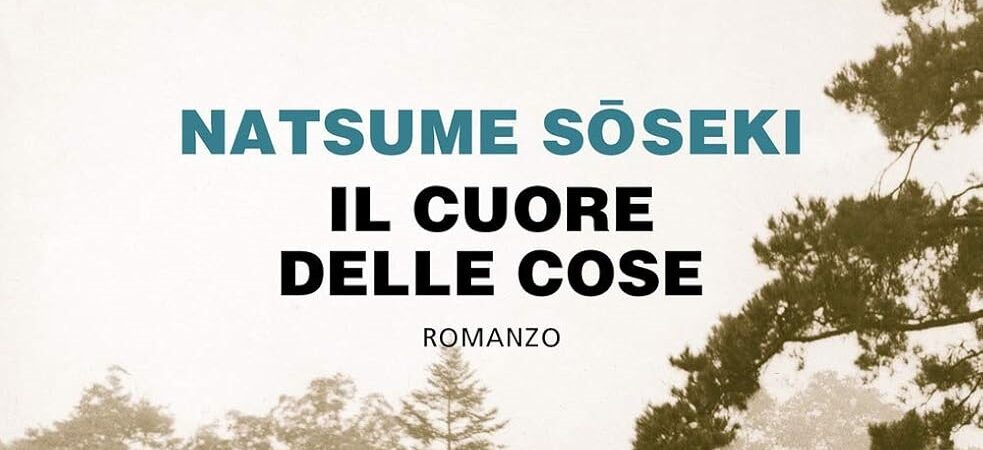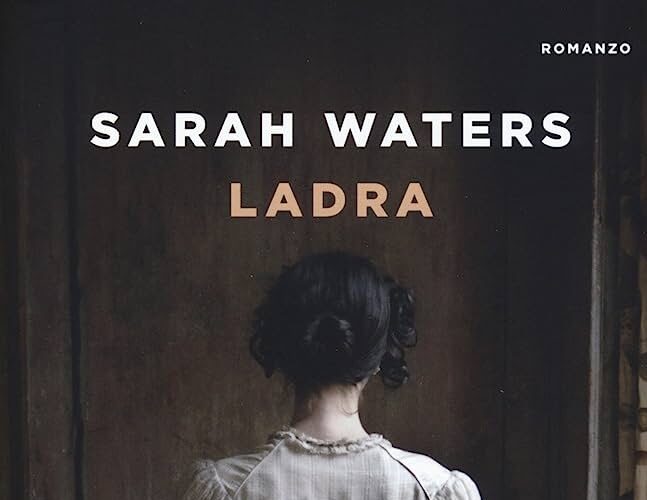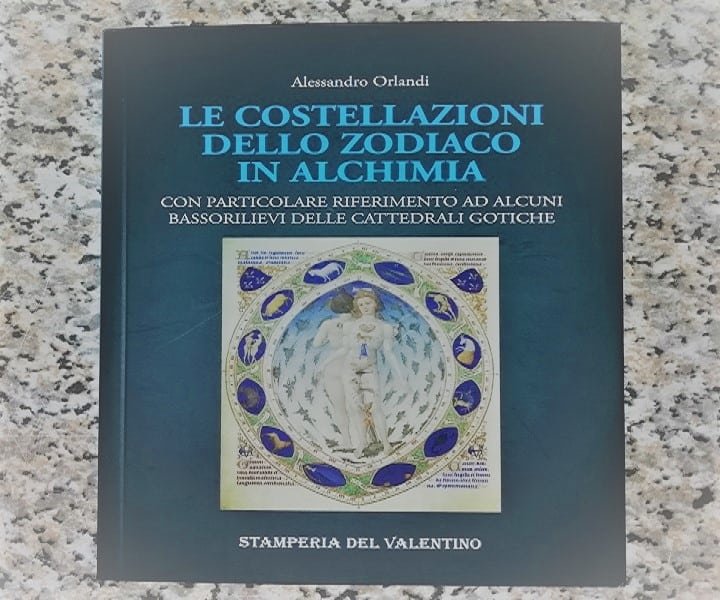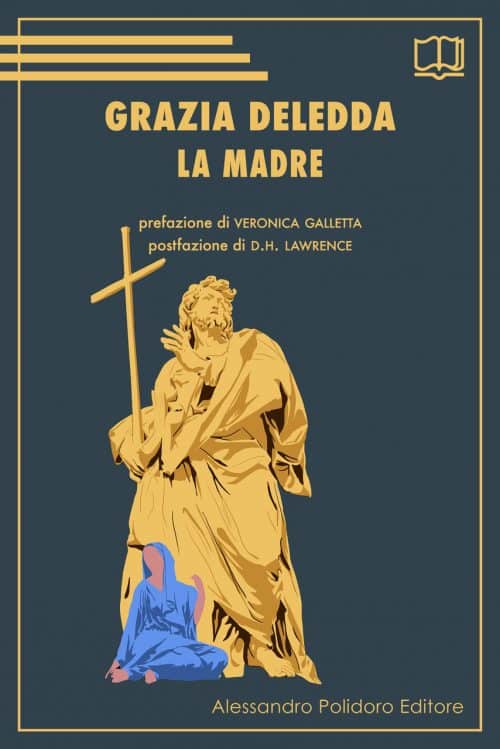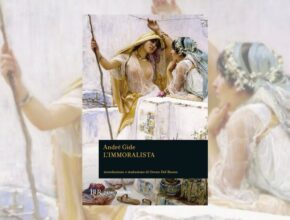Natsume Sōseki (夏目漱石), nato Natsume Kinnosuke (夏目 金之助, 1867–1916) è uno dei nomi più importanti nel milieu letterario giapponese. Ex volto delle banconote da 1000 yen, prima di essere sostituito da Hideyo Noguchi e Kitosato Shibasaburō (rispettivamente serie E e serie F), lo scrittore originario di Edo ha giocato un ruolo fondamentale nell’espressione del senso di alienazione che gran parte degli abitanti giapponesi hanno provato al passaggio dal Periodo Edo (江戸時代) a quello Meiji (明治時代).
Conosciuto per lavori come Io sono un gatto (吾輩は猫である, Wagahai wa neko dearu, 1905), Il signorino (坊ちゃん, Bocchan, 1906) e Guangiale d’erba (草枕, kusamakura, 1906), nel 1914 pubblicò quello che, ad oggi, è riconosciuto come il suo più grande capolavoro, Kokoro (こころ, Il cuore delle cose), originariamente rilasciato a puntate sull’Asahi Shinbun.
Il romanzo
L’opera di Sōseki illustra, con la maestria e l’eleganza tipiche dell’autore, il ritratto di una società in pieno mutamento, ormai del tutto impegnata nella corsa senza sosta all’occidentalizzazione; cieca dinanzi allo straniamento e al disagio di chi è ancora legato alle proprie radici.
Il cuore delle cose, infatti, viene pubblicato solo due anni dopo un evento che fece tremare la struttura identitaria, storica e politica del Giappone: la morte dell’imperatore Meiji (明治天皇), il 30 luglio del 1912.
Questo lutto sancì la fine di un’epoca, marcata da una transizione del Giappone proto-moderno verso una nazione bramosa di trovare un nuovo posto all’interno del quadro internazionale.
Il suicidio combinato del generale Nogi e sua moglie, in un atto di junshi (殉死, togliersi la vita dopo la morte del proprio signore) durante i funerali dell’imperatore, rispecchiò lo stato d’animo di un’ampia fetta di abitanti, rappresentata, nel romanzo, dai personaggi del Sensei e dal padre del protagonista senza nome, che si rivede, con riverenza e umiltà, nella figura del Figlio del Cielo, pensando addirittura che siano afflitti dallo stesso malessere.
La fase immediatamente successiva a questa tragedia, al debutto del Periodo Taishō (大正時代, 1912-1926), è stata definita da un senso di alienazione dilagante che ha macchiato l’intero paese; il fatto che i personaggi di Kokoro non abbiano un nome ne è una prova. In una società che, da un momento all’altro, risulta irriconoscibile agli occhi dei propri cittadini, il senso di inadeguatezza, di smarrimento e di incompatibilità con lo scorrere del tempo può avere la meglio sullo spirito, sia quello più resiliente, come nel caso del generale Nogi, che quello più fragile e delicato, come nel caso del Sensei.
I personaggi de Il cuore delle cose
Il Sensei, in uno dei numerosi scambi che ha con il protagonista, compie una disamina della società in cui vivono, affermando: “Vedi, la solitudine è il prezzo che noi dobbiamo pagare per essere nati in quest’epoca moderna, così piena di libertà, indipendenza ed egoistica affermazione individuale“.
Proprio come Sōseki, con cui condivide anche l’amore per la poesia cinese, questo personaggio porta la bandiera di una generazione “di mezzo”, nata nel pieno di un enorme mutamento.
Il Sensei è il simbolo della confusione che attanaglia il Giappone; è diviso tra l’interesse per la letteratura straniera, l’impossibilità di comprendere appieno il comportamento «non umano» del compianto amico K., educato secondo i principi confuciani, e l’attaccamento a una società che non ha fatto in tempo a sentire davvero sua.
In questo romanzo è giapponese chi bada a tenere i suoi sentimenti prudentemente nascosti nel fondo del cuore e il contrasto tra la permalosa campagna, dove la reputazione va tenuta immacolata, in cui la casa è il centro della famiglia e la fredda Tōkyō, ormai lanciata nel futuro, rappresentano alcune tra le maggiori testimonianze di criticità e incompatibilità sociali.
Conclusione
Il vero e proprio dialogo tra generazioni era ancora inimmaginabile, come dimostrato dalle ultime parole del testamento morale che il Sensei invia al giovane studente, prima di togliersi la vita: “tu ed io apparteniamo a epoche differenti […] non possiamo far niente per gettare un ponte sul vuoto che ci separa“.
Fonte dell’immagine: Amazon – BEAT editore