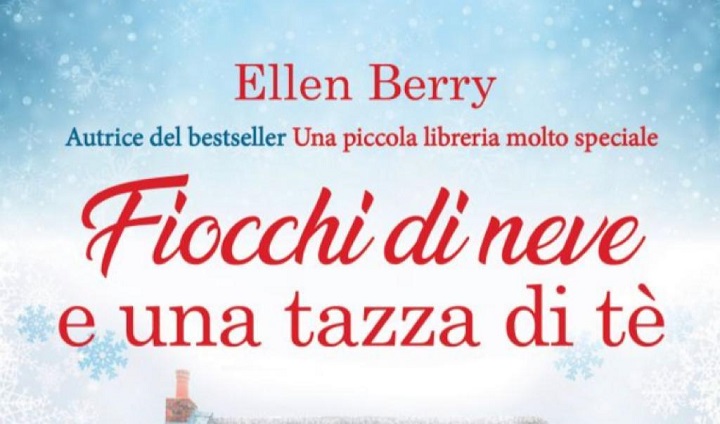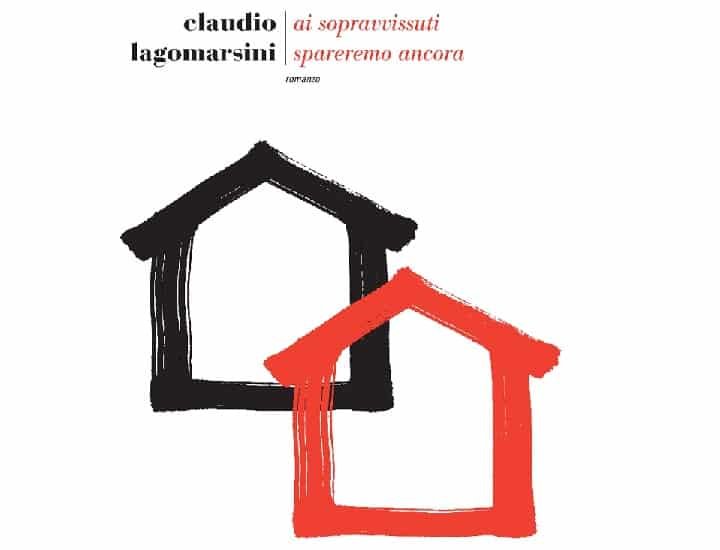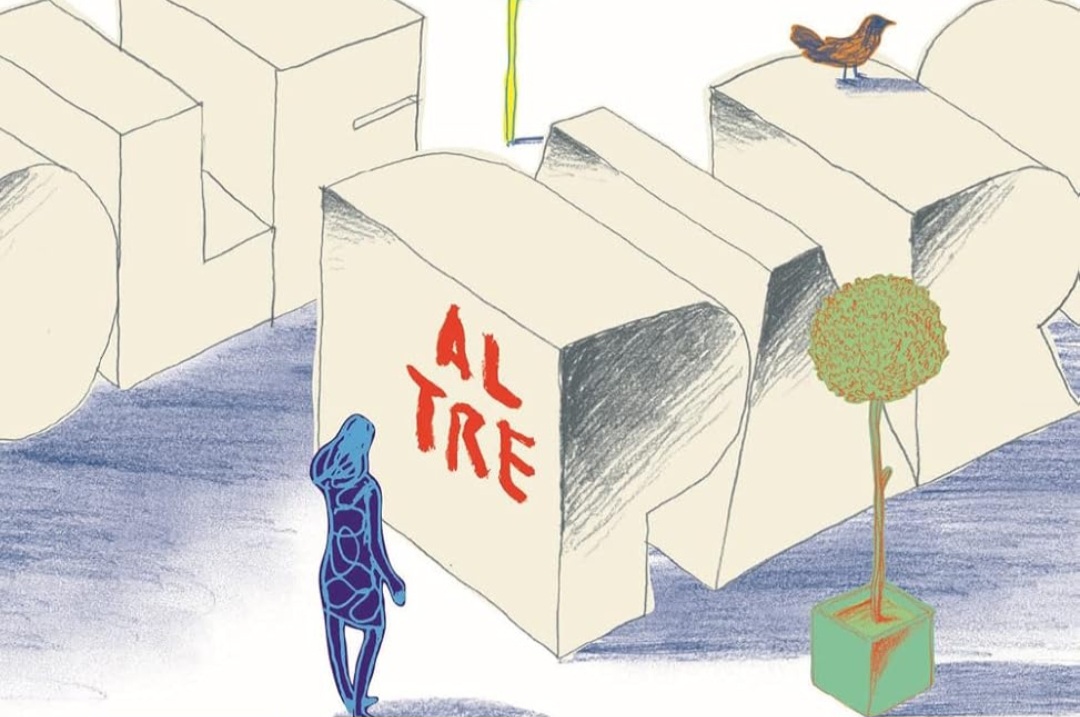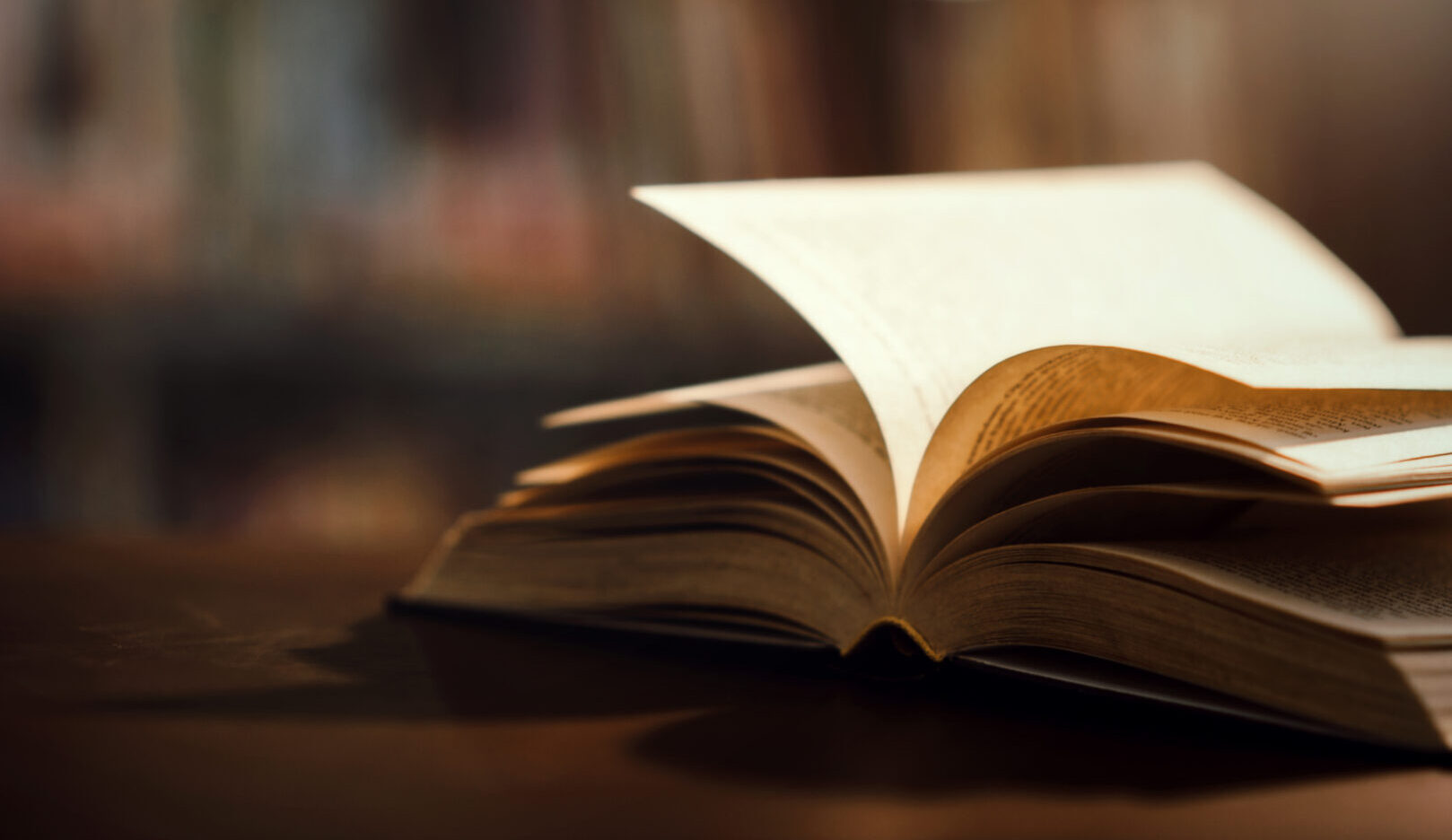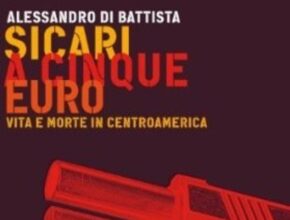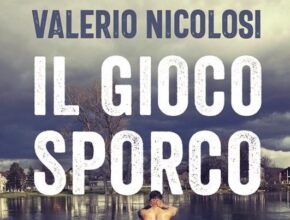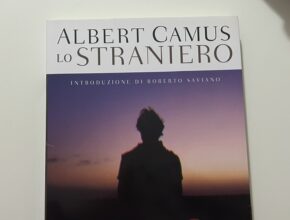Le poesie di Tōge Sankichi(峠三吉, 1917-1953) scritte dopo l’olocausto di Hiroshima e raccolte nella sua magnum opus Genbaku shishū (原爆詩集, Poesie della bomba atomica) sono cronaca ibrida degli effetti dell’atomica e della sua indignazione verso la malvagità del genere umano. Non fa affidamento sulla ben conosciuta forma del tanka o dello haiku, impiegata in migliaia dei suoi lavori precedenti, bensì, sceglie il verso libero. Non c’è un numero preciso di strofe o versi, né alcuna coerenza nella lunghezza delle singole poesie. Al contrario, egli decide di sperimentare sia nella forma che nei contenuti, cavalcando l’onda d’urto del disastro nucleare che, sei anni prima, aveva raso al suolo la sua Hiroshima. Abbandona le regole, il vecchio modo di comprendere e fare poesia, cercando di replicare l’effetto devastante della bomba.
Dolore in rima
La poesia Morendo inizia con un esclamazione sorda, rappresentata graficamente da un punto esclamativo, inusuale per la lingua giapponese, in cui tale effetto viene solitamente reso tramite l’uso di apposite particelle grammaticali. In 86 versi, Tōge dipinge gli ultimi istanti di vita di un abitante di Hiroshima il 6 agosto, concentrandosi sulla rappresentazione del dolore, sia fisico che interiore, e sulla devastazione materiale.
“Girando in tondo, come nella danza bon,
ragazze nude:
ne cade una, cadono tutte.
[…]
Un occhio che supplica ai miei piedi.
una testa bollita di bianco.
Capelli, materia cerebrale che le mie mani spingono verso il basso.“
Le diapositive proiettate dalla memoria del poeta sono di estrema sofferenza, e l’alternarsi tra descrizioni crude e strofe pregne di lirismo trasporta il lettore tra le macerie della città giapponese, come se la si stesse attraversando quel 6 agosto. Morendo non ha una fine netta, si spegne come una fiamma in carenza di ossigeno, flebilmente e senza quasi fare rumore.
“Ah!
Perché?
Perché qui
sul ciglio della strada,
separat*, car*, da te;
perché
devo
io
morire
?“
In questa poesia non si rinviene né rabbia né livore, ma piuttosto un senso di terrore e disperazione per una morte che rimarrà per sempre inspiegata. La straordinaria abilità dell’autore si manifesta anche in un dettaglio così sottile da sfuggire quasi alla percezione: la sua capacità di filtrare una pluralità di emozioni, alcune delle quali erano ancora in fase di elaborazione, in base agli effetti che desiderava suscitare nel lettore.
Nel componimento che fa da introduzione a Poesie della bomba atomica, Preludio, recitato dall’amico Tsubota al fianco del suo letto d’ospedale un’ora e quindici minuti prima che esalasse il suo ultimo respiro, sono ira e frustrazione le emozioni prevalenti.
“Ridacci i padri! Ridacci le madri!
Ridacci gli anziani!
Ridacci i figli!
[…]
Ridacci la pace,
la pace illesa.“
Il desiderio utopico di riavvolgere le lancette dell’orologio, per riportare il tempo a prima del 6 agosto, non avrebbe cancellato la ferita della guerra dal mondo, né avrebbe restituito le vite di tutte le persone morte dall’inizio della Seconda guerra mondiale fino a quel giorno. Con questi versi Tōge dimostra che la rabbia non conosce ragione e suggerisce implicitamente che, sebbene l’uso della bomba atomica fosse stato un evento unico e talmente surreale da sembrare frutto della fantasia di un folle, esso era stato comunque il risultato della guerra e della violenza umana. Il furore di Preludio si riflette anche in Fiamme, dove la conclusione «tra non molto la storia tenderà un’imboscata a tutti quelli che hanno giocato ad esser Dio» esprime il massimo picco di frustrazione del poeta nei confronti degli Stati Uniti. Il paese che si era arrogato l’autorità divina di creare e usare un’arma che potesse raggiungere una temperatura pari a quella della superficie del sole.
Gli occupanti in Poesie della bomba atomica
È interessante notare come nell’intera raccolta non compaiano mai i termini “Stati Uniti”, “America” o “americano”, nonostante la presenza silenziosa e sinistra degli States pervada l’interezza di Poesie della bomba atomica. È a loro che l’autore si rivolge in Preludio, più che a un’entità divina; è di loro che parla in Quando arriverà quel giorno? quando scrive: «ah, non è stato un incidente, o volere divino. Dopo minuzioso pianificare, con insaziabile ambizione, la prima bomba atomica dell’umanità venne lanciata […]».
In Stagione delle fiamme, Notte e Paesaggio, Tōge menziona i test nucleari effettuati sull’atollo Bikini, ma evita di fare riferimenti diretti agli Stati Uniti. In Colui che scava le tombe e Quando arriverà quel giorno? fa anche riferimento, con una punta di ironia, alle strade e i campi da gioco intitolati al generale MacArthur. La parola che ricorre più frequentemente nei suoi versi per identificare gli occupanti è “straniero”. Gli stessi stranieri ai quali le donne giapponesi furono costrette a svendere i propri corpi in quella «nuova Hiroshima» descritta nella poesia L’ombra.
Come molti dei suoi connazionali, il poeta ribadisce l’inutilità di non uno, ma ben due bombardamenti atomici su un paese già sconfitto, facendo riferimento in particolare, in Quando arriverà quel giorno? allo stato di «servitù senza limite temporale». Tramite questo passaggio, fa un cenno al Trattato di mutua cooperazione e sicurezza (安全保障条約, Anzen Hoshō Jōyaku), considerato da molti un accordo ineguale, e che divenne una delle principali cause scatenanti delle Lotte Anpo (安保闘争, Anpo tōsō). Le rivolte, che si tennero sull’intero territorio nazionale, vennero represse nel sangue dalla polizia e culminarono con l’omicidio dell’attivista universitaria Kanba Michiko (樺美智子, 1937-1960). Anche il poeta attribuisce grande valore al tema della memoria, come evidente in 6 agosto, poesia che si apre e si chiude con l’interrogativo «chi potrebbe mai dimenticarlo?». La processione di corpi nudi con la pelle appesa come stracci rimane impressa nella sua memoria, così come in quella di Hara Tamiki (原民喜, 1905-1951) e di Ōta Yōko (大田洋子 1903/06-1963), gli altri due principali esponenti della genbaku bungaku (原爆文学, “letteratura della bomba atomica”).
Il testamento di Tōge
Questa raccolta non contiene le memorie di un uomo sopraffatto dalla follia o paralizzato dalla perdita. È, piuttosto, l’inoppugnabile convinzione di dover tramandare quel dolore per interrompere il ciclo perpetuo di guerre e di morti. I “piccini” a cui l’autore si rivolge nella sua poesia omonima, non sono solo i bambini di «quella Hiroshima che non offriva ombre o riparo» ma anche, e soprattutto, coloro che continuano a leggere le sue poesie nonostante il susseguirsi delle stagioni, restando folgorati dalla sua maestria e dalla profondità inquietante della sua arte.
Nei sogni del poeta, dopo il completamento di Poesie della bomba atomica, sarebbe dovuto arrivare un poema epico intitolato Hiroshima, che non vide mai la luce a causa della sua prematura scomparsa.
Traduzione italiana delle poesie a cura di Christian Landolfi
Fonte immagine: Amazon