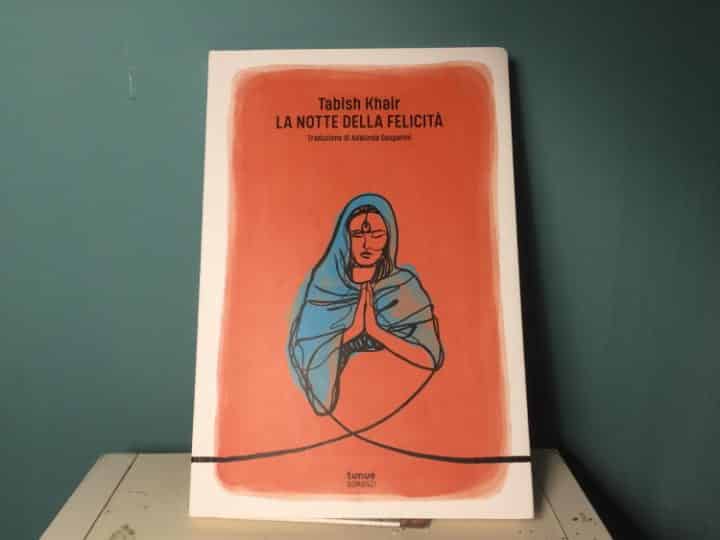“Tutto ciò che sono” è un libro di Ilaria di Roberto, edito da Europa Edizioni le cui tematiche intendono cambiare le regole viziate del mondo maschio.
Sono molte le tematiche che il libro di Ilaria di Roberto affronta in maniera eccezionale. Prime fra tutte, senz’altro il bullismo vissuto tra i banchi di scuola, la violenza fisica perpetuata nel corso degli anni, fino al Revenge porn e al cyberbullismo vissuti più avanti. In una strabiliante denuncia sociale.
Il suo testo ha una doppia voce, esso si rivolge infatti sia a chi è vittima e sia a chi compie violenza. Esso invita le donne a fare gruppo, a stringersi forte, fare una corazzata potente contro la violenza di molti uomini, e l’indifferenza di tanti, che malgrado tutto finisce per non avere genere.
“Lettera alla ragazza con il cappio al collo”, la denuncia sociale di Ilaria di Roberto
Di grande impatto è la “Lettera alla ragazza con il cappio al collo”. In queste pagine, l’autrice si rivolge direttamente a “Miranda Fox”, una giovane ragazza, la cui unica colpa è stata quella di inviare foto sensibili a colui che riteneva fosse la persona più importante della sua vita. Da qui si evince una storia carica di dolore, dove le amicizie si annullano, dove l’amore smette di esistere, e dove le parole emozionanti dell’autrice, accompagnano il lettore fino alla fine, ai piedi di una scena del terrore, dove una giovane donna, decide di farla finita, dissanguata e appesa per il collo. Il dolore e il vuoto, vengono descritti dall’autrice in maniera emozionante, permettendo al lettore di nuotare fino in fondo in una distesa capace di far male, ma di mostrare la vera faccia dell’orrore, a cui molto spesso, centinaia di donne sono costrette ad andare in contro, ogni giorno. Attraverso la sua storia, saranno molte le tematiche affrontate: la bulimia, l’autolesionismo, l’anoressia, le molestie, il Revenge porn, e molto altro.
A fare da contro parte, è “lettera al mio amico maschilista”. Qui l’autrice fa un accorato discorso, invitando il classico maschio a commettere una serie di riflessioni, fino a giungere ad un cambiamento totale di visione e pensiero. Qui l’autrice si dilunga in maniera profonda sulle “pari opportunità”, spingendo le donne a non sentirsi inferiori, e soprattutto ad essere pronte nella denuncia, laddove sia necessario. Sono molte le dediche e gli incoraggiamenti che l’autrice dedica alle donne, in un canto corale, dove le quote rosa sembrano riacquistare più vigore.
Di grande impatto è il discorso su cosa affronta chi decide di denunciare. Le fasi sono lunghe e tortuose, e spesso chi denuncia finisce per essere, agli occhi del popolo, il vero carnefice. La frase “uccidere le donne sembra stia diventando una moda” ne è l’emblema più profondo. La scia di odio, risentimento e cattiveria, scorre sotto gli occhi del lettore, in un fiume di sangue, che giorno dopo giorno, trascina via donne su donne.
Il libro “Tutto ciò che sono”, quindi diviene un viaggio introspettivo, dove l’autrice, racconta la sua storia personale di soprusi e violenze, altresì diventa al tempo stesso, il modo più autentico per raccontare la storia di molte altre. Attraverso la sua storia, l’autrice affronta diversi argomenti, oltre il cyberbullismo, si parlerà anche di catcalling, body shaming e molto altro. Esso però, non è solo un viaggio dentro sé stessa, ma anche un modo per puntare il dito contro una società patriarcale e profondamente maschilista. Tuttavia, l’autrice sembra ritrovare una autentica speranza, nel testo “Scrivimi una canzone”, dove non si è alla ricerca di un principe azzurro perfetto, quanto piuttosto di un uomo capace di abbracciare in maniera tenera, ed insegnare nuovamente la bellezza di essere amati.
Numeri di un fenomeno che fanno paura
Con il testo di Ilaria di Roberto, il lettore si troverà dinanzi dei numeri che fanno paura. Il 59% di chi è vittima di bullismo o Revenge porn pensa assiduamente al suicidio, e il 52% compie atti autolesionistici.
Un libro autentico e crudo, che attraverso una serie di racconti e componimenti sciolti, intende venire in contro a tutte quelle donne dimenticate o messe a tacere. L’autrice racconta una versione inedita di una donna vittima, ovvero tutto ciò che riguarda il suo dolore, le sue riflessioni, i suoi desideri, cercando di abbattere in qualche maniera i cliché sociali, che intendono incasellare una donna in un bel vestito coperto, in una voce fioca, in una vita vissuta tra le mura di casa. Esso diviene portavoce di una denuncia sociale, composto da 377 racconti, poesie, prose, aforismi e pensieri brevi. Un testo che racconta tutto, ma proprio tutto ciò che vive una donna costretta a vivere nell’ingiustizia e nel dolore. Un invito, quindi, quello di aprire il proprio cuore, mettersi a parlare a voce alta, indossare ciò che si vuole, essere felice nella vita scelta.
Un testo, quindi, capace di emozionare, ma di mostrare nella sua nudità totale il lato vizioso e malvagio di un mondo che tiene molte donne “in ostaggio”.
L’Intervista a Ilaria di Roberto, autrice di “Tutto ciò che sono”
Partendo dal titolo, come mai la scelta di un titolo così, se nel testo le esperienze sembrano essere quelle di una moltitudine di donne?
Quando mi domandano la ragione per cui abbia scelto di intitolare il mio libro “Tutto ciò che sono” rispondo sempre che questo lavoro – oltre ad essere il frutto di un passato segnato dalla violenza in ogni sua forma – rappresenta realmente tutto quello che è l’autrice. E lo fa a 360º, senza alcuna inibizione, senza giustificazione, senza chiedere scusa o il permesso, senza sforzarsi di regalare delucidazioni in cambio di comprensione, talvolta sconfinando nei limiti dell’autolesionismo e dell’ironia. Trattasi di un viaggio di natura fortemente introspettiva, definire quest’opera come uno “specchio” sarebbe alquanto riduttivo:
uno specchio ci induce inevitabilmente a pensare a un semplice riflesso, lo stesso contro cui ho combattuto per tutta la mia vita e che ho cercato con tutte le mie forze di cancellare, delimitando la mia identità entro i confini di quelli che fossero i pronostici sociali e di ciò che gli altri si aspettassero da me in quanto donna, vittima, stereotipo, danzatrice, scrittrice, attivista, ragazza oggettivata e criticata per le sue tendenze istrioniche che in definitiva non erano altro che la mia libera espressione identitaria. La mia opera, invece, si impegna, con modalità talvolta sfacciate, a deludere quelle aspettative a cui ho cercato di ottemperare tutta la vita per restituire un nuovo volto ad un’immagine defraudata, violata, marchiata nella sua integrità a causa delle violenze subite – sia online che on-life – e si accinge, in maniera quasi selvaggia, ad irrompere attraverso un mix di rabbia e ironia nelle coscienze e nelle menti, contribuendo a disfare tutti gli stereotipi che, volente o nolente, hanno incoraggiato la cancellazione della mia identità, quasi sempre messa in ombra dall’egemonia patriarcale e dall’efferatezza dei pregiudizi collettivi.
In Italia, lo stupro sembra quasi giustificato, seguendo la solita scia di domande stupide (come eri vestita?), perché ciò sembra essere tollerato?
A dispetto dei grandi passi avanti nella lotta contro gli stereotipi e la violenza di genere, i fatti di cronaca evidenziano quanto le vittime di revenge porn, stupro e femminicidio, siano ancora oggi largamente colpevolizzate per i soprusi subiti. Una delle conseguenze della violenza di genere è giustappunto il processo di responsabilizzazione applicato socialmente alla vittima mediante una serie di giustificazioni, volte ad attenuare il comportamento del carnefice. Secondo la studiosa Karla Mantella, tali processi prendono il nome di VICTIM BLAMING – il cui meccanismo consiste nel ritenere la vittima di un crimine, o di altre sventure, parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto, inducendola ad auto colpevolizzarsi e a subire inevitabilmente lo stigma e la pressione sociale – e SLUT SHAMING, condotta attraverso la quale le donne vengono attaccate per aver trasgredito a dei codici di condotta sessuale adeguati e ammonite per aver manifestato comportamenti o desideri “più sessuali” di quanto la società ritenga accettabile. Il patriarcato percepisce la donna come provocatrice, sexy, sfrontata, appellativi che, già di per sé, celano un giudizio errato e non obbiettivo e finiscono per collocare in un secondo piano la violenza perpetrata dagli uomini. Secondo questa visione paternalistica, la donna deve attenersi a determinate condotte per disinnescare la violenza e assumere, al contrario, degli atteggiamenti conformi ad un codice comportamentale ritenuto socialmente accettabile. Perché alla fine dei conti, la visione dicotomica della donna, risulta sempre essere la stessa: santa/sgualdrina, angelo/diavolo, seria/facile. Qualora non ci si attenga a tali codici di comportamento, vestiario o atteggiamento, si valicherà il confine imposto dalla società ed è qui che la donna – così come la maniera che essa abbia di vivere la propria sessualità – inizierà ad essere stigmatizzata, deumanizzata e giudicata negativamente dall’opinione pubblica. Tali condotte, soventemente applicate dalla società patriarcale, si traducono in un quadro più ampio e complesso, ossia in quella che Margaret Lazarus definì “cultura dello stupro”, un paradigma culturale nel quale le violenze e gli abusi vengono impropriamente edulcorati e normalizzati attraverso l’erronea apposizione della sessualità alla violenza denunciata. Un’identificazione che ci conduce inevitabilmente a considerare “romantici” o “sexy” atteggiamenti oggettivamente violenti e/o abusivi (basti pensare alle molestie da strada, alle palpate indesiderate e talvolta, anche alle forme di violenza socialmente ritenute “più gravi”).
Nel testo affermi di essere femminista perché esiste il maschilismo. Ci racconti meglio il perché e cosa intendi?
Come esplicato nella mia autobiografia, si tratta chiaramente di un principio causa-effetto, la cui incidenza esula completamente dall’automatismo. Essere femminista in una società in cui il rispetto verso le donne sembra non voler essere un fattore intrinseco, richiede sforzo, comprensione, intensa autoanalisi e una quantità non indifferente di Xanax (sorrido mentre dico ciò). Sarebbe fantastico potersi svegliare la mattina senza l’incessante bisogno di convincere gli uomini che la vagina non sia meno importante di un pene. E invece non ci resta altro che spendere – spesso anche disperdere – tutte le nostre energie affinché questa condizione di parità tanto conclamata venga appresa, assimilata e riconosciuta una volta per tutte. Essere femministe è un atto eroico, oggi giorno, così come la conquista della propria autodeterminazione in una società che ci vuole costantemente all’angolo, schiave delle aspettative sociali e delle insicurezze che il patriarcato ci ha introiettato sin da bambine, quando ci veniva “spontaneo” giocare con le bambole, piuttosto che con le macchine o prediligere il rosa al blu.
Come definiresti un attacco di panico, e come si può guarire?
All’interno del mio libro, mi impegno in un susseguirsi vorticoso di immagini, richiami e metafore, a descrivere l’ansia e il panico che seguono un attacco perpetrato in rete. Dietro questo, il chiaro intento di mettere in luce quelli che sono gli aspetti più subdoli della violenza psicologica, il cui cavillo risiede proprio nell’indimostrabilità di quanto si subisce. Come esplicitato nel testo “attacco di panico”, è ciò che io amo definire “l’urlo dell’anima”, il grido straziante di chi sopporta troppo a lungo, il richiamo di chi necessita di esplodere, la resa di chi ha lottato da sempre contro i propri mostri, il più delle volte nel totale silenzio. È il conto da pagare che il tuo corpo ti presenta, dopo un lungo processo di somatizzazione della sofferenza, l’istante in cui riemergono le parole non dette, le emozioni represse, l’ansia placata, il dolore tenuto a bada. È la punizione che il nostro corpo ci infligge per aver messo a dura prova il nostro spirito. A porre rimedio a questo mio mal di vivere è stata senz’altro la psicoterapia, molto spesso impropriamente stigmatizzata. Ma come si dice? In analisi non va chi ha problemi, perché tutti hanno problemi. In analisi va chi ha intenzione di risolverli. Chi ha il coraggio di guardare in faccia i propri mostri, senza sentire la necessità di diventare come loro, in virtù di un eventuale riscatto personale. Ma non ci si può riscattare dal dolore che ci è stato inflitto, infliggendone a nostra volta. Trovo sia indiscutibilmente vacuo tentare di porre rimedio alla propria sofferenza senza prima aver dato adito alla comprensione, all’introspezione e a quell‘empatia che c’eravamo promesse/ i di non provare mai più. È indispensabile che il dolore venga rielaborato, sviscerato e sperimentato sulla nostra pelle prima di leccare le ferite altrui e permettere al soffio delle proprie labbra di tramutarsi in un antidoto. Non si può pretendere di trovare una cura, senza prima aver provato l’impeto della malattia. Non ci si può curare se prima non ci si ammala.
Affermi di essere un ex ancella, cosa significa esserlo, e quando hai capito che era opportuno cambiare?
Mi sono avvicinata al femminismo in concomitanza agli albori della mia battaglia legale, quando ho compreso che quella lotta non fosse solo la mia, ma quella di tante altre donne vittime dei medesimi soprusi. Ho capito di essere femminista quando ho iniziato a riconoscermi, attraverso un arduo percorso di autocoscienza, nelle storie delle altre. Un tempo ero affetta dal cosiddetto “maschilismo interiorizzato”, quel canovaccio di doveri e comportamenti paternalistici che una donna applica automaticamente nella vita di tutti i giorni, perpetrando la cultura patriarcale, esattamente come buona parte degli uomini. Sono stata da sempre “demi-sessuale”, pertanto orientata affettivamente verso rapporti improntati sul sentimento “autentico”: in altre parole, non sono stata mai in grado di concedermi sessualmente ad un uomo nei confronti del quale non vi fosse alcun coinvolgimento emotivo. Questo mi faceva sentire inevitabilmente “speciale”, per alcuni versi anche “migliore” rispetto a chi, invece, sceglieva di percorrere vie diverse, o magari di avere una vita sessuale più emancipata della mia. Non nego che in diverse occasioni abbia anche dato della troia ad un’altra: sulla mia bocca, termini come “pudore”, “decoro”, “dignità” erano all’ordine del giorno. Vivevo di pregiudizi e qualora mi capitasse di vedere foto di donne in abiti succinti, non mi guardavo dal giudicare negativamente chi li indossasse. Ero convinta che l’abito facesse il monaco e costituisse altresì una buona fetta della famigerata “dignità” femminile.
Ritenevo l’aborto un peccato poiché, secondo quello che mi era stato introiettato dalla religione cristiana, trovavo ingiusto decidere della vita di un’altra “persona”. Totalmente inconsapevole che un embrione fosse solo un cumulo di cellule, vivevo nell’assurda ed erronea convinzione che abortire fosse un omicidio. Se vedevo una donna con i capelli corti, la invitavo a farli crescere perché in tal maniera sarebbe risultata “più femminile” agli occhi degli uomini. Mi depilavo per non destare un senso di repulsione nei miei fidanzati. Non facevo altro che esordire con slogan del tipo “siate vere donne!”, riferendomi pressappoco alla capacità imprescindibile femminile di “tenersi l’uomo” assecondando ogni sua richiesta. Vivevo di consensi con la certezza che così facendo sarei riuscita finalmente a trovare l’uomo della mia vita. Come? Annullandomi, chinando il capo, oggettificandomi, dando per veritiera qualunque affermazione uscisse dalle labbra di un qualsivoglia portatore di pene. Una sorta di scendiletto con la vagina, ecco. Amavo la gelosia, il sentirmi perennemente controllata, coartata, dominata, spesso anche umiliata dalla persona che amassi e che credevo nutrisse per me un sentimento autentico. Ritenevo che in un uomo la galanteria dovesse essere d’obbligo: il fatto di vedermi spostare una sedia, aprire la portiera della macchina come se mi fossero mancate le braccia, versare da bere o sentirmi dire “sei solo mia e di nessun altro” mi lusingava da morire. Mi faceva sentire protetta, al sicuro, ben lontana da ogni forma di grossolanità e da gesti privi di sentimento. Mi sentivo a mio agio nel mio status quo di donna repressa, oppressa, svenevole. E questo perché sapevo che, così facendo, nessuno mi avrebbe mai più giudicata negativamente, proprio come accadeva in passato. Devo riconoscere che anche l’assenza di una figura paterna ed un passato segnato dal bullismo e dalla violenza abbiano condizionato negativamente buona parte della mia esistenza. Poi sono cambiata, ho deciso di combattere quando ho provato a manifestare la mia sessualità in maniera anticonvenzionale e non è stata accettata; quando ho visto disintegrare la mia dignità ed il mio essere donna da chi prometteva di amarmi; dopo aver collaudato l’umiliazione davanti a chi mi diceva di cambiarmi d’abito, perché con una minigonna indosso gli uomini mi avrebbero considerato una troia; quando ho sperimentato sulla mia pelle le conseguenze di atteggiamenti paternalistici di cui, involontariamente, mi ero resa portavoce; quando ho capito che la gelosia, il possesso e l’oppressione non hanno nulla a che vedere con l’amore e, soprattutto, quando la cultura machista, conglobata a dovere nel mio animo dai millantatori di questa fallocrazia feconda, mi si è rivoltata contro come un boomerang, riducendo il mio animo in brandelli. All’interno del monologo “Femminista perché” esterno chiaramente quanto il femminismo abbia avuto per me un ruolo salvifico.
Ilaria di Roberto: single, 30 anni, senza figli, ma felice. Quanto secondo te, il giudizio e l’oppressione sociale influisce sulla serenità altrui? In quanti si sentono giudicati per “essere in ritardo” su quella che sembra essere una tabella di marcia obbligata dalla vita? Quando hai smesso di sentirti così?
Parlo da un punto di vista prettamente personale, non egoriferito. Benché io stessa, sovente, fatichi ad accettare di trovarmi in quella porzione di limbo e condizione che la nostra società definirebbe “fuori tempo”, ho sempre cercato di divincolarmi da qualsivoglia forma di aspettativa sociale. Ho 32 anni, sono single, non ho figli e non ho intenzione di averne almeno per i prossimi dieci anni e toh? Al netto delle mie vicissitudini personali, sono disperatamente felice. Chiaramente, mi sento acerba sotto molti punti di vista. Non ho una laurea, non ho neanche la patente, non ho ancora un impiego fisso e sto ancora cercando il mio posto nel mondo. Tuttavia, a dispetto delle innumerevoli vicissitudini, una cosa sono riuscita ad ottenerla e, forse, in questo sono stata molto più precoce di altri: l’amor proprio. Quando mi chiedono perché – in contrasto con quanto generalmente ci si aspetta una donna di trent’anni – non mi prodighi nella ricerca di un uomo e quindi della celeberrima “sistemazione”, la risposta è sempre la stessa: «I have no economic independence». Chiaramente, a molte/i potrebbe sfuggire il nesso logico tra la scelta di condividere un percorso con qualcuno e l’ambizione di essere finanziariamente e professionalmente di successo, talvolta persino sopravanzando gli altri. Vi dirò che il nesso risiede proprio nella sopravvivenza, o meglio, in quel “mantenere” sé stessi ed altre persone, grazie ai mezzi di sussistenza che la società mette a nostra disposizione. Fin dai tempi più remoti, la ricerca smodata di siffatti mezzi è stata relegata all’uomo, per secoli identificato come colui che «portava a casa la pagnotta». Ed era questa la normalità, poiché le donne erano destinate ad occuparsi di altre questioni, in primo luogo il lavoro domestico. Ma la sopravvivenza – in particolare per le donne – implica anche lo smantellamento di pregiudizi e preconcetti in una società il cui dominio economico, culturale, sociale e lavorativo è sostanzialmente relegato agli uomini, a notevole scapito del nostro genere.
Per rompere questa serie di pregiudizi è essenziale recidere le catene dell’oppressione, divergendo dalla propria zona di comfort di “tenuta” per implementare il meccanismo di autorealizzazione personale. Dopo anni di studio e molteplici disavventure con il “sesso forte” ho appreso che è impossibile sottrarsi ai meccanismi fallocentrici della coercizione quando la tua autodeterminazione non è totalmente consolidata. Immaginate di essere donne in carriera o comunque lavoratrici autonome, indipendenti, sia emozionalmente che economicamente. Suppongo che non sarebbe un’impresa utopistica decidere di andare a cena fuori, concedersi una bottiglia di champagne e brindare alla vostra autodeterminazione, accompagnando il tutto con un succulento piatta di aragoste alla catalana, servite su un tavolo adorno di candele e un bel bouquet di rose rosse.
In tal caso, se il giorno seguente un uomo decidesse di invitarci a cena, ciò non costituirebbe motivo di meraviglia, né di sbigottimento, considerando che sullo stomaco avremmo ancora i rimasugli dello sfizioso pesce della sera prima, profumosamente pagato con il NOSTRO stipendio. Ora, è assodato che buona parte degli uomini cerchi di barattare una minuziosa razione della propria galanteria con la nostra libertà di scelta e che nove volte su dieci, il mezzo di scambio sia rappresentato dalla figa. Ergo, ogni volta che un oppressore con aria disincantata mi domanderà «Perché non vuoi uscire con me?» risponderò «Perché se non posso pagare alla romana, preferisco tenermi la fagiana».
Ilaria di Roberto, la scrittura che si fa denuncia
Dici di essere nata per l’inchiostro, quando hai iniziato a scrivere, e quando questo ha influito sulla tua vita?
Al di là dell’irrilevanza del fatto, tengo a specificare che non sono diventata “scrittrice” in ragione delle mie innumerevoli vicissitudini, ma in virtù di una passione che affonda le sue radici nell’amore incondizionato – trasmessomi da mia madre – verso tutto ciò che è cultura e in particolar modo, per la scrittura. Di fatto, è proprio grazie al suo apporto che, all’età di tre anni, iniziai ad apprendere i primi rudimenti di grammatica, a leggere e a scrivere, dando voce agli innumerevoli pensieri che sovente affollavano la mia mente. Quello per la scrittura – insieme alla danza, alla recitazione e al canto – è un amore sbocciato in tenera età, progredito nel contesto di un trascorso travagliato, permeato dall’eredità emotiva di un padre assente, dal bullismo fisico e verbale perpetrato tra i banchi di scuola e dagli strascichi dell’anoressia nervosa. Tuttavia, considerando le ricorrenti accuse di ricercata notorietà avanzate in questi anni, è sempre bene sottolineare che, in realtà, la mia propensione alle arti nasce ancor prima del clamore mediatico relativo alle mie vicissitudini. Sono nata come scrittrice prima ancora che l’opinione pubblica mi attribuisse l’ingrato titolo di “vittima di Revenge Porn”. Tradotto in parole povere, non sono diventata una scrittrice perché vittima di Revenge Porn, ma ho raccontato il Revenge Porn attraverso la scrittura, utilizzandola come mezzo e veicolo di terapia per il contrasto del fenomeno. Tutto questo, nel tentativo di conferire al mio dolore un ruolo funzionale per me e tante altre.
Al ché, la sera che amo definire “delle sabbie mobili” ho deciso di comporre un saggio nel quale ripercorro il mio vissuto personale, intitolato “Tutto ciò che sono”, da poco premiato “Libro dell’anno 2022” dall’associazione Area Cultura di Roma e che il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sarà presentato presso la Ecate Caffè Libreria di Milano.
Al di là di ogni possibile percezione di presunzione e autoreferenzialità, potrete comprendere quanto quest’opera rappresenti per me un risarcimento, un riscatto, la mia rivalsa, nonché l’unica e sola possibilità di tornare in carreggiata e riprendere in mano la mia vita, considerando che, da qualche tempo, è anche diventata materiale didattico in diverse scuole d’Italia. Nelle mie opere, cerco di annientare ogni possibile divisione tra me e il lettore: non più “io contro di te”, bensì “io insieme a te”. Mettersi nei panni degli altri, per quanto dispendioso sia, è la cosa più bella del mondo. Tutti dovremmo renderci conto che le parole, così come la scrittura, possono essere una potente, potentissima arma. Sta a noi decidere se utilizzarle come difesa o tramutarle nell’ennesimo strumento di distruzione. Saranno le nostre scelte a determinarne il potere.
Nel testo sono molte le parti dedicate alla riflessione, meno quelle che riguardano la tua vita. Il testo è volutamente meno biografico e più rivolto “agli altri”? Perché?
Sai, in molte occasioni il mio libro è stato definito autocelebrativo o addirittura il prodotto di un indottrinamento “misandrico” scaturito da solo Dio sa cosa. In realtà non mi sono mai erta a paladina, né espletato il consueto distacco tra scrittore e lettore, visto che nel libro mi rivolgo a tutte le donne come solidali sorelle, senza alcun grado di separazione. Ho deciso semplicemente di mettere la mia esperienza al servizio di tutte, senza ricorrere alla necessità di innalzarmi in cattedra, esprimendomi dall’alto del mio dolore al basso di chi “non può capire perché non gli è successo”. Questi sono snobismi e pregiudizi da cui ho cercato rigorosamente di prendere le distanze e di combattere con rabbia e passione. Non sono una maestra di vita, ma una donna che ha deciso deliberatamente, senza alcun secondo fine, di donare il mio vissuto per suscitare una nuova consapevolezza in chi ancora non l’ha raggiunta e soffre nella sua condizione femminile senza comprenderne le ragioni.
Quali sono le sensazioni che pervadono la mente di una donna, quando essa diviene vittima di Revenge porn? Come si potrebbe fare per scongiurare tale fenomeno?
Tra i commenti più abituali rispetto a ciò che concerne il reato di Revenge Porn abbiamo: “Le donne potrebbero evitare di mandare foto a cani e porci” – o ancora – “Le donne dovrebbero avere buonsenso” e addirittura “Il Revenge Porn è una scelta sessuale, le vittime sapevano a cosa sarebbero andate incontro, inviando i propri nudes”, materiale che poi, in virtù di quella vendetta tanto osannata dal popolo dei redpillati e degli incel, finisce per essere sbandierato illecitamente su qualche sito porno per mano di ex fidanzati incapaci di accettare la fine di una relazione.
Mi sembra coerente, a tal proposito, parlare della mia esperienza personale. Sono stata vittima di Revenge Porn. Due volte. “Due volte troia” dirà di qualcuno, mentre i più clementi penseranno “Due volte stupida”. Mai negato. Al contrario, nego con estrema lena la forma mentis del “revenge porn = scelta sessuale”, avvalorata dal clamore dell’esercito dei Redpill & Incel Company. Il Revenge Porn non lo scegli. È lui a scegliere te. Ti sceglie per la capacità che hai di vedere il buono anche in coloro che il buono non sanno neanche cosa sia. Ti sceglie per i tuoi vuoti mai sanati, per quel bisogno incondizionato d’amore che non sembra ancora voler far parte della tua vita.
Ti sceglie per la tua mancanza di autostima, per la tua fragilità, per l’incapacità che hai di dire “No!” davanti a proposte un po’ troppo azzardate, convinta che grazie all’asservimento, riuscirai ad ottenere quell’affetto che ti è stato tolto.
Ti sceglie perché vorresti aprire gli occhi, essere sfiduciata, alzare le barriere e chiuderti a riccio dinanzi al primo campanello dall’allarme, ma non ce la fai: le mortadelle che hai sugli occhi ti stanno troppo bene. La sola cosa che ti tiene in vita è l’erronea convinzione che proprio grazie a quegli sforzi sarai amata perché tutto ha un prezzo e nessuno ti dà niente per niente. Tocca a te fare tutto. Tocca a te spogliarti. Tocca a te mostrare un seno o una vulva. Tocca a te assumere le posizioni più disparate pur di compiacere il bisogno sessuale della persona dalla quale credi di ricevere amore. Tocca sempre a te. E no, non mi piaceva. Non mi eccitava nemmeno, tutt’altro: più mi veniva chiesto di cimentarmi in video “estremi”, più sentivo volare via una parte della mia dignità, una volta premuto il tasto INVIO. Chi lo avrebbe mai detto che a distanza di qualche settimana, quelle foto sarebbero finite sugli schermi di qualche microcefalo, bello e pronto per la pippa quotidiana? Si dà il caso che stavolta la foto con la quale avevano intenzione di svuotare il loro testicoli non fosse quella della solita modella vogliosa, buttata sulla prima pagina di una qualche rivista “da gabinetto”. La foto, stavolta, era la mia. Decidi di dare di nuovo la tua fiducia ad un’altra persona, stavolta reale, con la quale condividi gli istanti più magici della tua vita e insieme a cui sperimenti per la prima volta la bellezza di un rapporto “carnale”. A lui racconti tutto, anche di essere stata vittima di una delle peggiori piaghe sociali di tutti i tempi: il revenge porn. Dopo un’assidua frequentazione ed una serie infinita di “not all men”, ‘‘io non sono come gli altri”, “di me puoi fidarti, non ti farò mai del male”, nel corso di uno dei vostri momenti intimi, decide di fotografarti senza il tuo consenso. Come ti accorgi dell’atto, gli fai giurare e spergiurare di non diffondere le foto, visto che sei già caduta una volta nelle trappole del Web. E si sa, una volta è più che sufficiente. “Metto il blocco, le ho solo io” promise. Peccato che i suoi amici, a distanza di un anno siano venuti a ridirti di aver visto quelle foto e che, la persona che amavi, si fosse prestata a questo ignobile atto, farcendo il tutto con un goliardico “GUARDATE CON CHI SONO STATO IERI! AHAHAHAH. Sei vittima per la terza volta quando decidi di andare a denunciare e le autorità ti domandano la ragione per la quale, ad una scrittrice come te, sia passato per l’anticamera l’idea di farsi fotografare nuda. È appurato, dopotutto, che il sesso sia una prerogativa di tutti, tranne che delle scrittrici. Lo sei la quarta volta quando anche gli amici più stretti ti abbandonano.
Lo sei la quinta quando perdi il saluto delle persone che un tempo fingevano di stimarti. Persone che oggi, invece, fingono di non conoscerti. Lo sei la sesta quando perdi il lavoro a causa del danno alla tua immagine professionale, o almeno così lo chiamano: devo riconoscere sia abbastanza riduttivo, visto che oltre all’immagine è stata danneggiata la mia anima, la mia integrità fisica e mentale e ben due anni della mia vita. Potrei continuare all’infinito, cercando un altro miliardo di ragioni per convincervi che, in realtà, di piacere ne abbia provato ben poco. Tuttavia, so che ad ogni modo, non servirà perché la conclusione sarà sempre la stessa: “Donne, evitate di farvi le foto da troie”. Non ci sono gonne, droghe, alcol, foto o video in grado di attenuare, edulcorare o giustificare anche solo lontanamente l’efferatezza di un crimine. Parimenti, non esistono divagazioni come “Te la sei cercata!”, “Hai voluto la bicicletta? Ora pedala!”, “Hai voluto fare la tr0ia? Ora piangi!”, “Chi semina vento raccoglie tempesta!” (mi sono state dette tutte, giuro) che possano rendere chi li pronuncia, meno complici di siffatti crimini.
Hai asserito di aver tentato due volte il suicidio. Cosa consiglieresti a chi pensa che la morte sia l’unica soluzione?
Tra le opere inerenti al tema del suicidio abbiamo ‘Lettera alla ragazza con il cappio al collo”, un’opera parzialmente autobiografica che ha avuto già un riconoscimento da “Area Cultura” nella sezione “Il racconto dell’anno 2020”. L’opera affronta da vicino tematiche di violenza, abusi, stupri, revenge porn, autolesionismo, cyberbullismo e infine anche il suicidio. Di fatto, nell’opera, mi rivolgo ad una ragazza che si è tolta la vita a causa degli abusi subiti nel corso della vita. È una sorta di denuncia sociale che credo possa diventare manifesto di prevenzione, un intreccio tra la mia vicenda personale e quella della giovane Amanda Todd suicidatasi a causa del Cyberbullismo. A tutte coloro che hanno vissuto e stanno vivendo le mie stesse difficoltà, mi sento in dovere di dire “amatevi! e fate in modo che questo amore diventi così forte da non permettervi mai di rifiutare un dono tanto importante come quello della vita.
In cosa ti hanno cambiato le esperienze di vita difficili? Quali sono le cose che facevi prima che adesso non fai più?
Mi sono ritrovata isolata dalla comunità e minacciata dai miei stessi concittadini con scritte sui muri, auguri di morte, aggressioni, tutti episodi all’ordine del giorno. Oggi vivo praticamente barricata in casa assieme a mia madre, in un quartiere difficile. Ogni giorno il mio paese mi denigra, mi sento emarginata. Oltre a ciò, non è stato ancora preso alcun provvedimento contro chi mi sta distruggendo la vita. A fare male di più è la sensazione di avere tutti contro e di sentirsi abbandonata anche da chi avrebbe il dovere di proteggermi. Le autorità competenti, dopo aver sentito la mia storia, mi guardano con scetticismo. Senza parlare dei commenti offensivi che ricevo giornalmente da tutte quelli che credono stia solo cercando di ottenere un pizzico di notorietà. Non ho mai visto così tanta cattiveria. Non nego che tutto questo mi faccia stare ancora male. Si sa che in un contesto di poco più di diecimila abitanti, i pettegolezzi siano all’ordine del giorno, ma a causa di questa situazione, molta gente del posto mi ha tolto il saluto, altri addirittura mi hanno accusata di stregoneria per via della setta che in un secondo momento mi ha irretita, quei pochi che mi salutano lo fanno di nascosto per non farsi vedere da altri. La Scorsa estate mi è stata fatta una scritta sul muro dell’androne “Ilaria sei una pornostar, devi morire” seguita dall’inserimento di escrementi, urina, petardi e profilattici nella mia cassetta delle lettere. Sono stata picchiata, minacciata, bollata come poco di buono e accusata di utilizzare la mia vicenda personale come pretesto per sbarcare il lunario. Molti di loro mi intralciavano il passaggio con la pretesa, avendo visto le mie foto diffuse sui siti porno, di portarmi al letto pagandomi. Sono stata minacciata di morte mentre facevo spesa, quando andavo a buttare l’immondizia o anche solo dopo aver preso una boccata d’aria fuori in balcone. Ho dovuto smettere di frequentare i corsi di ballo, la mia più grande passione. Sono impossibilitata dal trascorrere il weekend fuori per non lasciare la mia famiglia sola in questo quartiere di persone senza scrupoli. Mi sono ritrovata addirittura sul punto di commettere una follia. Non avrei mai pensato di arrivare a tanto.
Ilaria di Roberto, perché leggere il tuo libro?
Innanzitutto andrebbe letto perché è un messaggio scomodo. In una società conformista come la nostra e in cui veniamo inevitabilmente addestrati ad omologarci è importante provare ad essere la voce fuori dal coro. Credo che il mio sia uno dei pochi libri che affronta da vicino ciò che nel 1875, la nota regista Margaret Lazarus denominò “cultura dello stupro”, quel bagaglio di norme patriarcali, codici comportamentali e retaggi trasmessi dai media, dalla società e sovente anche dalle istituzioni che minimizzano e incoraggiano la violenza maschile, declinandola ad un semplice fatto ordinario. Tale meccanismo viene implementato da quella che gli studi di genere definiscono “vittimizzazione secondaria” il cui processo consiste sostanzialmente nello spostare l’attenzione dall’autore del misfatto alla vittima che conseguentemente, sarà ritenuta parzialmente o totalmente responsabile della violenza subita. Questo argomento viene affrontato all’interno del monologo “Com’eri vestita?”, la domanda che sovente viene rivolta a tutte le vittime di stupro. In secondo luogo, perché non è il classico libro che ci si aspetta da una vittima di violenza. È una denuncia sociale che trasuda intensità, commuove, tocca corde dolenti, talvolta anche in maniera selvaggia e persuasiva. Ma non è una lettura pesante, tutt’altro: spesso provo ad esercitare l’ironia, scherzando sull’eterno scontro tra maschi e femmine e divertendomi ad asfaltare il completo campionario di incel, misogini con cui ogni ragazza ha a che fare quotidianamente.
Infine, perché non si limita ad essere un messaggio di sensibilizzazione per le vittime, ma uno schiaffo in faccia per i carnefici che magari, leggendolo, si riconosceranno nella figura del “mostro” evitando di perpetrare determinate condotte e violenze.
Immagine in evidenza per l’intervista a Ilaria di Roberto: Ufficio Stampa