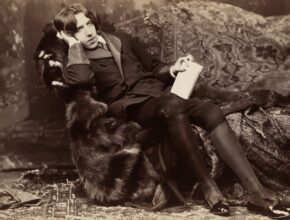La Rivoluzione Ungherese del 1956: storia, cause e conseguenze | Riassunto
Il 2022 ha segnato il sessantaseiesimo anniversario della Rivoluzione Ungherese del 1956, un evento cruciale nella storia europea del XX secolo. Ancora oggi è una questione molto dibattuta e discussa tra storici e politici, sia per il ruolo che ha avuto, sia per gli obiettivi che i rivoluzionari proponevano. La Rivoluzione Ungherese rappresenta un capitolo fondamentale della storia europea del Novecento, un evento tragico e complesso che ancora oggi suscita dibattiti e riflessioni. Il 1956 ungherese ha racchiuso al suo interno le contraddizioni di un continente che, appena uscito da due guerre mondiali, si è subito immerso in una lotta ideologica senza esclusione di colpi. La rivolta, scoppiata il 23 ottobre e repressa nel sangue dall’intervento sovietico il 4 novembre dello stesso anno, fu un grido di libertà e di autodeterminazione da parte del popolo ungherese, oppresso da un regime totalitario e stalinista. Per questo motivo la rivoluzione è stata interpretata in vari modi:
- come movimento nazionale per l’indipendenza;
- come rivolta operaia e operaista;
- come insurrezione anticomunista;
- come movimento per un socialismo democratico.
In questo articolo si analizzano le cause, gli eventi e le conseguenze di quella che è passata alla storia come la Rivoluzione Ungherese del 1956.
Il contesto storico: l’Ungheria nel secondo dopoguerra
Per comprendere appieno gli eventi del 1956, è necessario fare un passo indietro e analizzare il contesto storico in cui essi maturarono. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Ungheria, in virtù degli accordi di Yalta, entrò nella sfera d’influenza sovietica.
Dalla democrazia al regime di Rákosi: 1945-1948
Tra il 1945 e il 1948, l’Ungheria vive una breve parentesi democratica. Nel dopoguerra, la costruzione del socialismo ungherese procede molto difficilmente, tanto è vero che alle elezioni del 1945 il partito comunista è appena terzo (quindi uno dei partiti più deboli per quanto riguarda l’Europa orientale). Il leader stalinista Mátyás Rákosi, a capo del Partito dei Lavoratori Ungheresi inizia un tenace lavoro di conquista del potere e in meno di tre anni riesce a neutralizzare le opposizioni e a creare un regime totalitario, allineato alle direttive di Mosca.
Il regime di Rákosi: culto della personalità e crisi economica
Gli anni del regime di Rákosi (1948-1953) sono contrassegnati dal culto della personalità del leader, da un regime di terrore instaurato dalla polizia politica (la famigerata ÁVH), dalle requisizioni forzate nelle campagne, da una forte repressione politica e da una profonda crisi economica, dovuta anche alle esose riparazioni di guerra imposte all’Ungheria dall’URSS. Il regime di Rákosi è, a tutti gli effetti, una dittatura di stampo stalinista.
La destalinizzazione e il “nuovo corso” di Imre Nagy
La morte di Stalin, nel marzo del 1953, apre a nuovi scenari a livello internazionale. Anche l’Ungheria risente di questo cambiamento: la leadership sovietica, guidata da Nikita Krusciov, avvia infatti un processo di destalinizzazione, che avrà il suo culmine nel XX Congresso del PCUS nel febbraio del 1956, durante il quale Krusciov denuncerà i crimini di Stalin.
La leadership di Imre Nagy: 1953-1955
In Ungheria l’ala riformista del partito comunista trova terreno grazie alla nuova leadership di Mosca: Imre Nagy diventa primo ministro nel 1953 e apre una nuova fase che è contrassegnata dal rallentamento delle misure contro i contadini, dal rilascio dei prigionieri politici e dalla stabilizzazione della situazione economica. Nagy inaugura un “nuovo corso” in politica, allentando la presa del regime sulla società e sull’economia ungherese.
Il ritorno degli stalinisti e il malcontento popolare
Questo nuovo corso, purtroppo, dura poco perché nel 1955 gli stalinisti in Ungheria riprendono forza e potere riuscendo a mettere ai margini Nagy, anche a causa di manovre orchestrate dallo stesso Rákosi. Il ritorno al potere della cerchia di Rákosi, e in particolare di Ernő Gerő (leader comunista dell’Ungheria), viene accolto con grande preoccupazione e malcontento dalla popolazione ungherese, che aveva sperato in un futuro di maggiore libertà e benessere.
Lo scoppio della Rivoluzione Ungherese del 1956
Il malcontento popolare, unito alle speranze suscitate dalla rivolta di Poznań in Polonia (giugno 1956) e all’eco delle critiche al regime stalinista che filtravano attraverso i media, tra cui Radio Free Europe, creano un clima di crescente tensione in Ungheria. La situazione precipita nell’autunno del 1956.
Le proteste studentesche del 23 ottobre 1956
Il 23 ottobre del 1956 circa 3000 studenti – prima a Szeged, successivamente a Budapest (all’Università di tecnologia e economica) – si sono riuniti in associazioni, sono scesi in piazza in segno di solidarietà con gli studenti polacchi di Poznań, e hanno manifestato contro il regime comunista del segretario, generale e primo ministro polacco József Cyrankiewicz e, più in generale, contro la politica di sovietizzazione imposta all’Ungheria.
La rivolta popolare e le richieste dei manifestanti
Al corteo pacifico degli studenti inaspettatamente (alla fine del loro turno di lavoro) si sono aggiunti gli operai, e la protesta si è trasformata rapidamente in una vera e propria rivolta popolare. I manifestanti chiedevano a gran voce la fine della dittatura di Mátyás Rákosi, l’allontanamento dalla Polonia delle truppe sovietiche, libere elezioni, libertà di stampa e di associazione, e il ritorno al potere di Imre Nagy. In particolare, chiedevano il ritiro delle truppe sovietiche dal territorio ungherese, come previsto dal Patto di Varsavia.
Il governo di coalizione di Imre Nagy e l’intervento sovietico
Sotto la pressione della piazza, il governo ungherese cede. Rákosi viene destituito e Imre Nagy torna al potere come primo ministro, il 24 ottobre 1956. Iniziano a sorgere i primi consigli operai e gruppi rivoluzionari; la ÁVH, la polizia odiata, viene sciolta e le truppe sovietiche si ritirano; nasce così un governo di coalizione guidato da “zio Imre”, ossia Imre Nagy. Il 1° novembre, Nagy proclama la neutralità ungherese e l’uscita dal Patto di Varsavia, sperando di ottenere il sostegno delle potenze occidentali.
I consigli operai e la caduta del regime
In tutto il paese si formano consigli operai che assumono il controllo delle fabbriche e delle amministrazioni locali. Il regime di Rákosi e Gerő collassa rapidamente sotto i colpi della rivolta popolare.
L’operazione “Turbine” e la repressione sovietica
La risposta sovietica non si fa attendere. Il 4 novembre l’Armata Rossa, con circa 100.000 uomini e 3000 carri armati, in un’operazione denominata “Turbine”, coordinata direttamente dal leader sovietico Nikita Krusciov e da Mikhail Suslov, capo ideologo del PCUS, invade l’Ungheria e reprime nel sangue la rivoluzione. I combattimenti sono feroci, soprattutto a Budapest, ma la resistenza ungherese viene sopraffatta dalla superiorità militare sovietica. La rivolta affoga nel sangue: i morti sono 2.700 e quasi 250.000 i feriti. Circa 200.000 ungheresi decidono di abbandonare per sempre il loro paese, dando vita a uno dei più grandi esodi della storia europea del XX secolo.
Le conseguenze della Rivoluzione Ungherese del 1956
La repressione della Rivoluzione Ungherese ebbe conseguenze drammatiche per l’Ungheria e per l’intero blocco orientale. Imre Nagy venne arrestato, processato e giustiziato nel 1958. Al suo posto, i sovietici insediarono un nuovo governo guidato da János Kádár, fedele a Mosca. In Ungheria iniziò una nuova fase di repressione politica, con migliaia di arresti ed esecuzioni. La Rivoluzione Ungherese del 1956 dimostrò chiaramente i limiti della destalinizzazione e la ferma volontà dell’URSS di mantenere il controllo sui paesi satelliti, come verrà poi ribadito con la repressione della Primavera di Praga nel 1968 e con la teorizzazione della dottrina Brežnev sulla sovranità limitata. La Guerra Fredda e la Cortina di Ferro dividono ancora l’Europa, e la speranza di libertà e democrazia del popolo ungherese è stata brutalmente soffocata. Solo molti anni dopo, con la caduta del muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’Ungheria potrà finalmente riconquistare la propria indipendenza e intraprendere la strada della democrazia. La Rivoluzione del 1956, con il suo carico di speranze e di lutti, rimane una ferita aperta nella memoria storica ungherese, ma anche un simbolo di coraggio e di resistenza contro l’oppressione, che avrebbe ispirato i movimenti di liberazione dell’Europa orientale, tra cui Solidarność in Polonia.
Fonte immagine: Wikipedia