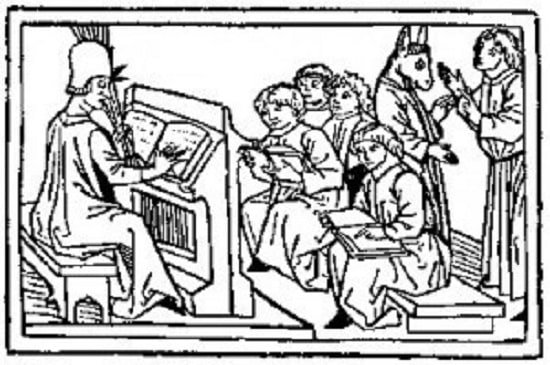La democrazia moderna, così come l’abbiamo conosciuta fino alla fine del XX secolo, è giunta al termine: ora stiamo entrando in una nuova fase storica. «Mentre i cittadini di questa fine di secolo cercano nella nebbia globale che li avvolge la strada per avanzare nel terzo millennio, tutto ciò che sanno con certezza è che un’epoca della storia è finita. La loro conoscenza non va oltre». In tal modo, Eric J. Hobsbawm, importante storico marxista inglese, termina il suo capolavoro Il secolo breve.
Secondo Hobsbawm, il XX secolo si conclude con il collasso dell’Unione Sovietica, segnando così la fine del socialismo europeo. Questo sconvolgimento storico «ha prodotto incertezza politica, instabilità, caos e guerra civile su un’area enorme del pianeta». L’intera umanità stava dirigendosi verso un’epoca di “caos sistemico” e di crescente “disordine globale”.
Nonostante autori liberali avessero acclamato il trionfo del modello occidentale e, di conseguenza, la fine della storia, il nostro continente assaporava un progressivo spostamento a destra dell’asse politico, un lento deterioramento delle conquiste delle classi lavoratrici e di un ordine mondiale sempre più instabile. Nel marasma generale, però, c’era una certezza: la democrazia moderna era ormai giunta al suo termine. Ci trovavamo progressivamente trasportati in una nuova forma di democrazia, una “democrazia postmoderna”.
La nascita della democrazia moderna
La democrazia moderna nasce da una ridefinizione del concetto di “rivoluzione”. Esso, in generale, ha sempre indicato il giro completo di un corpo intorno ad un altro, in modo che ritorni al punto di partenza. Pertanto, il cambiamento era previsto, ma considerato anormale.
L’evento spartiacque capace di associare al termine rivoluzione il significato che tutti noi oggi conosciamo è la Rivoluzione francese. Dal punto di vista storico, la Rivoluzione francese comporta enormi sviluppi in direzione della democrazia moderna: 1) la normalità del cambiamento, 2) il concetto di sovranità, 3) il concetto di popolo, 4) distinzione tra destra e sinistra.
Tali aspetti sono intimamente legati all’ingresso nella storia di gruppi che, identificandosi nella maggioranza di una nazione, reclamano i propri diritti politici, mobilitati da una convinzione: la sovranità appartiene al popolo.
La lotta al suffragio
Secondo Domenico Losurdo, come scritto nel suo fondamentale libro Democrazia o Bonapartismo, un elemento cruciale per la democrazia moderna è la lotta al suffragio: una lotta, specifica l’autore, ancora non del tutto conclusa. Questo processo, avviato dalla Rivoluzione francese, ha segnato l’inizio di una fase di riconoscimento politico per gruppi di individui precedentemente esclusi dai diritti civili e politici.
Nonostante l’instaurazione di una geo-cultura che si basava sulla normalità del cambiamento e sulla sovranità del popolo, la storia ha seguito un corso tutt’altro che lineare, caratterizzato dall’alternarsi di rivendicazioni popolari, misure emancipatore e operazioni di de-emancipazione. In altre parole, in questa fase storica si procede per mezzo dell’avvicendamento di fasi di cambiamento continuo e fasi di cambiamento discontinuo.
Non a caso, Losurdo riconosce tre tappe fondamentali per la democrazia moderna nella lotta al suffragio:
- il 10 settembre del 1792, quando i sanculotti prendono il palazzo delle Tuileries;
- gli sconvolgimenti rivoluzionari del 1848;
- gli sconvolgimenti rivoluzionari della Russia nel 1917.
Nelle prime due tappe, le piazze popolari e plebee rivendicano il suffragio universale (maschile). Naturalmente, si scontrano con una borghesia liberale pronta a schiacciare questa lotta in nome della loro superiorità.
La terza tappa, la rivoluzione bolscevica, è però fondamentale nell’estensione del suffragio, non solo agli uomini, ma anche alle donne. Losurdo afferma: «Il conseguimento di questo importante obiettivo ad opera delle donne non può essere compreso senza tener presente da una parte la loro massiccia immissione nel processo produttivo nel corso della prima guerra mondiale e dall’altra l’influenza profonda degli sconvolgimenti verificatisi in Russia».
De-emancipazione in guerra
D’altro canto, i pensatori liberali avevano più volte espresso la loro contrarietà nell’espansione del suffragio ai subalterni: la rappresentanza politica non può non essere monopolio dei proprietari. Quando le tensioni tra le grandi potenze avrebbero portato alla Grande Guerra, le classi dominanti in Europa hanno sfruttato questo processo di emancipazione dei subalterni per “creare cittadini”, pronti a morire per la propria patria. Nel 1914 gli appelli dei partiti marxisti ad un’unità internazionale delle classi operaie si persero nel vento ai primi squilli di tromba. Gli operai di tutto il mondo si trovarono a combattere tra loro, per difendere la propria nazione.
Non solo, era necessaria un’espansione materiale delle risorse, continuando ad estendere i propri imperi. I processi di emancipazione, dovuti dalla lotta delle classi popolari e dei subalterni, sono contrastati da processi di de-emancipazione messi in atto dalle classi dominanti.
Ecco che vediamo che in un paese come l’Italia le «classi dominanti si riconciliano con le classi popolari, ormai considerate partecipi della civiltà e quindi meritevoli di essere ammesse alla cittadinanza politica, ecco che la razzializzazione dei barbari collocati al di fuori della metropoli capitalistica si sviluppa fino al punto da stimolare contro di loro una guerra coloniale spietata e di sterminio che comporta il massacro di famiglie intere, compresi bambini e donne».
La lotta al riconoscimento politico delle classi subalterne nella metropoli aveva avuto i suoi effetti, riuscendo quindi a garantire maggiori diritti politici. La borghesia , che precedentemente razzializzava i subalterni ed i poveri, reagiva con una nuova razzializzazione, adesso diretta verso i popoli africani, definiti barbari ed inferiori.
Nonostante queste misure de-emancipative, la presenza del socialismo in Europa ha contribuito ad una redistribuzione del potere dall’alto verso il basso. La democrazia moderna stava prendendo forma sulla base di una lotta esercitata su una direzione ascendente, concretizzatosi nella lotta di classe.
Il neoliberismo e la transizione dalla democrazia moderna a quella postmoderna
Nei primi anni Settanta i neoliberali erano esclusi dal dibattito pubblico, troppo estremisti per poter avere un ruolo politico definito. In un clima di crescente crisi economica, recessione, frustrazione e paura, i governi guadagnavano tempo e applicavano le ormai obsolete ricette keynesiane. Fino al 1974, Il premio Nobel era stato conferito a economisti che non teorizzavano la politica di laissez-faire. Qualcosa però stava cambiando: nel 1976 Milton Friedman, figura di riferimento per i politici neoliberali, vinse il premio Nobel per l’economia. Cinque anni dopo, nel 1981, Ronald Reagan divenne presidente degli Stati Uniti. Ex divo del cinema, Reagan fondò la sua politica su una convinzione determinante: «Lo stato non è la soluzione, ma il problema».
L’autore Gary Gerstle in Ascesa e declino dell’ordine neoliberale scrive: «ricchi finanziatori dai saldi convincimenti neoliberali si riunirono tra loro e con candidati a cui erano disposti a donare milioni. Istituirono inoltre think tank ben foraggiati con l’incarico di sviluppare il più rapidamente possibile un forte impulso di policy making. In Ronald Reagan scoprirono un candidato in grado di portare il loro messaggio al popolo americano, con quel tocco popolare capace di eguagliare il fascino di Franklin Delano Roosevelt. Trascinato alla presidenza nel 1980 dagli elettori che aveva gradualmente sottratto ai democratici (bianchi del Sud e bianchi urbani nel Nord), Reagan cominciò ad applicare le sue idee neoliberali alla vita americana su più fronti: deregolò l’economia; privò lo Stato di poteri e risorse; riformò i tribunali e la loro giurisprudenza; stabilì nuove regole per “liberare” il dibattito politico dalla morsa dell’establishment e dei media che presumeva favorevoli al New Deal».
La democrazia moderna stava inerpicandosi nella direzione del progressivo declino: i ricchi, i proprietari, iniziano ad avvertire la regolamentazione e i sistemi di redistribuzione della ricchezza dovuta al Welfare State, come un vero e proprio costo da sopprimere; tutte le conquiste delle classi operaie e dei gruppi subalterni, organizzati in partiti comunisti, erano diventati un fastidio insopportabile per le classi dirigenti, che desideravano eliminarle ad ogni costo.
La democrazia moderna entra in crisi a partire dagli anni ’80. Il collasso dell’Unione Sovietica e la conseguente fine del socialismo in Europa, ha comportato l’ingresso in una nuova fase per la democrazia. Di che fase stiamo parlando?
Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo ancora rifarci all’autore Domenico Losurdo, il quale afferma che siamo in presenza di un: ›ridimensionamento teorico della democrazia. Dato che questa non riesce a realizzare le sue promesse, né per quanto riguarda i diritti materiali né per quel che concerne la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, si procede ad una ridefinizione minimale che l’adatta all’esistente».
Democrazia o Bonapartismo?
La fine della democrazia moderna, rimpiazzata dalla democrazia postmoderna, annuncia l’avvio del “bonapartismo soft”: il regime in cui la democrazia è un mercato politico sul quale si affrontano leader concorrenti. Nella sfida tra partiti diversi, non si affrontano immaginari o visioni del mondo contrapposti. No, ad affrontarsi sono leader cesaristici che propongono, a elettori disorientati e dominati, un’idea più o meno simile del mondo. La comunità politica si è ridotta a mercato entro cui si sceglie tra due prodotti politici che, pur in concorrenza reciproca, si rassomigliano come un dentifricio o una saponetta rassomiglia a un altro dentifricio o saponetta di marca diversa.
È essenziale riconoscere la fine di un’epoca storica e l’inizio di una nuova fase per la democrazia moderna. Non esistono risposte facili, ma una cosa è certa: solo una risposta collettiva, unita all’attivazione politica dei gruppi subalterni, può fermare la perversa direzione che la “democrazia” ha preso.
Fonte immagine: Pexels (Wellington Silva, https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-arte-dipingendo-museo-14638946/)