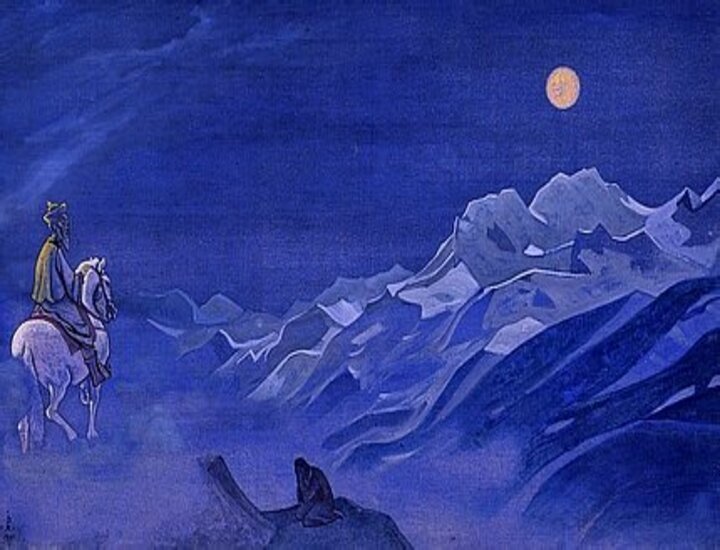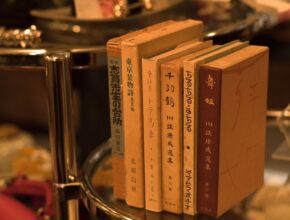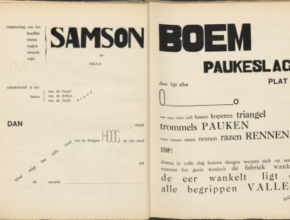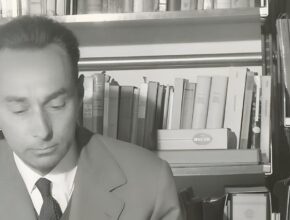Decameron: cornice e supercornice nell’opera di Boccaccio
Il Decameron di Giovanni Boccaccio, scritto probabilmente intorno al 1349, subito dopo la terribile peste del 1348, è un’opera molto importante della letteratura del Trecento europeo. Quest’opera, definibile come una sorta di commedia umana, presenta una struttura complessa e articolata: al suo interno, possiamo individuare la presenza di due elementi particolari, una cornice e una supercornice, che donano all’opera un carattere di grande modernità. Boccaccio, con il Decameron, dà vita a un’opera estremamente innovativa, sia dal punto di vista della struttura, sia da quello della scelta dei temi e dello stile: la realtà viene rappresentata in modo estremamente fedele e vivido, e la varietà dei personaggi, delle situazioni e degli ambienti è una delle caratteristiche principali di quest’opera. L’autore fotografa la società del suo tempo, fatta di mercanti, nobili, ecclesiastici, popolani, mettendone in luce vizi e virtù, con uno sguardo ironico e, a tratti, dissacrante.
Il Decameron è di fatto una raccolta di cento novelle raccontate in dieci giorni. Infatti, la parola “Decameron” deriva dal greco (Deca e hemeron) e significa proprio “dieci giorni”. Quest’opera è assolutamente moderna, sia per le sue scelte linguistiche e stilistiche che per la sua varietà, nota caratterizzante di questa raccolta di novelle. All’interno del Decameron sono presenti tre livelli di narrazione: vi è quella di primo livello, costituita dalla voce dell’autore; quella di secondo livello, che fa riferimento ai narratori delle novelle; infine, quella di terzo livello, che si riferisce ai personaggi all’interno delle novelle raccontate che, a loro volta, raccontano delle storie.
Cos’è il Decameron di Boccaccio?
Il Decameron, come si è detto, è una raccolta di cento novelle, narrate da una Brigata di dieci giovani, sette ragazze e tre ragazzi, nel corso di dieci giornate. Il titolo stesso dell’opera, di derivazione greca, significa letteralmente “dieci giorni”. La narrazione è organizzata in modo molto preciso: a ogni giornata, tranne la prima e la nona, corrisponde un tema specifico, scelto dal re o dalla regina della giornata. Tra i principali temi del Decameron, troviamo l’amore, sia nella sua declinazione più nobile e cortese, sia negli aspetti più sensuali e carnali, la fortuna, l’ingegno e la beffa. Boccaccio sceglie di utilizzare il volgare fiorentino, una lingua viva e ricca di sfumature, che gli permette di rappresentare in modo realistico ogni aspetto della società del suo tempo. L’opera è estremamente moderna anche nella sua struttura narrativa, che prevede un gioco di incastri e rimandi tra i vari livelli della narrazione, creando un effetto di grande coinvolgimento per il lettore.
Supercornice del Decameron: l’autore si racconta
Il primo livello di narrazione del Decameron fa riferimento alla voce dell’autore reale, Giovanni Boccaccio, che parla in prima persona. In tale livello ritroviamo la supercornice, cioè lo spazio che l’autore riserva a sé, una sorta di firma d’autore. Essa è composta dal Proemio, dalla conclusione e dagli interventi in cui l’autore fa riflessioni sulla sua opera, sulla letteratura e sul ruolo dello scrittore. Nella supercornice Boccaccio si rivolge direttamente ai lettori, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a scrivere, le sue scelte stilistiche e il suo pensiero.
Proemio del Decameron: l’intrattenimento per le donne
Nel Proemio, Boccaccio espone i motivi per i quali ha deciso di scrivere l’opera e la dedica: afferma che questa è indirizzata alle donne che sono afflitte da pene d’amore, allo scopo di ricavarne intrattenimento, piacere, diletto e alleviare le loro sofferenze. Le donne, infatti, rispetto agli uomini, hanno meno possibilità di trovare svaghi e distrazioni dalle pene d’amore e vivono la loro condizione amorosa in modo più intenso e sofferto. Boccaccio vuole offrire loro, attraverso la lettura delle sue novelle, una fonte di svago e consolazione, un modo per immedesimarsi nelle vicende narrate e trovare conforto nelle parole dell’autore.
Decameron e l’eros: la difesa di Boccaccio
Poiché il tema dell’amore è affrontato in quasi tutta l’opera, e in particolare l’eros, Boccaccio sente la necessità di difendersi dalle possibili critiche e di rivendicare il suo diritto a fare una letteratura libera, ispirata all’amore e al piacere, anche carnale, e lo fa in particolare nell’introduzione alla IV giornata (nella “novella delle papere“) e nella conclusione all’opera. L’autore si difende dalle accuse di eccessiva licenziosità, affermando che la letteratura deve essere libera di trattare ogni argomento, senza censure. La rappresentazione dell’amore, in tutte le sue forme, anche attraverso l’uso di un linguaggio colorito e immagini vivide, rientra a pieno titolo nel campo d’azione della letteratura.
La cornice del Decameron: spazio e tempo dei narratori
Poiché la struttura del Decameron è “a incastro”, la supercornice comprende la cornice, ovvero lo spazio e il tempo nel quale si muovono i dieci novellatori, che sono Pampinea, Fiammetta, Filomena, Emilia, Elissa, Neifile, Lauretta, Dioneo, Filostrato e Panfilo. La cornice svolge la funzione di macro-racconto in cui i novellatori sono i personaggi della storia narrata. Infatti, questa è composta dall’ambientazione delle novelle, dall’antefatto e dalla descrizione della peste.
La peste a Firenze e la fuga in campagna
La cornice del Decameron è tutto ciò che non fa parte dello sviluppo delle singole novelle: nella Firenze contaminata dalla peste, un gruppo di sette ragazze e tre ragazzi, la Brigata, si incontra nella Chiesa di Santa Maria Novella e decide di ritirarsi in campagna per sfuggire al contagio, in un luogo idilliaco e incontaminato, un vero e proprio locus amoenus. La descrizione della peste a Firenze è estremamente realistica e dettagliata, e serve a Boccaccio per introdurre il tema della fragilità umana di fronte alla forza incontrastabile della natura. Durante queste giornate, per passare il tempo nelle ore pomeridiane, ogni giovane, a turno, racconta una novella, creando un vero e proprio rituale di narrazione.
La funzione della cornice nel Decameron
La funzione della cornice, all’interno del Decameron, è quella di dare una struttura e un ordine alle cento novelle e di contestualizzarle dal punto di vista storico e spaziale, creando un filo conduttore che le unisce. Ma non solo: la cornice ha anche lo scopo di dare compattezza alla narrazione, collegando le varie novelle tra loro attraverso le giornate, i commenti dei novellieri, le riflessioni e i dialoghi che intercorrono tra loro. Così come la supercornice del Decameron comprende la cornice, questa, a sua volta, comprende il vero racconto, in un gioco di scatole cinesi. Ogni novella può essere considerata come un exemplum, un racconto che racchiude un insegnamento morale o un esempio di comportamento. La cornice, in definitiva, crea un contesto unitario e coerente per le cento novelle, rendendo il Decameron un’opera complessa e affascinante, che continua a parlare ai lettori di ogni tempo.
Fonte immagine in evidenza per l’articolo sulla cornice e supercornice del Decameron: Pixabay