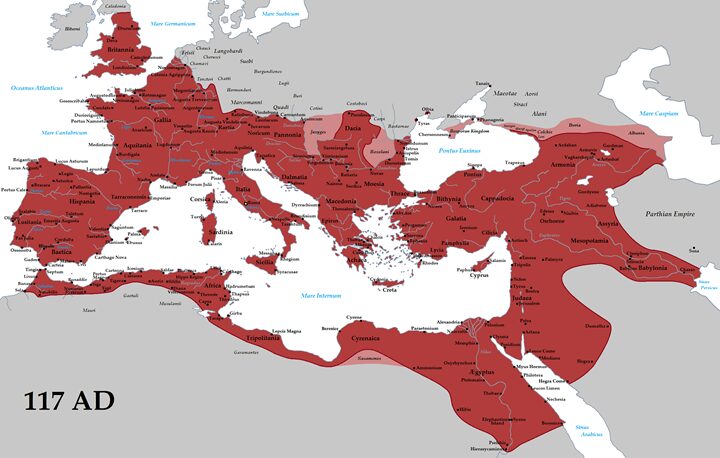Questo articolo esplora alcuni aspetti della mentalità medievale, ovvero il modo in cui gli uomini e le donne del Medioevo (in particolare l’Alto Medioevo, fino all’anno Mille) concepivano la vita e la morte, il corpo e l’anima, il passato e il futuro, il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, cercando di comprendere il significato della loro esistenza.
Ricostruire il pensiero medievale: fonti e difficoltà
Ricostruire la mentalità medievale presenta delle difficoltà. In primo luogo, il Medioevo copre un periodo molto lungo (almeno cinque secoli per l’Alto Medioevo), durante il quale la mentalità può aver subito trasformazioni. In secondo luogo, le fonti disponibili sono limitate: provengono per lo più da una ristretta élite culturale (soprattutto ecclesiastica) e riflettono la loro visione del mondo, mentre è più difficile accedere ai pensieri della maggioranza della popolazione, esclusa dall’uso della scrittura.
Lunga durata e società “parmenidea”: la lentezza del cambiamento
Nonostante queste difficoltà, il tentativo non è impossibile. Le mentalità appartengono alla dimensione della “lunga durata” (concetto introdotto dallo storico Fernand Braudel): cambiano molto lentamente, in secoli, non in anni. Questo è particolarmente vero per il Medioevo, quando i cambiamenti nel modo di vedere il mondo erano molto più graduali rispetto alla società contemporanea. Mentre la società contemporanea è definita “eraclitea” (in costante mutamento, come il fiume di Eraclito), la società medievale potrebbe essere definita “parmenidea” (caratterizzata da una maggiore stabilità, come l’Essere di Parmenide).
Il cristianesimo: la visione dominante del mondo
Inoltre, nel Medioevo, quasi tutta la cultura era prodotta da uomini di Chiesa (i chierici), che nei loro scritti affrontavano spesso questioni riguardanti la vita quotidiana dei fedeli. La nostra ricerca è facilitata dal fatto che il cristianesimo si diffuse in tutta Europa e tra tutti i ceti sociali, soppiantando progressivamente i residui degli antichi culti pagani. La visione del mondo della maggioranza degli uomini e delle donne del Medioevo era quindi fortemente condizionata dalla dottrina e dalla morale cristiana. I racconti contenuti nella Bibbia erano accettati nel loro significato letterale, proposti instancabilmente ai fedeli e rappresentati nei dipinti e nelle sculture che ornavano chiese e cappelle.
Paradiso e inferno: la sorte ultraterrena dell’uomo medievale
I racconti biblici insegnavano l’esistenza di un unico Dio, creatore del mondo e dell’uomo, che un giorno avrebbe posto fine al mondo conosciuto, giudicando i vivi e i morti. I Vangeli fornivano indicazioni precise sulla sorte ultraterrena: ai giusti sarebbe toccata l’eternità beata in Paradiso, ai malvagi la condanna eterna nell’Inferno, immaginato come una cavità nel cuore della terra.
Dio, Satana e i santi: una lotta continua tra bene e male
L’agiografia: modelli di santità
Nonostante il monoteismo cristiano, il mondo medievale era popolato di entità intermedie, come il diavolo e i demoni. L’intera vita umana era vista come in bilico tra Dio e Satana, e l’anima di ciascuno era oggetto di una contesa tra cielo e inferno. I peccati e le tentazioni erano innumerevoli, e resistervi richiedeva fede e l’aiuto dei santi, uomini speciali che avevano vinto le aggressioni del diavolo grazie alla fede, alla preghiera e al sostegno divino. L’agiografia (racconti delle vite dei santi) ebbe grande diffusione, fungendo da modello per ogni fedele.
Il mondo come foresta di simboli: la natura e il divino
Era diffusa la convinzione che Dio potesse intervenire direttamente nella vita umana attraverso miracoli: guarigioni prodigiose, piogge provvidenziali, dimostrazioni di forza sovrumana. Dio e il diavolo non erano spettatori passivi, ma intervenivano costantemente nel mondo.
Il cristianesimo medievale elaborò l’idea che il mondo visibile fosse un segno, uno specchio, una foresta di simboli in cui tutto rimanda a una realtà sovrannaturale o a una verità di fede. Gli uomini medievali vedevano la realtà come “doppia”: le cose non erano mai solo come apparivano, ma costituivano il segno di qualcosa di più alto (es. il leone poteva simboleggiare la forza, ma anche Cristo; il pellicano, che nutre i piccoli con il proprio sangue, era simbolo del sacrificio di Cristo).
Scienza e teologia: due modi di interpretare il mondo
Si può affermare che il mondo medievale fosse “incantato”: Dio e Satana erano presenti, e ogni cosa portava un messaggio profondo. Questo spiega perché le scienze naturali medievali compirono pochi progressi rispetto al mondo antico, spesso abbandonando i risultati raggiunti da Greci e Romani. Di fronte al mondo, l’uomo medievale non si chiedeva “come funziona?”, ma “che cosa significa?”, e la risposta era affidata ai teologi, non agli scienziati.
La mentalità medievale, profondamente influenzata dal cristianesimo, era quindi caratterizzata da una visione del mondo in cui il soprannaturale permeava il naturale, in cui ogni cosa aveva un significato simbolico e in cui la vita umana era vista come una lotta continua tra bene e male, con la prospettiva di una ricompensa o di una punizione eterna.
Prof. Giovanni Pellegrino