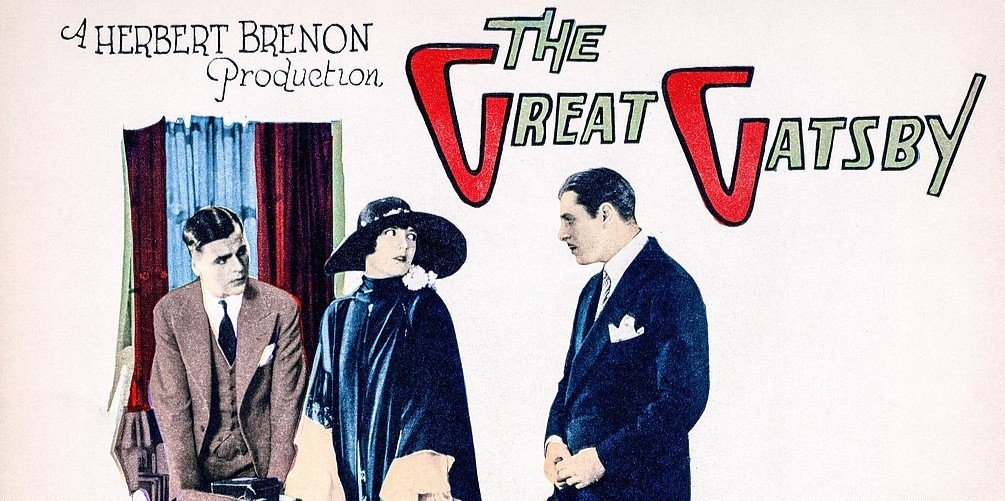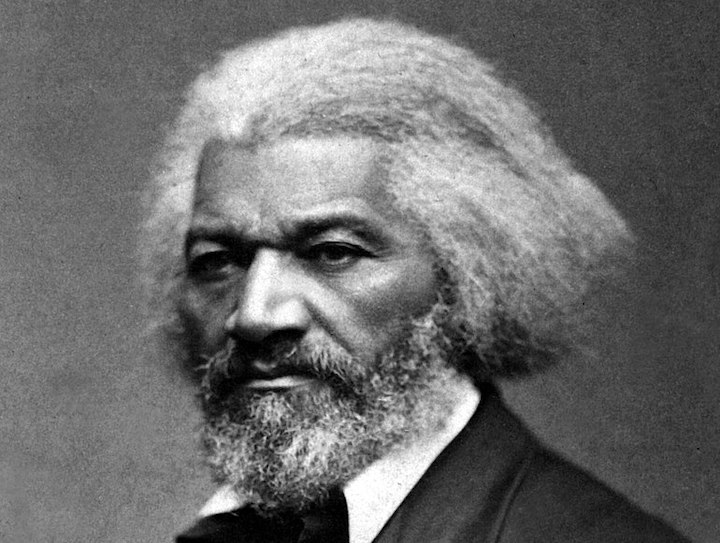Divinità dei boschi: alla scoperta delle ninfe, dei satiri e di tutto il pantheon selvatico della religione greco-romana
La mitologia greco-romana è costituita da un ricco patrimonio di vicende che riguardano gli dèi dell’Olimpo, gli uomini e le creature mostruose di vario tipo come i Giganti, Cerbero o l’Idra di Lernia.
Nati all’origine della civiltà, i miti entrarono nel patrimonio poetico e letterario grazie a opere come la Teogonia di Esiodo e il Ciclo troiano nel mondo greco oppure l’Eneide di Virgilio e le Metamorfosi di Ovidio per quello romano abbandonando la cultura popolare.
I Greci e i Romani ritenevano che i boschi fossero abitati dalle divinità: si tratta di tracce di culti folk legati alla terra, quando questi popoli non avevano ancora raggiunto un grado di civiltà maggiore che potesse permettere la nascita di forme letterarie e il miglioramento delle condizioni di vita. Gli stessi Latini erano soliti distinguere la selva (ossia il bosco) dalla campagna dal momento che la prima rappresenta un luogo dove “la natura non era stata addomesticata” e l’uomo non poteva sopravvivere in nessun modo.
Le divinità dei boschi dei Greci: le driadi e i satiri
Il primo caso di divinità dei boschi era quello delle driadi, ossia le ninfe silvestri. Si trattava di dee minori associate alle foreste per distinguerle dalle proprie simili delle montagne (oreadi) e delle acque marine o fluviali (naiadi). Lo storico Giulio Giannelli afferma, in una voce dell’Enciclopedia Treccani, che tali divinità boschive trascorrevano le proprie giornate cacciando con la dea Artemide (Diana per i Romani), partecipando ai riti del vino in onore di Dioniso (Bacco a Roma) oppure in attività come la filatura, la tessitura, la danza o il bagno. Quando un albero, che una ninfa usava come abitazione, veniva abbattuto anche l’anima della divinità spariva con la propria dimora.
Alle ninfe non si attribuiva però soltanto la facoltà di destare l’amore per esse nei mortali, ma anche la forza d’infondere negli uomini una sovreccitazione estatica, dalla quale si facevano spesso derivare certe virtù profetiche in coloro che n’erano colpiti: νυμϕόληπτοι si dicevano quest’invasati, e di tale specie sono da riguardarsi anche le sibille; i Latini chiamarono costoro lymphatici (ossia nymphatici; lympha = nympha [..]). (Giulio Giannelli, Enciclopedia italiana in Dizionario Treccani, 1934, ultima consultazione 13 luglio 2022)
I più grandi nemici delle ninfe erano i satiri, divinità maschili dall’aspetto umano ma con alcuni attributi caprini come zampe con zoccoli al posto dei piedi, una coda pelosa, orecchie lunghe e corna sulla fronte. In origine i satiri erano descritti allo stesso modo dei sileni, altre creature del bosco ma con attributi equini. Soltanto con lo scultore greco Prassitele (vissuto nel IV secolo a.C.) queste creature si ingentilirono diventando simili a degli adolescenti con orecchie caprine e folte chiome. I Romani avevano un corrispettivo di questo essere mitologico, il Fauno, una divinità di origine antichissima legata alla dimensione boschiva della cultura italica.
I satiri trascorrevano le proprie giornate seguendo il dio Dioniso durante i riti misterici dionisiaci (o baccanali per i Latini) e molto spesso erano rappresentati nel momento di aggredire sessualmente una ninfa.
Dai monti dell’Arcadia arriva il famoso Pan
La divinità boschiva più importante della mitologia classica era Pan. Si trattava di un dio boschivo e agreste originario dell‘Arcadia, la regione montuosa della Grecia abitata da pastori e contadini quindi lontana dalle póleis come Sparta, Atene o Tebe, evolute dal punto di vista politico-sociale, oppure dalle colonie magnogreche come Neapolis, Siracusa, Crotone e Taranto, sviluppatesi sotto il profilo filosofico-culturale.
L’archeologa Margherita Guarducci racconta le origini del dio Pan presentate nell’inno dedicato alla divinità. Egli era figlio di Ermete Cillenio e di una ninfa figlia di Driope. Il nascituro era stato battezzato con il nome Pan che in greco significa “tutto”, dal momento che la notizia della sua nascita rallegrò tutte le divinità dell’Olimpo.
Pan era rappresentato con una folta barba, zampe di capra e lunghe orecchie ed accompagna Dioniso nelle sue giornate. Questa divinità era capace di infondere terrore e preoccupazione negli animi di bestie e uomini soprattutto nel primo pomeriggio, da qui il termine “panico” legato al panismo dannunziano. La sede del dio era situata lungo una catena montuosa formata dai monti Liceo, Menalo e Partenio dove i locali lo veneravano in un tempio nei boschi.
Fonte immagine di copertina: Pixabay