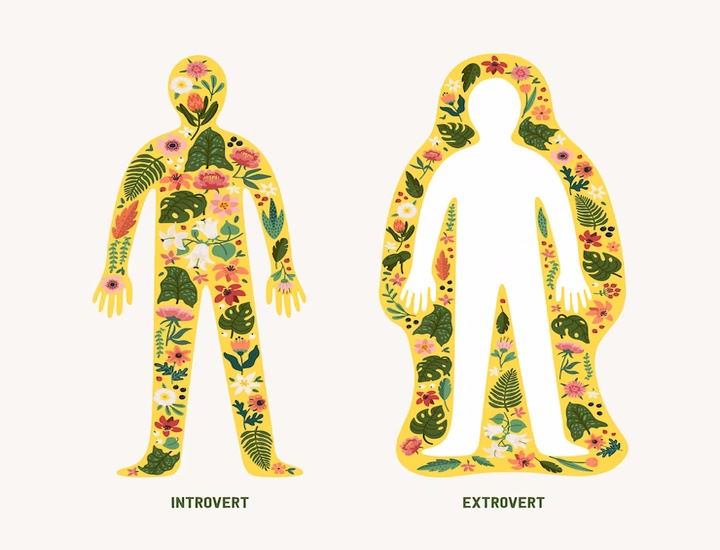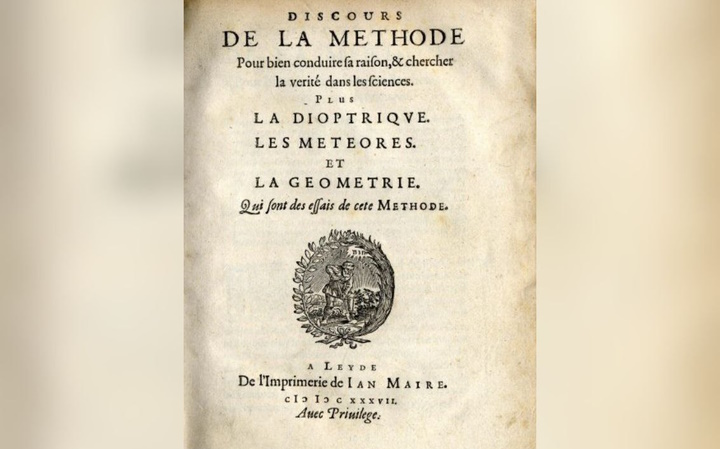L’attivista e scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, vincitrice del Commonwealth Writers Prize con il libro L’ibisco viola, affronta in un toccante TED talk una problematica sulla quale ha avuto modo di riflettere in più fasi della sua vita. L’autrice discute l’importanza delle molteplici narrative, del pericolo che comporta la storia unica, ovvero l’avere una visione unilaterale su un altro popolo e possederne un’idea erronea e stereotipata. Nello svilupparsi del discorso, Adichie fornisce dei validi esempi personali a sostegno delle sue argomentazioni.
Vediamo in cosa consiste il pericolo della storia unica.
Cominciando dalla sua infanzia, Adichie evidenzia la difficoltà nell’identificarsi con un personaggio che possedesse i suoi stessi tratti somatici. Difatti, da bambina leggeva libri di letteratura inglese, molto più semplici da reperire, e immaginava i personaggi caucasici che venivano descritti. Crebbe convinta che non esistessero personaggi come lei, che la letteratura consistesse in questo tipo di narrazione. Successivamente ebbe la possibilità di accedere alla letteratura africana, e scoprì che anche altre storie potevano essere raccontate. Grazie agli autori africani prese consapevolezza dell’importanza di non limitarsi a raccontare una storia unica, narrata cioè da un unico punto di vista.
Lei stessa ha visto qualcuno attraverso uno sguardo unilaterale, e lo ha associato ad un’unica storia. Fa riferimento a Fide, un ragazzino che svolgeva le faccende domestiche in casa sua. Col tempo iniziò ad assumere un atteggiamento pietistico verso di lui, addirittura pensava che la famiglia di Fide non fosse in grado di creare nulla. Questo perché attraverso i libri che aveva letto e attraverso le parole della madre che la invitava, quando non voleva mangiare, a pensare alla povertà di Fide, ne aveva sviluppato una visione stereotipata e, pertanto, completamente distorta rispetto alla realtà. Quando scoprì che la famiglia di Fide fosse diversa da come l’aveva immaginata, e che il fratello era in grado di realizzare un cestino, rimase sorpresa, perché tutto quello che sapeva sulla loro storia era che fossero poveri. Si rese conto che la narrazione che si era costruita su di loro fosse falsa.
La presa di consapevolezza dell’autrice
Il percorso di realizzazione di Adichie giunse al culmine quando provò personalmente cosa significasse essere visti attraverso lo sguardo bianco ed occidentale, vivendo così sulla propria pelle il pericolo della storia unica. Una volta trasferitasi nella sua università americana, la sua coinquilina l’associò ad una serie di comuni stereotipi sulla cultura e identità africana: pensava che non conoscesse l’inglese, non sapesse come far funzionare una stufa, o che ascoltasse solo musica tribale. Ancora prima di conoscerla, provava già un sentimento di paternalismo nei suoi confronti. Adichie capì che anche quella ragazza possedeva una sola storia sull’Africa, che per lei non provava nient’altro che pietà, e non concepiva gli africani come esseri umani alla pari dei bianchi.
L’autrice, che si identifica orgogliosamente come nigeriana (identità per lei molto più sentita di quella africana), ammette che se anche lei fosse vissuta esclusivamente in un paese occidentale, avrebbe probabilmente sviluppato una visione incompleta, monolitica, e pertanto scorretta, dell’Africa. Adichie si incolpa a sua volta, ammettendo che lei stessa durante la sua vita aveva contribuito alla narrativa della storia unica, credendo all’unica versione venduta sui messicani: immigrati spregevoli, che attraversavano i confini di nascosto e rubavano i soldi della sanità.
Le origini della storia unica
Adichie identifica nella letteratura occidentale una grande responsabile che nei secoli ha contribuito a mostrare l’Africa come un luogo pericoloso, un paese incivile e dove proliferano le malattie. Tutto ciò sin dalla produzione diaristica di John Locke, che segna l’inizio della tradizione occidentale nel ritrarre l’Africa sub-sahariana come un luogo altamente pericoloso e troppo diverso dal mondo occidentale. Questa percezione dell’Africa non è affatto recente: è legata al processo di colonizzazione di questi territori, per cui fu necessario per i coloni giustificare le proprie azioni spregevoli dipingendo gli africani come selvaggi, creature mostruose con un occhio sulla fronte e senza testa. Hannah Arendt a proposito parla di come quello che spaventasse di più i coloni fosse pensare a queste persone come parte della natura stessa, e pertanto, seguendo una visione antropocentrica, come qualcosa di immutabile e che dovesse essere dominata.
Secondo Adichie, per creare un’unica storia è sufficiente presentare un popolo con delle caratteristiche specifiche e fisse, e alla fine le persone crederanno a quell’unica narrativa alla quale sono state esposte. Importante è essere consapevoli che una storia è definita non solo dai termini in cui viene raccontata, ma soprattutto dalla prospettiva che viene adottata. Emerge dunque l’importanza della corretta rappresentazione dei gruppi oppressi. Chi appartiene ad un gruppo potrà comprendere profondamente il suo funzionamento e fornire una visione più accurata dall’interno, evitando stereotipi che chi non condivide quella cultura può sviluppare in quanto influenzato da fattori esterni. A suo avviso chi racconta una storia possiede potere, perché è in grado di modificare la percezione di un’altra persona. «Il potere è la capacità non solo di raccontare la storia di un’altra persona, ma di farne la storia definitiva di quella persona […] Inizia la storia con le frecce dei nativi americani e non con l’arrivo degli inglesi, e hai una storia completamente diversa».
Adichie conclude il suo discorso sottolineando le conseguenze della storia unica: chi ne è vittima viene privato della sua dignità. Risulterà complesso riuscire ad empatizzare e a percepire come nostro pari un popolo che conosciamo solo attraverso una visione parziale e stereotipata, perché saremmo piuttosto portati a concentrarci sulle differenze, che ci allontanano e ci separano dagli altri. Difatti afferma che «la storia unica crea stereotipi e il problema con gli stereotipi non è solo che sono falsi, ma sono anche incompleti. Rendono una storia la storia unica». Così come la narrazione di una storia può deumanizzare un essere umano o un popolo intero, può allo stesso tempo restituirgli la dignità persa, se affidata a chi di queste storie è protagonista.
Fonte immagine: Copertina del video YouTube Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story | TED