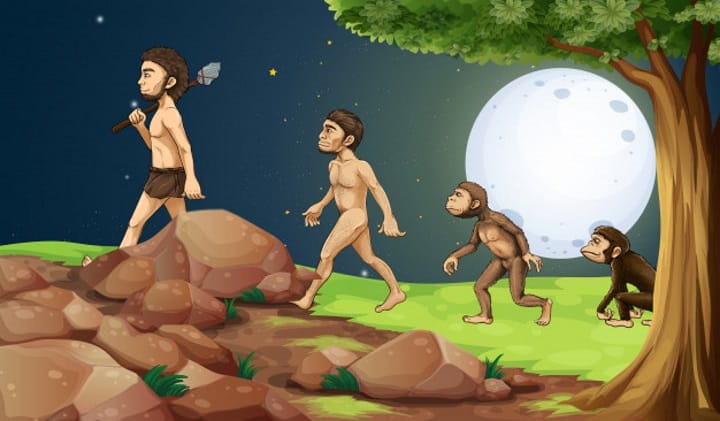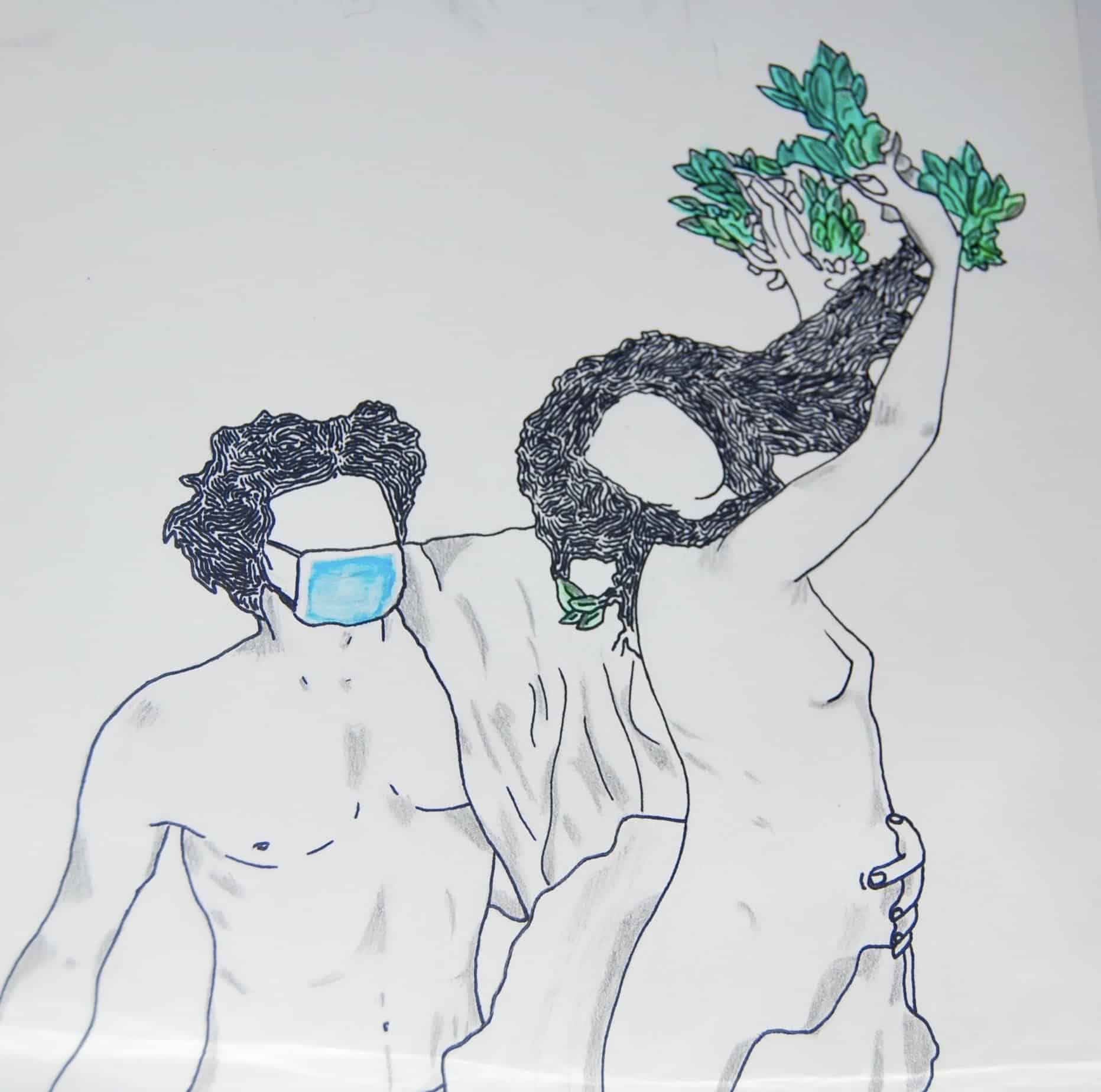La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi è un’opera molto interessante che vale la pena conoscere.
Prima di analizzare la figura della Sarrocchi è fondamentale affermare che lo studio delle autrici è ancora oggi poco approfondito, ma è possibile confermare che, ad oggi, sono stati fatti molti passi in avanti.
La letteratura d’autrici: uno sguardo particolare all’epica tra Cinquecento e Seicento tramite La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi
La letteratura femminile ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura letteraria italiana, portando alla luce voci, esperienze e punti di vista che, troppo a lungo, sono stati marginalizzati o addirittura ignorati. Le scrittrici, in molti casi, hanno dovuto lottare per ottenere riconoscimento e visibilità in un campo dominato da uomini. Tuttavia, le loro opere hanno contribuito a modellare il pensiero e ad arricchire la narrativa, esplorando temi legati alla condizione femminile, alle lotte sociali e alle dinamiche di potere.
Il loro contributo è pari a quello degli uomini e le donne dovrebbero essere inserite nel canone letterario: i nomi femminili dovrebbero figurare accanto a quelli maschili. Per comprendere quanto affermato in precedenza è possibile fare una panoramica, al femminile, sull’epica della nostra letteratura tra Cinquecento e Seicento, attraverso la Scanderbeide di Margherita Sarrocchi.
Margherita Sarrocchi: vita d’autrice
Margherita Sarrocchi è un’autrice molto importante nel panorama della letteratura femminile. Nasce intorno al 1560, non sappiamo molto della sua famiglia. Ebbe un’educazione maschile e venne istruita non solo alle arti del trivio e del quadrivio ma anche allo studio del greco. Accanto a questa formazione volta verso l’antico, l’istruzione letteraria della Sarrocchi la portò soprattutto a diventare una petrarchista, non soltanto come poetessa: fu anche una lettrice accurata del Canzoniere di Petrarca.
Prima ancora di scrivere opere sue, curò l’edizione critica sia del Canzoniere di Petrarca sia delle Rime di Giovanni Della Casa (poeta che, sulla scorta di Petrarca e di Tasso, aveva scritto un libro di rime molto famoso nel 1500).
L’autrice realizza a Roma un salotto intellettuale frequentato dai principali intellettuali romani, tra cui Luca Valerio che da suo precettore lentamente si trasforma in suo compagno di vita. Continua ad apprezzare anche gli studi scientifici, nel 1611 conosce Galileo Galilei, il quale comincia ad intrattenere con lei un rapporto epistolare. Vista l’intonazione delle sue lettere, Margherita Sarrocchi diventa una vera e propria seguace di Galileo al punto che, quando scrive la sua opera a cui tiene particolarmente, si preoccupa di farla leggere proprio a Galilei.
Margherita Sarrocchi è stata inserita nei principali salotti intellettuali del tempo e nell’Accademia degli Oziosi e degli Umoristi. Nella prima, conosce Giambattista Marino, che si innamora perdutamente di lei. Egli le dedica una serie di sonetti amorosi, ma dopo un breve periodo di amore corrisposto, Sarrocchi passa oltre e lo lascia. Marino, ne L’Adone, la chiama cornacchia e la denigra in una serie di altri sonetti. Tuttavia, Luca Valerio racconta che alla Sarrocchi poco interessano le critiche perché è una donna particolarmente determinata e non presta attenzione a queste accuse perché è pronta ad apparecchiare la sua opera più importante.
La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi
La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi è un poema epico che nasce nel Seicento, dopo che l’epica è passata attraverso la stagione rinascimentale prima di Ariosto e poi di Tasso. La Sarrocchi lavora molto a quest’opera e ne dà lettura a Galileo Galilei. Oltre a temi di carattere epico, infatti, torna anche la passione scientifica che anima l’autrice della letteratura femminile nostrana. Scanderberg, protagonista dell’opera, si ammala gravemente e vengono indicati una serie di rimedi medici in maniera molto dettagliata, che rivelano la conoscenza della scienza medica da parte della scrittrice. Inoltre, dall’opera si capisce che Margherita sia una seguace di Galilei perché inserisce riferimenti sia a elementi come il cannocchiale sia al nuovo sistema cosmologico proposto da Galileo.
L’opera riceve due edizioni: la prima edizione è del 1606, composta da 11 canti, dedicata a Costanza Colonna. La seconda edizione è del 1623 ed è una versione meno scientifica -perché il nome di Galileo era ormai noto all’Inquisizione- ma più ampia: costa di 23 canti. Questa vicenda editoriale ricorda quella di Tasso: l’autore aveva pubblicato la Gerusalemme Liberata e poi l’aveva epurata di alcuni parti, trasformandola nella Gerusalemme Conquistata: opera più incline ai dettami della controriforma. Così, anche La Scanderbeide: la prima edizione abbonda di scene amorose e ludiche, la seconda viene epurata di queste possibili distrazioni, per diventare esclusivamente un poema epico che segnerà il trionfo della cristianità sugli infedeli.
Il racconto, infatti, è incentrato sulla ricostruzione delle avventure del guerriero albanese, Giorgio Castriota Scanderberg, che compie una spedizione contro il sultano turco Murad per riconquistare l’Albania. Questa riconquista avverrà solo in un momento preciso: quando si convertirà al cristianesimo. Nella vicenda di questo eroe che riporta alla cristianità l’Albania che era stata messa a ferro e fuoco dal sultano turco, si sente l’influenza sia nei temi sia nello stile dei Discorsi del poema eroico di Tasso. Opera in cui veniva fissata l’idea che l’argomento dovesse essere il meraviglioso cristiano e in cui veniva definita la funzione dei personaggi all’interno del testo: dovevano incarnare concetti eticamente positivi. Questa idea del personaggio costruito per fare il bene viene seguito anche da Margherita Sarrocchi. L’opera epica è scritta in ottave, perché Tasso aveva messo a norma l’uso dell’ottava come metro della poesia epica ed eroica.
Personaggi e scelte stilistiche dell’opera
Il protagonista dell’opera è un uomo ma avvertiamo un’attenzione particolare dell’autrice ai personaggi femminili. Questo protagonismo delle donne dei poemi epici non è invenzione femminile ma maschile (il primo a farlo è stato Ariosto, che realizza la figura dell’eroina guerriera di Bradamante). Questa equiparazione ariostesca tra personaggi femminili e maschili viene portata avanti anche da Tasso, che tuttavia elimina progressivamente gli episodi che connotano le donne come donne e finisce per trasformare le sue eroine positive esclusivamente in guerriere, mentre alle eroine negative (soprattutto le maghe) vengono attribuiti i tratti tipici della femminilità: le donne positive di Tasso diventano quasi degli uomini, mentre le donne negative conservano le caratteristiche di fascino e attrattiva che hanno normalmente le donne. Questo obbedisce all’epoca della controriforma che vede nella seduzione femminile una distrazione dall’ortodossia.
Dunque, quando Margherita Sarrocchi scrive, tra il modello ariostesco e quello tassiano, sceglie di seguire quello tassiano perché elimina ogni riferimento (o quasi) alla femminilità a discapito del valore morale delle donne, che deve sempre emergere. Le donne, come in Tasso, devono sempre avere valori morali positivi. Questo si vede bene nella protagonista femminile del libro, Rosmonda. Ella è la figlia del sultano ed è presentata come una giovane guerriera di straordinaria forza e valore. A questo personaggio si affianca un’altra tipologia di femminile, rappresentata da Silveria, cresciuta dai pastori, che si distingue nei boschi dell’Albania per lo straordinario patriottismo, ha ucciso tantissimi infedeli, non conosce grazia e femminilità perché non ha mai avuto l’amore di una famiglia: è una guerriera pura che non cade mai in tentazione, mentre Rosmunda è costretta a combattere quotidianamente dalle tentazioni offerte dalla sua femminilità. Si tratta di due modi diversi di raccontare il femminile che tuttavia non affrancano mai le donne da valori positivi. Non abbiamo ne La Scanderbeide personaggi femminili totalmente negativi. Essi sono o totalmente positivi o parzialmente negativi ma che intraprendono percorsi che li ingentiliscono. La versione del 1623 è molto più complessa e sembra esemplata molto più da vicino sul modello tassiano: vi è infatti la stessa costruzione proemiale della Gerusalemme Liberata.
Confronti con Tasso e Ariosto
Nella versione del 1606 abbiamo l’invocazione alla Musa ed emerge il tema dell’opera. La Musa dovrà aiutare la poetessa a cantare i grandi affanni del re dell’Epiro e l’assalto che Giorgio Castriota farà in Albania per liberarla dai Turchi. Non c’è dedica, non è esplicitato il fine dell’opera: la poetessa entra immediatamente nel vivo dell’opera stessa. Nella versione del 1623 questo non accade, si avverte una particolare imitazione dello stile e anche della sintassi tassiana. Tasso parla di Goffredo che riuscirà a guidare i cristiani verso la vittoria contro gli infedeli e descrive la crociata come un’operazione dovuta al volere di Dio. Questa stessa intonazione sintagmatica appare subito nella prima ottava della versione del 1623 e, esattamente come in Tasso, le ottave successive sono occupate dalla dedica. Questa dedica è bipartita perché dedicata ai coniugi estensi, dedica prima alla signora e poi al marito, al quale però l’unico merito attribuito sembra essere aver conquistato come moglie una donna tanto elevata come Giulia. Questa bipartizione del femminile e del maschile è presente in tutto il testo, sebbene l’opera debba raccontare le gesta di un uomo, è un personaggio femminile che assumerà sempre più importanza fino a diventare vera protagonista (Rosmonda). È come se l’opera cantasse le gesta di un uomo che per compierle in maniera valorosa deve attendere l’intervento divino, e di una donna che invece possiede già in sé tutte le doti necessarie per essere vittoriosa, la vera eroina etica è Rosmonda (dal nostro punto di vista). Dal punto di vista controriformista invece, Sarrocchi sceglie questo tipo di soluzione perché l’eroe positivo è l’eroe che agisce per volontà divina, le cui gesta sono eticamente orientate da Dio. Il messaggio della controriforma è che da soli non sempre si agisce correttamente.
Fondamentale è la parte dell’opera in cui viene presentata Rosmonda: inizialmente è presentata come guerriera. Nella seconda parte, le viene attribuita una certa femminilità, non viene rappresentata nel momento della battaglia. Margherita Sarrocchi riprende un elemento presente in Ariosto. La femminilità non è esplicitata in battaglia perché le donne rivelano solo dopo aver vinto la propria identità. Questo perché il loro aspetto distrattivo, necessita d’essere nascosto in battaglia.
Fonte immagine di copertina: Ritratto di Margherita Sarrocchi da L’Enciclopedia delle donne https://www.enciclopediadelledonne.it/edd.nsf/biografie/margherita-sarrocchi