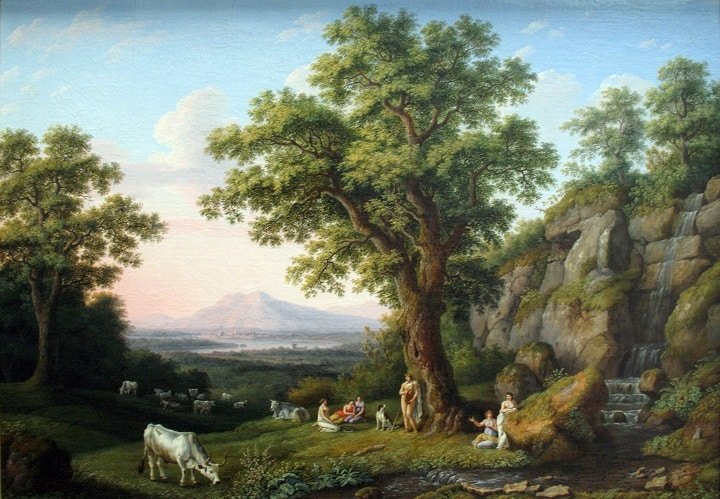Gli Etruschi furono un popolo affascinante e misterioso dell’Italia antica, che visse tra il IX e il I secolo a.C. in un’area denominata Etruria, corrispondente all’odierna Toscana, all’Umbria occidentale e al Lazio settentrionale e centrale, con propaggini anche in Campania, Emilia-Romagna e Lombardia. La loro civiltà, caratterizzata da una cultura raffinata, un’arte originale e una religione complessa, ha profondamente influenzato la civiltà romana, lasciando un’eredità duratura.
Le origini degli Etruschi: un enigma ancora irrisolto
Le teorie sull’origine degli Etruschi: Lidia, Nord Europa o autoctoni?
Le origini degli Etruschi sono ancora oggi oggetto di dibattito tra gli studiosi. Esistono diverse teorie, spesso contrastanti:
- Origine orientale (Lidia): Secondo lo storico greco Erodoto, gli Etruschi sarebbero giunti in Italia dalla Lidia, una regione dell’Asia Minore, a seguito di una carestia.
- Origine settentrionale (Nord Europa): Un’altra teoria, meno accreditata, ipotizza una provenienza dal Nord Europa, basandosi su alcune somiglianze culturali e linguistiche.
- Origine autoctona: La teoria più diffusa oggi è che gli Etruschi siano il risultato dell’evoluzione della cultura villanoviana, una civiltà dell’età del ferro presente in Italia centrale, con possibili apporti di popolazioni orientali giunte in Italia nel II millennio a.C.
La storia degli Etruschi: dall’ascesa al declino
L’espansione etrusca in Italia (IX-VI secolo a.C.)
A partire dal IX secolo a.C., gli Etruschi iniziarono a sviluppare una civiltà fiorente, espandendosi dall’Etruria verso altre regioni d’Italia. Fondarono numerose città, tra cui Veio, Tarquinia, Cerveteri, Vulci, Chiusi, Perugia, Volterra e altre.
La struttura sociale: dalle città-stato all’aristocrazia
Gli Etruschi non formarono mai uno stato unitario, ma erano organizzati in una serie di città-stato indipendenti, spesso in conflitto tra loro. Inizialmente, ogni città era governata da un re (lucumone), ma a partire dalla fine del VI secolo a.C., il potere passò nelle mani di un’aristocrazia terriera, che controllava la vita politica ed economica.
L’economia etrusca: agricoltura, artigianato e commercio
L’economia etrusca si basava inizialmente sull’agricoltura (cereali, vite, olivo), sull’allevamento (bovini, ovini, suini), sull’artigianato (ceramica, metallurgia, oreficeria) e sullo sfruttamento delle risorse minerarie (ferro, rame, piombo). Grazie alla loro abilità nella navigazione, gli Etruschi divennero una potenza marittima e commerciale, controllando le rotte del Mediterraneo nord-occidentale e commerciando con Greci, Fenici e Cartaginesi.
Il declino e la conquista romana (V-I secolo a.C.)
A partire dal V secolo a.C., la civiltà etrusca iniziò a declinare, a causa di diversi fattori: la pressione dei Celti da nord, l’espansione dei Greci nel Mediterraneo, le rivolte interne e, soprattutto, l’ascesa di Roma. Nel corso dei secoli successivi, i Romani conquistarono progressivamente le città etrusche, fino alla completa sottomissione dell’Etruria nel I secolo a.C. Un evento fondamentale fu la conquista e la distruzione di Veio nel 396 a.C.
La cultura etrusca: arte, religione e vita quotidiana
L’arte etrusca: periodi, influenze e caratteristiche
L’arte etrusca è convenzionalmente suddivisa in cinque periodi principali:
- Periodo Villanoviano (900-720 a.C.): caratterizzato da una produzione artigianale di oggetti in ceramica e metallo, con decorazioni geometriche.
- Periodo Orientalizzante (720-580 a.C.): influenzato dall’arte orientale (fenicia, egizia, assira), con l’introduzione di nuovi materiali (oro, avorio) e nuove tecniche (granulazione).
- Periodo Arcaico (580-480 a.C.): influenzato dall’arte greca arcaica, con la produzione di sculture in terracotta e pietra, e di affreschi nelle tombe.
- Periodo Classico (480-320 a.C.): caratterizzato da un maggiore realismo e da una maggiore attenzione alla resa dei dettagli.
- Periodo Ellenistico (320-27 a.C.): influenzato dall’arte greca ellenistica, con una produzione artistica più eclettica e meno originale.
La pittura etrusca: gli affreschi delle tombe
La pittura etrusca è conosciuta soprattutto grazie agli affreschi che decorano le pareti delle tombe. Questi affreschi, realizzati con colori vivaci ottenuti da sostanze minerali, raffigurano scene di vita quotidiana, banchetti, giochi, danze, cerimonie religiose e scene mitologiche. La pittura etrusca è influenzata dall’arte greca, ma presenta anche caratteristiche originali, come l’uso di tinte piatte, la rappresentazione del corpo umano con parti frontali e parti di profilo, e una maggiore vivacità e dinamismo delle figure.
La scultura etrusca: argilla e bronzo
A differenza dei Greci, gli Etruschi non utilizzavano molto la pietra o il marmo per le loro sculture, ma preferivano l’argilla (terracotta), un materiale facilmente reperibile nel loro territorio e che permetteva una lavorazione più rapida e immediata. Le sculture etrusche avevano principalmente una funzione funeraria, rituale o votiva. Erano anche abili nella lavorazione del bronzo, utilizzato per realizzare statue, utensili, armi e oggetti decorativi.
L’architettura etrusca: templi e città
L’architettura etrusca è conosciuta soprattutto grazie ai resti delle città, delle necropoli e dei templi. Le case etrusche erano costruite con materiali deperibili (legno, mattoni crudi), per questo motivo ne sono rimaste poche tracce. Il tempio etrusco aveva una struttura caratteristica, descritta da Marco Vitruvio Pollione nel suo trattato De Architectura. Era caratterizzato da una pianta quasi quadrata, con un’ampia parte anteriore porticata (prònao) e una parte posteriore divisa in tre celle, dedicate alle principali divinità del pantheon etrusco (Tinia, Uni, Menerva). Le colonne erano in ordine tuscanico, simile all’ordine dorico greco ma con base e fusto liscio. Il tempio era riccamente decorato con elementi in terracotta policroma, come antefisse (elementi decorativi posti alla fine delle tegole) e acroteri (elementi decorativi posti sul colmo e agli angoli del tetto).
L’oreficeria etrusca: la tecnica della granulazione
Gli Etruschi erano abili artigiani e orafi, famosi per la loro maestria nella lavorazione dei metalli preziosi, in particolare dell’oro. Una delle tecniche più raffinate utilizzate dagli orafi etruschi era la granulazione, che consisteva nell’applicare minuscole sferette d’oro su una superficie metallica, creando decorazioni elaborate e dettagliate.
La religione etrusca: dei, aldilà e pratiche funerarie
La religione etrusca era politeista e caratterizzata da un forte legame con il mondo dell’aldilà. Gli Etruschi credevano che la vita continuasse dopo la morte, e per questo motivo dedicavano grande cura alla costruzione e alla decorazione delle tombe. Le tombe etrusche erano spesso ipogee (scavate sotto terra) o a tumulo (ricoperte da un cumulo di terra), ed erano organizzate come vere e proprie case, con diverse stanze e corridoi. Le pareti erano decorate con affreschi, e all’interno venivano deposti oggetti personali del defunto, cibo, bevande, armi, gioielli e altri beni che potessero essergli utili nell’aldilà. Tra le principali divinità etrusche c’erano Tinia (corrispondente al Giove romano), Uni (Giunone), Menerva (Minerva), Aplu (Apollo), Artumes (Artemide), Nethuns (Nettuno) e Voltumna.
La musica etrusca
La musica aveva un ruolo importante nella vita degli Etruschi, sia nelle cerimonie religiose che nei momenti di svago. Gli strumenti musicali più utilizzati erano la lira, la cetra, il flauto, la tromba e il corno.
L’eredità degli Etruschi e l’influenza su Roma
Anche se la civiltà etrusca fu assorbita da quella romana, la sua influenza sulla cultura, l’arte, la religione e le istituzioni di Roma fu profonda e duratura. I Romani adottarono dagli Etruschi molte usanze, come l’arte della divinazione (aruspicina), l’uso dell’arco in architettura, i giochi gladiatori, il sistema di numerazione e alcuni simboli del potere (come la toga e i fasci littori).
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia
Di Paperoastro – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21812217