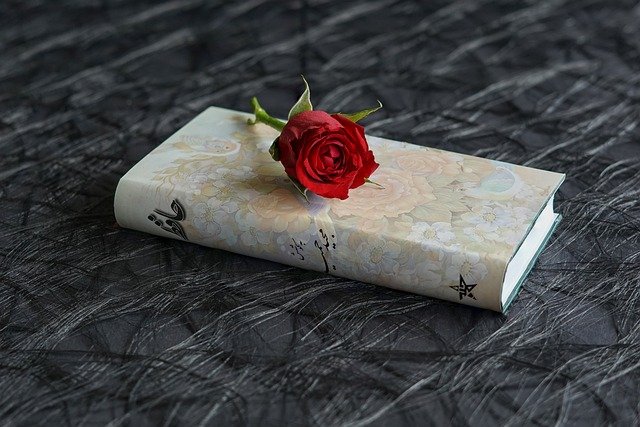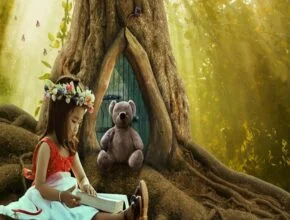Nell’arte poetica, ma non solo, ricorrono frequentemente alcuni “artifici”, modi particolari di servirsi delle parole che si allontanano dal normale uso linguistico e grammaticale: sono le cosiddette figure retoriche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Cosa sono le figure retoriche?
Le figure retoriche sono forme espressive, basate su una deviazione dal linguaggio comune, il cui scopo è quello di rendere il messaggio più efficace e suggestivo. La loro funzione è quella di comunicare una particolare carica emotiva. In poesia, ad esempio, la parola si carica di sensi diversi da quello letterale, e il poeta sente l’esigenza di potenziare l’efficacia delle immagini e di ravvivare il linguaggio per renderlo più espressivo. Si ricorre così a figure stilistiche e simboli che contribuiscano a dare forza, vigore e musicalità a quanto si intende comunicare. L’aggettivo “retorico” allude al fatto che si tratta di un abbellimento del linguaggio col quale si intende impressionare chi legge o ascolta. Le figure retoriche non sono esclusive dello stile letterario o poetico, ma ricorrono anche nel parlare quotidiano e in ogni tipo di linguaggio, come ad esempio quello pubblicitario.
Figure retoriche di suono: quali sono e a cosa servono?
Le figure retoriche di suono (o figure di suono) riguardano il livello delle strutture foniche, la ripetizione, il parallelismo, la musicalità dei suoni; modificano il suono delle parole per ottenere un effetto poetico, diverso da quello del linguaggio comune. Si tratta di espedienti stilistici che conferiscono alla lettura del testo un particolare suono: dolce, aspro, piano, solenne, vivace. Servono a creare particolari effetti acustici e a sottolineare concetti chiave attraverso la ripetizione o la combinazione di suoni.
Allitterazione
L’allitterazione è la ripetizione di una lettera (suono) o di un gruppo di lettere all’inizio o all’interno di più parole. Crea un effetto di musicalità e coesione.
Esempio:
Di me medesimo meco mi vergogno (F. Petrarca)
Assonanza
Due parole sono legate da assonanza quando nella loro parte finale (la parte che va dalla vocale che porta l’accento in poi) presentano le stesse vocali, ma diverse consonanti. L’assonanza crea un effetto di rima imperfetta, generando una musicalità più sottile.
Esempio:
Piove sui nostri volti silvani (G. D’Annunzio, da La pioggia nel pineto).
Consonanza
Due parole sono legate da consonanza quando nella loro parte finale (la parte che va dalla vocale che porta l’accento in poi) presentano le stesse consonanti, ma diverse vocali. Simile all’assonanza, ma con un focus sulle consonanti, crea un effetto di eco e di richiamo.
Esempio:
Tra gli scogli parlòtta la marétta (E. Montale, da Maestrale)
Onomatopea
L’onomatopea è una parola o una frase che riproduce il suono o il rumore di una cosa o il verso di un animale. L’onomatopea rende la descrizione più vivida e immediata, coinvolgendo il lettore a livello sensoriale.
Esempio:
Nei campi / c’è un breve gre-gre di ranelle (G. Pascoli, da La mia sera).
Paranomasia
La paranomasia è l’accostamento di due parole che presentano suoni simili ma significato diverso. Crea un gioco di parole che attira l’attenzione e può avere effetti umoristici o di enfasi.
Esempio:
sedendo e mirando (G. Leopardi, da L’Infinito)
La figura retorica della paranomasia non ricorre solo nel testo poetico ma anche nel parlato quotidiano (giochi di parole, frasi fatte, slogan pubblicitari), basti pensare a “detti” come “Ogni riccio un capriccio” o “Chi non risica non rosica”.
Figure retoriche di significato: quali sono e a cosa servono?
Le figure retoriche di significato, a differenza delle figure retoriche di suono, incidono sul significato della parola, ampliandolo, connotandolo e rendendolo diverso dal senso comune; in questo caso l’effetto è prodotto da un uso particolare del significato delle parole stesse ed è chiamato in causa soprattutto il lessico. Esse sono utilizzate sia in prosa, sia in poesia e anche nei cosiddetti modi di dire (es. mi piange il cuore). Le figure di significato servono a trasferire il significato da un termine a un altro, creando immagini vivide e concetti più profondi.
Antitesi
L’antitesi è l’accostamento di immagini o espressioni di senso opposto. Crea un contrasto che mette in risalto le differenze tra i termini accostati.
Esempio:
Pace non trovo e non ho da far guerra;
e temo e spero; e ardo e sono un ghiaccio;
e volo sopra ‘l cielo e giaccio in terra;
e nulla stringo e tutto ‘l mondo abbraccio. (F. Petrarca)
Ossimoro
L’ossimoro è l’accostamento di parole di significato contrario; a differenza dell’antitesi, i termini sono associati in un’unica espressione. L’ossimoro crea un effetto paradossale che stimola la riflessione.
Esempio:
bianca nel tacito tumulto (G. Pascoli)
Iperbole
L’iperbole è un’esagerazione per eccesso o per difetto. Viene usata per enfatizzare un concetto, spesso con effetti comici o drammatici.
Esempio:
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. (E. Montale)
Litote
La litote è l’affermazione di un concetto attraverso la negazione del suo contrario. È una forma di attenuazione che può rendere un’affermazione più elegante o ironica.
Esempio:
Il nostro Don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno. (A. Manzoni)
Ipallage
L’ipallage consiste nel riferire a un termine quel che è proprio di un altro termine della stessa frase. Crea uno spostamento logico che può sorprendere il lettore.
Esempio:
il divino del piano silenzio verde (G. Carducci)
[Invece di: “il divino silenzio del piano verde”]
Metonimia
La metonimia è la sostituzione di un termine con un altro che abbia con il primo rapporti di affinità logica e/o materiale. Permette di esprimere un concetto in modo indiretto, ma evocativo.
Esempi:
La causa per l’effetto: ma negli orecchi mi percosse un duolo (= un grido prodotto da una sensazione di dolore) (Dante).
L’effetto per la causa: talor lasciando le sudate carte (= i libri che mi facevano sudare per la fatica) (G. Leopardi).
La materia per l’oggetto fatto con essa: legno per “carrozza” o per “nave”.
Il contenente per il contenuto: bevo un bicchiere (=la quantità contenuta in un bicchiere).
L’autore dell’opera invece dell’opera: leggere Dante (= la Divina Commedia di Dante); comprare un Modigliani (= un quadro di Modigliani).
Il mezzo o lo strumento invece della persona che lo usa o della cosa da esso prodotta: essere una buona forchetta (=un buongustaio); essere il primo violino dell’orchestra (=il primo suonatore di violino).
Il concreto per l’astratto: avere fegato (=coraggio).
Similitudine
La similitudine è un paragone introdotto da elementi comparativi quali come, simile a, più di, ecc. Rende un concetto più chiaro attraverso il confronto con un altro elemento.
Esempio:
E caddi come corpo morte cade (Dante)
Metafora
La metafora consiste nel sostituire a una parola un’altra parola legata alla prima da un rapporto di somiglianza. Generalmente, viene considerata una “similitudine abbreviata”, perché realizza in forma immediata e sintetica il rapporto di somiglianza che di solito viene presentato in forma analitica mediante una similitudine o una comparazione (per mezzo di connettivi: come… così; tale… quale; similmente). Così la metafora Sei una volpe altro non è che l’abbreviazione della similitudine Sei furbo come una volpe. La metafora crea immagini potenti e suggestive, trasferendo qualità da un oggetto all’altro.
Sineddoche
La sineddoche consiste nell’indicare una cosa non con il suo solito nome, ma con un altro che ha il significato più o meno ampio, e simile. È un tipo di sostituzione che si basa su una relazione di quantità.
Esempi:
la parte per il tutto: il mare è pieno di vele (= barche a vela)
il tutto per la parte: ha gli occhi celesti (= solo l’iride non tutto l’occhio)
il genere per la specie: i mortali (= gli uomini); il felino (= il gatto)
la specie per il genere: mi guadagno il pane (= cibo)
il singolare per il plurale: il cane (= i cani) è un animale fedele
il plurale per il singolare: non litigare con gli amici (= con un particolare amico)
la materia per l’oggetto: nella destra ha il ferro (= la spada)
Sinestesia
La sinestesia associa sensazioni appartenenti a sfere sensoriali diverse, fondendole in un’unica immagine. Crea un effetto di fusione sensoriale che rende la descrizione più originale e coinvolgente.
Esempio:
L’odorino amaro (G. Pascoli)
(L’odore si percepisce con l’olfatto, l’amaro con il gusto).
Personificazione
La personificazione è l’attribuzione di caratteristiche umane a oggetti inanimati o animali. Rende più vivida una descrizione, attribuendo sentimenti o azioni umane a ciò che umano non è.
Esempio:
Laudata sii per il tuo viso di perla, o Sera (G. D’Annunzio)
Figure retoriche di posizione (o dell’ordine delle parole)
Le figure retoriche di posizione, o figure dell’ordine, riguardano la disposizione delle parole all’interno della frase, e si discostano dall’ordine sintattico “normale” (soggetto-verbo-complemento) per creare particolari effetti stilistici. Queste figure giocano con l’ordine delle parole per dare enfasi, ritmo o un particolare effetto espressivo.
Anafora
L’anafora è la ripetizione di una o più parole all’inizio di frasi o versi successivi. Crea un effetto di insistenza e di ritmo incalzante, sottolineando un concetto chiave.
Esempio:
Per me si va ne la città dolente,
Per me si va ne l’etterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente. (Dante, Inferno, Canto III)
Epifora
L’epifora è la ripetizione della stessa parola o gruppo di parole alla fine di frasi o versi successivi. Speculare all’anafora, crea un effetto di enfasi e di circolarità.
Esempio:
Presto verrò, come il vento che passa,
come la nuvola bianca che passa,
come l’ombra della sera che passa(Autore inventato per l’esempio).
Anastrofe
L’anastrofe è l’inversione dell’ordine normale di due o più parole all’interno di una frase. L’anastrofe mette in risalto un termine specifico, spostandolo dalla sua posizione consueta.
Esempio:
All’opre femminili intenta sedevi (invece di “sedevi intenta all’opre femminili”) (Leopardi, A Silvia).
Iperbato
L’iperbato è l’inserimento di una o più parole tra due elementi che dovrebbero essere sintatticamente uniti, creando una separazione. L’iperbato crea un effetto di sospensione e può mettere in risalto sia gli elementi separati sia la parola inserita.
Esempio:
Molti di pietà videro il volto (invece di “videro il volto di molti”)
Chiasmo
Il chiasmo è una disposizione incrociata di elementi corrispondenti in due frasi o versi. Gli elementi possono essere legati per significato o per forma grammaticale. Il chiasmo crea un effetto di simmetria e di equilibrio, spesso evidenziando un’antitesi o un parallelismo.
Esempio:
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori (Ariosto, Orlando Furioso – Proemio) (sostantivo, sostantivo, sostantivo, sostantivo, in ordine A-B-B-A).
Altro esempio:
Vizi privati, pubbliche virtù. (A-B, B’-A’)
L’uso delle figure retoriche nella comunicazione moderna
Le figure retoriche, sia di suono che di significato, mantengono un ruolo importante anche nella comunicazione moderna. Non le troviamo, infatti, solo all’interno di poesie e opere letterarie, ma sono ampiamente utilizzate nella pubblicità, nei discorsi politici, nel giornalismo e persino nel linguaggio quotidiano. Uno slogan come “Red Bull ti mette le ali” è un chiaro esempio di metafora (e iperbole) usata a fini commerciali. L’efficacia di questi strumenti retorici risiede nella loro capacità di rendere il messaggio più memorabile, persuasivo e coinvolgente. La conoscenza delle figure retoriche, quindi, non è utile solo per l’analisi letteraria, ma anche per comprendere meglio come funziona la comunicazione a tutti i livelli.
Fonte immagine per l’articolo: Pixabay
Nunzia Serino