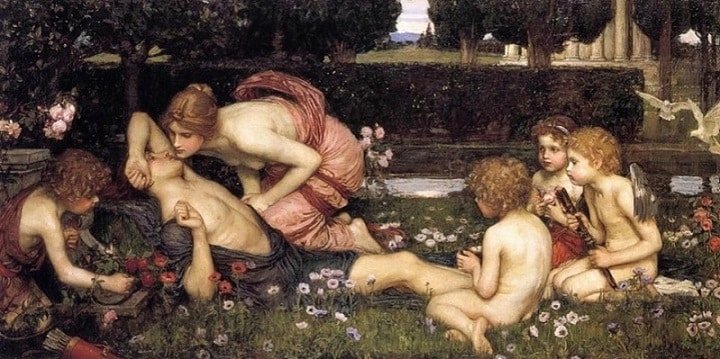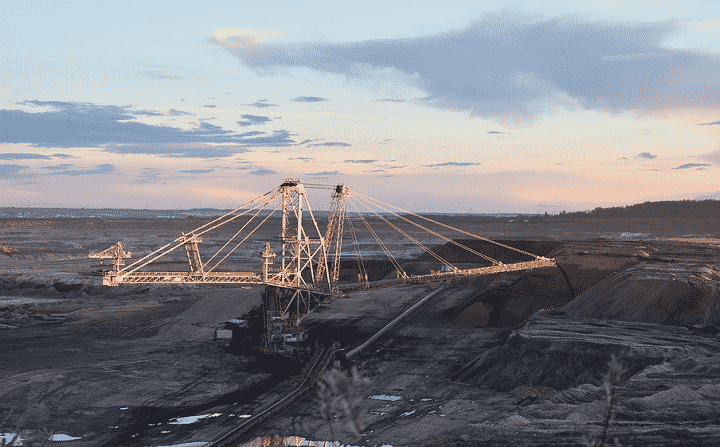Imperatori di Roma: da Augusto a Romolo Augustolo, storia e dinastie
Gli imperatori di Roma hanno contribuito ad alimentare la fama e la notorietà non solo della Capitale, ma di tutto il vasto territorio che negli anni era stato conquistato grazie all’abilità dei generali e alla potenza dell’esercito romano. Cospirazioni, segreti, leggende e misteri ruotano intorno alla figura dei grandi imperatori di Roma, alcuni degni di lode, altri dalla moralità e dalla condotta discutibili. La storia di Roma, dalla fine del Principato di Augusto, nel 14 d.C., fino al crollo dell’Impero romano d’Occidente, nel 476 d.C., è un susseguirsi di eventi epocali, che hanno segnato profondamente non solo la storia dell’Urbe, ma quella di tutta l’Europa e del Mediterraneo.
Questo articolo vuole essere un excursus, una panoramica sui principali imperatori romani, sulle loro gesta, sulle loro personalità e sulle dinastie a cui appartennero, per comprendere al meglio un periodo storico di fondamentale importanza. Dalla dinastia Giulio-Claudia a quella Flavia, dall’età adottiva, considerata uno dei periodi più floridi dell’Impero romano, fino alla crisi del III secolo, alla tetrarchia di Diocleziano e alla definitiva divisione tra Impero romano d’Occidente e Impero romano d’Oriente, si delinea un affresco storico di grande fascino e complessità. Si parlerà di imperatori del calibro di Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Tito, Domiziano, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Diocleziano, Costantino, Teodosio e Romolo Augustolo.
La dinastia Giulio-Claudia: da Augusto a Nerone (14-68 d.C.)
La dinastia Giulio-Claudia segna l’inizio dell’Impero romano, dopo la crisi della Repubblica. Alla sua morte, Ottaviano Augusto, primo imperatore e fondatore del Principato, designa come suo successore il figlio della moglie Livia Drusilla Augusta, Tiberio, il quale prende il nome dal padre naturale Tiberio Claudio Nerone.
Tiberio: l’imperatore schivo e il ritiro a Capri
Tiberio era detto l’ “imperatore schivo” per via del suo carattere riservato e della sua politica prudente, rispettosa delle prerogative del Senato romano. Dopo le vittorie contro i Germani e contro i Parti, aleggiò il sospetto che avesse avvelenato il nipote Germanico, geloso della sua popolarità di condottiero valoroso. Iniziò una serie di processi di lesa maestà che portarono l’imperatore, ormai stanco, ad abbandonare Roma nelle mani del prefetto del pretorio Seiano e a rifugiarsi nella sua lussuosa villa a Capri.
Caligola: tra follia e dispotismo, la nomina del cavallo senatore
Alla morte di Tiberio il Senato acclamò imperatore suo nipote Gaio, figlio di Germanico, detto Caligola per via della particolare calzatura militare (caliga) che da piccolo era solito indossare. Il suo breve impero, durato solo quattro anni, fu caratterizzato dall’eliminazione fisica degli oppositori e dai continui atti di umiliazione della classe senatoria: tradizione vuole che Caligola abbia addirittura nominato senatore il proprio cavallo Incitatus. Il suo strapotere lo rese inviso ai pretoriani che ordirono una congiura che gli risultò fatale.
Claudio: l’imperatore zoppo, tra burocrazia e conquiste
Gli stessi pretoriani che avevano ucciso Caligola nominarono come nuovo imperatore Claudio, un suo anziano zio, il quale ebbe il merito di aver reso la burocrazia di Stato molto più efficiente e di aver conquistato la Britannia, sottomettendone la parte meridionale e trasformandola in provincia. La sua vita privata fu particolarmente intricata: sposò in terze nozze Messalina, dipinta da Tacito come una vera e propria meretrice, la quale fu condannata a morte e alla damnatio memoriae tra la totale indifferenza del marito, intento a consumare il suo pasto durante un banchetto. Successivamente sposò la nipote Agrippina, già madre di Nerone, che per garantire l’ascesa al trono al figlio fece avvelenare Claudio.
Nerone: l’incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani
L’impero di Nerone può essere suddiviso in due fasi: la prima positiva, grazie all’influenza del prefetto del pretorio Burro e del filosofo Seneca, la seconda negativa, per via della sua politica violenta e sanguinaria iniziata con il matricidio. Tristemente noto è l’incendio di Roma del 64, la cui colpa ricadde sulla comunità cristiana, dando vita ad una terribile persecuzione. Si ritiene, invece, che sia stato lo stesso Nerone a causare l’incendio per poter costruire la sua fastosa villa, nota come Domus aurea. Dopo aver duramente represso la congiura dei Pisoni, tra le cui vittime illustri ci furono Lucano, Petronio e lo stesso Seneca, l’imperatore rimase completamente isolato e fu costretto al suicidio.
La dinastia Flavia e il consolidamento dell’impero (69-96 d.C.)
Nel 69 l’esercito nominò imperatore Vespasiano, homo novus di famiglia equestre, che grazie ad una legge ad hoc concentrò nelle sue mani tutti i poteri dei suoi predecessori. Egli consolidò i confini, garantendo all’impero pace e stabilità. Durante la dinastia Flavia, ci fu una ripresa economica e un rafforzamento del potere centrale.
Vespasiano: l’homo novus e la costruzione del Colosseo
Vespasiano promosse la costruzione dell’Anfiteatro Flavio, che sarà completato da Domiziano nell’80, che prese il nome di Colosseo dal colosso di Nerone, l’enorme statua che all’epoca era situata lì vicino.
Tito: l’imperatore “delizia del genere umano” e l’eruzione del Vesuvio
Suo figlio Tito divenne imperatore nel 79 e fu soprannominato “delizia del genere umano” grazie alla sua clemenza. Il suo impero fu breve e funestato da due disastrosi eventi: l’eruzione del Vesuvio del 79 che distrusse le città di Pompei, Ercolano e Stabia, e l’incendio di Roma l’anno successivo. Alla sua morte, nell’81, fu divinizzato come i suoi predecessori Cesare, Augusto, Claudio e Vespasiano.
Domiziano: il tiranno e la fine della dinastia
A differenza del fratello Tito, Domiziano fu visto come un tiranno e per questo motivo finì assassinato in una congiura. Nonostante ciò, ottenne risultati positivi in politica estera grazie alla creazione di una zona cuscinetto tra il Reno e il Danubio, il cosiddetto limes, e al consolidamento del dominio romano in Britannia. Con la morte di Domiziano, si estinse la dinastia Flavia.
L’impero adottivo: l’età dell’optimus princeps (96-192 d.C.)
Poiché nessuno degli imperatori di Roma del II secolo ebbe discendenti diretti, essi dovettero adottare una persona estranea alla loro famiglia, scelto in base alle sue doti politiche e militari, un optimus princeps la cui autorità fosse accettata da tutti. Questo periodo, noto come impero adottivo, fu caratterizzato da una grande stabilità politica e da una notevole prosperità economica.
Traiano: l’imperatore provinciale e l’espansione dell’impero
Traiano fu il primo imperatore provinciale: egli riformò l’amministrazione, risanò le casse dello Stato, bonificò le paludi pontine, fece edificare il Foro Traiano ed estese i confini dell’impero a Dacia, Siria e Regno dei Parti, raggiungendo la massima estensione territoriale dell’Impero romano.
Adriano: il difensore dei confini e la diaspora degli Ebrei
Adriano, proveniente dall’aristocrazia spagnola, cosmopolita e amante della cultura greca, condusse una politica estera difensiva. Fece costruire il Vallo di Adriano per proteggere i confini a nord dell’impero e domò la rivolta scoppiata in Giudea tra il 132 e il 135, provocando la diaspora degli Ebrei. Tra gli imperatori di Roma più interessanti.
Antonino Pio e Marco Aurelio: la filosofia al potere
I suoi successori, Antonino Pio e Marco Aurelio, si distinsero per la politica pacifica, tesa al consolidamento dei confini e al miglioramento del tenore di vita degli schiavi. Marco Aurelio, in particolare, fu un imperatore-filosofo seguace dello stoicismo, volto alla ricerca della tranquillità dell’animo, attraverso la moderazione delle passioni e il rispetto dei doveri del civis romanus. Con la nomina di suo figlio Commodo come suo successore, venne violato il principio di adozione, facendo sprofondare l’impero in un’epoca buia di anarchia militare.
Da Diocleziano a Romolo Augustolo: la tetrarchia e la caduta di Roma (284-476 d.C.)
Nel 284 il potere era passato nelle mani di Diocleziano che era riuscito a ripristinare l’ordine nell’impero e a difenderne efficacemente i confini. Egli diede vita ad una tetrarchia, “governo dei quattro”, insieme a Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio, in modo da poter amministrare e gestire meglio il vastissimo territorio imperiale, che si estendeva dalla Spagna al Ponto. Questo periodo segna il passaggio dal Principato al Dominato, con un potere imperiale sempre più centralizzato e assolutistico.
Diocleziano: il ripristino dell’ordine e la persecuzione dei cristiani
Tra il 303 e il 304 Diocleziano avviò una dura campagna di persecuzioni anticristiane e a questi provvedimenti seguì un’ondata di arresti e condanne a morte che non riuscì comunque ad impedire la diffusione del cristianesimo.
Costantino e Teodosio: il cristianesimo da religione perseguitata a religione di Stato
Sarà soltanto nel 313, grazie all’editto di Milano promulgato dall’imperatore Costantino, che i cristiani otterranno liberà di culto e nel 380, con l’editto di Tessalonica emanato in seguito da Teodosio, il cristianesimo diventa religione ufficiale dell’impero.
La divisione dell’impero e la fine di Roma
Alla morte di Teodosio l’impero si divide tra i suoi figli Onorio, che ottiene l’Occidente, e Arcadio, che governa in Oriente. I due imperi avranno sorti diverse: l’Impero romano d’Occidente crolla nel 476 d.C., quando Odoacre depone Romolo Augustolo, mentre quello d’Oriente durerà fino al 1453, anno in cui i Turchi ottomani invasero Costantinopoli, segnando la fine di un’epoca potente e gloriosa.
Fonte immagine per l’articolo sugli imperatori di Roma: Pixabay