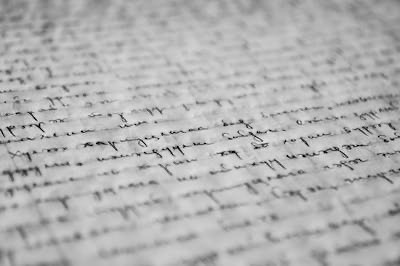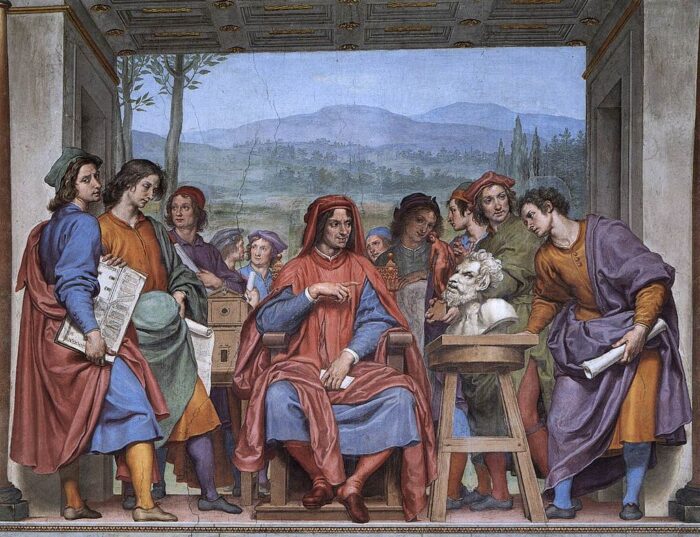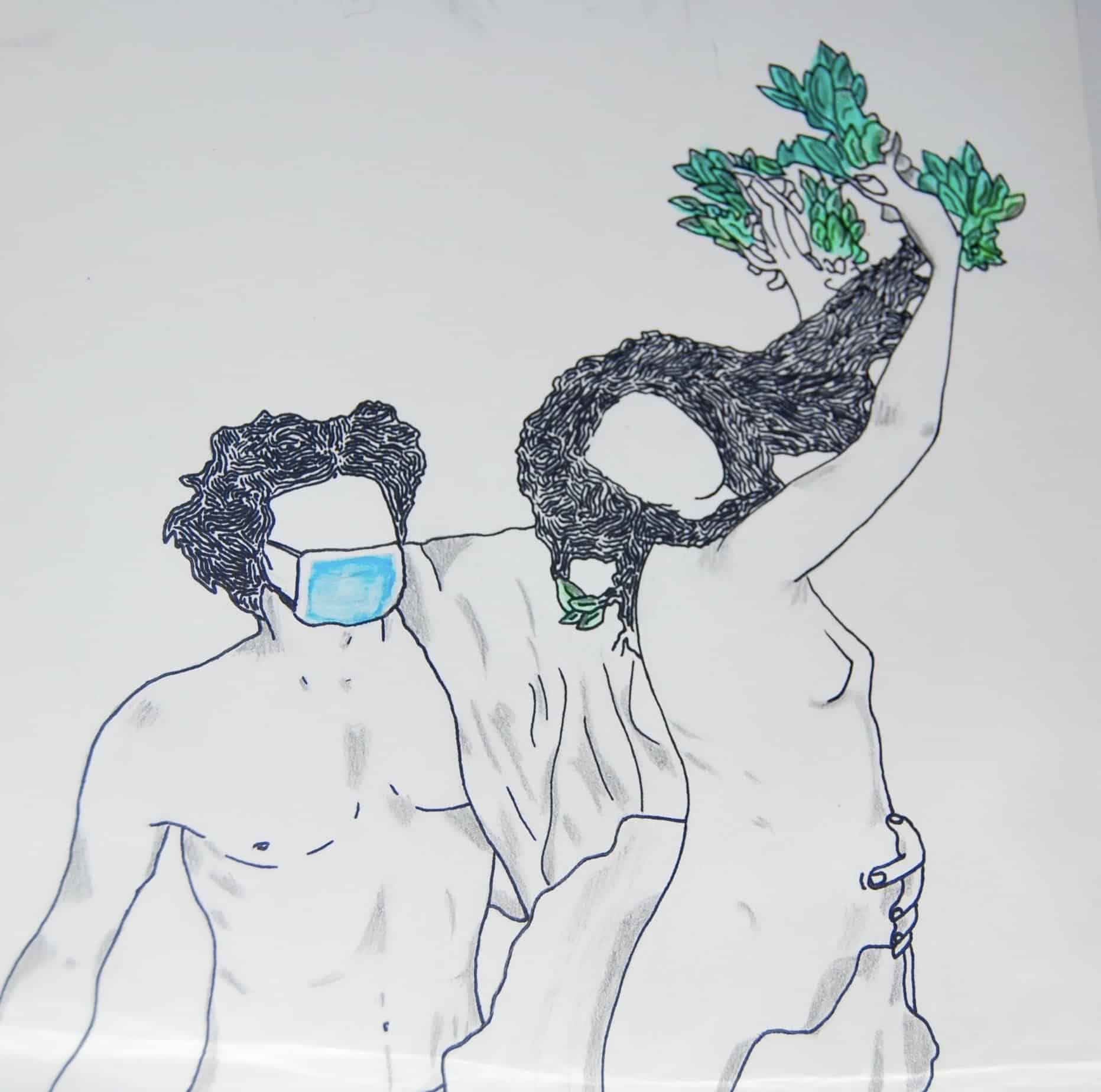Scrittura etrusca: storia e caratteristiche dell’alfabeto
La scrittura etrusca, con il suo *fascino misterioso* e la sua storia millenaria, rappresenta da secoli un’affascinante area di studi per linguisti e storici. La civiltà etrusca, sviluppatasi nell’area *mediotirrenica* dell’Italia centrale tra il IX e il I secolo a.C., fu la prima in Italia ad adottare un sistema di scrittura alfabetico, derivato da quello greco, ma con caratteristiche proprie e peculiari. La decifrazione completa di questo alfabeto è un importante traguardo dell’*epigrafia etrusca* che ci permette di comprendere meglio la cultura, la religione e la vita quotidiana di questo popolo. In questo articolo ripercorreremo le tappe fondamentali della storia della scrittura etrusca, analizzeremo le sue caratteristiche distintive, metteremo in evidenza le influenze subite e le modifiche apportate nel corso del tempo. Attraverso l’analisi dei reperti archeologici, come la celebre tavoletta di Marsiliana d’Albegna, e delle iscrizioni pervenuteci, ricostruiremo il percorso che ha portato alla nascita e all’evoluzione dell’alfabeto utilizzato in *Etruria*.
Le origini della scrittura etrusca: un’introduzione
L’introduzione della scrittura tra le popolazioni italiche è un evento di portata storica, che segna il passaggio dalla protostoria alla storia. Gli Etruschi, stanziati in un’area geografica che comprendeva l’odierna Toscana, l’Umbria occidentale e il Lazio settentrionale, furono i primi a fare questo importante passo, adottando un sistema di scrittura alfabetico derivato da quello greco. Si stima che l’introduzione della scrittura in *Etruria* sia avvenuta intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. Un’antica leggenda, riportata da fonti latine, attribuisce l’introduzione dell’alfabeto in Italia a Demarato di Corinto, padre del re di Roma Tarquinio Prisco. Al di là del mito, è certo che l’alfabeto etrusco derivi da una variante occidentale dell’alfabeto greco, probabilmente quella *euboica*, diffusa nelle colonie greche dell’Italia meridionale. I ritrovamenti di iscrizioni in varie città dell’Etruria, come Tarquinia, Cerveteri, Veio e Vulci, testimoniano l’ampia diffusione della scrittura in tutta l’area.
L’influenza greca sull’alfabeto etrusco: il ruolo dei coloni
Il processo di acquisizione dell’alfabeto greco da parte degli Etruschi avvenne attraverso i contatti con i coloni greci stanziati in Campania, in particolare nelle città di *Cuma* e *Pitecusa* (l’odierna Ischia). Questi insediamenti, fondati a partire dall’VIII secolo a.C., fungevano da tramite per la diffusione della cultura greca in Italia. *Cuma*, in particolare, fondata da coloni provenienti dall’isola di Eubea, ha avuto un ruolo importante nella trasmissione dell’alfabeto *greco euboico*.
I primi contatti con la scrittura: Cuma e le colonie greche
Gli Etruschi entrarono in contatto con la scrittura attraverso gli scambi commerciali con le colonie greche. Gli oggetti importati dalla Grecia, come vasi e anfore, recavano spesso iscrizioni in alfabeto greco, che inizialmente vennero imitate dagli Etruschi a scopo decorativo. In seguito, gli Etruschi compresero l’utilità della scrittura come strumento di comunicazione e iniziarono ad adattare l’alfabeto greco alle esigenze fonetiche della propria lingua. Questo processo di adattamento, avvenuto in maniera graduale, portò alla formazione di un alfabeto con caratteristiche proprie, diverso da quello greco originario. I reperti archeologici rinvenuti a *Cuma* e *Pitecusa*, oggi conservati in parte presso il *Museo archeologico nazionale di Napoli*, testimoniano questo processo di interazione culturale.
L’alfabeto etrusco: un sistema di scrittura in evoluzione
L’alfabeto etrusco, pur derivando da quello greco, presenta caratteristiche peculiari che lo rendono un sistema di scrittura autonomo e originale. Nel corso dei secoli, l’alfabeto etrusco subì diverse modifiche e adattamenti, riflettendo l’evoluzione della lingua parlata e le influenze culturali esterne. Lo studio di queste modifiche, attraverso l’analisi delle iscrizioni rinvenute, è fondamentale per comprendere la storia della *linguistica etrusca*.
Adattamenti fonetici e differenze con l’alfabeto greco
L’adattamento dell’alfabeto greco alla lingua etrusca comportò l’eliminazione di alcune lettere e la modifica di altre. Gli Etruschi, infatti, si resero presto conto che alcuni suoni presenti nella lingua greca non esistevano nella loro lingua, e viceversa. Ad esempio, la lingua etrusca non possedeva le consonanti sonore /b/, /d/ e /g/, né la vocale /o/. Di conseguenza, le lettere greche beta, delta e omicron vennero eliminate o utilizzate con valore fonetico diverso.
Lettere eliminate e suoni non corrispondenti
Come accennato, le lettere greche beta (Β) e delta (Δ) furono eliminate dall’alfabeto etrusco, in quanto non esistevano i suoni corrispondenti nella lingua etrusca. La lettera omicron (Ο), invece, venne probabilmente pronunciata come una /u/ e trascritta con la lettera upsilon (Υ), già presente nell’alfabeto greco. Altre modifiche riguardarono l’utilizzo del sigma e del san. Queste differenze fonetiche tra le due lingue hanno portato gli studiosi a ipotizzare che l’etrusco non fosse una lingua indoeuropea e che potesse avere un’*origine* come *sostrato linguistico* di popolazioni preesistenti.
La tavoletta di Marsiliana d’Albegna: il più antico esempio di alfabeto etrusco
Uno dei reperti più importanti per lo studio della scrittura etrusca è la tavoletta di Marsiliana d’Albegna, rinvenuta nel 1908 nella necropoli della Banditella, in *Maremma*. Si tratta di una tavoletta d’avorio, databile intorno al 670 a.C., che riporta inciso, sul bordo, un alfabeto etrusco completo di 26 lettere, disposte in ordine alfabetico. Si tratta del più antico esempio di alfabeto etrusco completo a noi pervenuto e rappresenta una testimonianza fondamentale per la ricostruzione della storia di questo sistema di scrittura. Oltre alla tavoletta, nella tomba sono stati rinvenuti altri oggetti legati alla scrittura, come uno stilo in avorio, una spatola per lisciare la cera e frammenti di tavolette scrittorie in legno.
Caratteristiche della tavoletta e sua importanza storica
La tavoletta di Marsiliana d’Albegna, di piccole dimensioni (8,8 x 5 cm), è un reperto di eccezionale valore storico. La presenza di un alfabeto completo, inciso in ordine, dimostra che la tavoletta aveva una funzione didattica o di modello per la scrittura. La sequenza delle lettere è quasi identica a quella dell’alfabeto greco *euboico*, confermando la derivazione dell’alfabeto etrusco da quest’ultimo. La tavoletta di Marsiliana è importante non solo come testimonianza dell’alfabeto etrusco arcaico, ma anche come prova dell’elevato livello di alfabetizzazione raggiunto dagli Etruschi già nel VII secolo a.C.
Dove si trova la tavoletta di Marsiliana?
La tavoletta di Marsiliana d’Albegna, dopo il suo rinvenimento, è stata trasferita a Firenze ed è attualmente conservata ed esposta presso il *Museo Archeologico Nazionale di Firenze*. Rappresenta uno dei pezzi più preziosi della collezione etrusca del museo e attira l’attenzione di studiosi e appassionati da tutto il mondo. Assieme alla tavoletta, nel *Museo Archeologico Nazionale di Firenze* sono esposti anche gli altri oggetti scrittori rinvenuti nella stessa tomba, che offrono una straordinaria testimonianza della cultura materiale legata alla scrittura in *Etruria*.
Peculiarità della scrittura etrusca
Oltre alle differenze fonetiche e grafiche rispetto all’alfabeto greco, la scrittura etrusca presenta altre caratteristiche peculiari che la rendono un sistema di scrittura unico nel suo genere. Queste peculiarità riguardano la direzione della scrittura, l’uso della punteggiatura e la spaziatura tra le parole. Lo studio di queste caratteristiche, attraverso l’analisi delle iscrizioni, permette di approfondire la conoscenza delle pratiche scrittorie in uso presso gli Etruschi.
Scrittura da destra a sinistra e bustrofedica
Una delle caratteristiche più evidenti della scrittura etrusca è la direzione della scrittura, che procede da destra verso sinistra, al contrario di quella greca e latina. Questo andamento *destrorso* è presente nella maggior parte delle iscrizioni etrusche, anche se esistono esempi di scrittura *bustrofedica*, in cui le righe si alternano, procedendo da destra a sinistra e da sinistra a destra, come i solchi tracciati da un aratro trainato da buoi (*bustrofedico* deriva dal greco *bous*, bue, e *strephein*, volgere). La scrittura *bustrofedica* è attestata soprattutto nelle iscrizioni più antiche e tende a scomparire in quelle più recenti.
La mancanza di spazi tra le parole e la punteggiatura nella scrittura etrusca
Un’altra caratteristica della scrittura etrusca è l’assenza di spazi tra le parole. Le parole, infatti, venivano scritte di seguito, senza interruzioni, rendendo a volte difficile la lettura e l’interpretazione delle iscrizioni. Per separare le parole, gli Etruschi utilizzavano un sistema di interpunzione costituito da uno o più punti, generalmente due o tre, allineati verticalmente. Questo sistema di interpunzione, sebbene non sempre utilizzato in modo sistematico, rappresenta un importante ausilio per la lettura e la comprensione dei testi etruschi.
Supporti scrittori e tipologie di testi
Gli etruschi scrivevano su una grande varietà di supporti, utilizzando diverse tecniche di scrittura. La scelta del supporto dipendeva dalla tipologia del testo e dalla sua funzione. I materiali più utilizzati erano la ceramica, il metallo, la pietra, l’avorio, il lino e, probabilmente, anche il papiro e le tavolette cerate, anche se di questi ultimi materiali non ci sono pervenuti reperti a causa della loro deperibilità.
Materiali utilizzati per la scrittura
Tra i supporti scrittori più comuni in *Etruria* vi erano le urne cinerarie, i vasi, le lamine metalliche, gli specchi, i cippi funerari e le pareti delle tombe. Per scrivere su questi supporti, gli Etruschi utilizzavano la tecnica dell’incisione, per la quale si servivano di strumenti appuntiti, come stiletti e scalpelli. Per la scrittura su papiro o tavolette cerate, invece, si utilizzavano pennelli e inchiostro, come testimoniato dal ritrovamento di calamai in alcune tombe etrusche. Altri esempi importanti di *scrittura etrusca* sono le *Lamine di Pyrgi*, il *Cippo di Perugia*, il *Disco di Magliano* e la *Tegola di Capua*.
Tipologie di iscrizioni delle scrittura etrusca: funerarie, religiose e letterarie
La maggior parte delle iscrizioni etrusche a noi pervenute è di carattere funerario o religioso. Le iscrizioni funerarie, incise su urne, sarcofagi e cippi, riportano il nome del defunto, la sua genealogia e, a volte, una breve formula di saluto. Le iscrizioni religiose, invece, si trovano su oggetti votivi, come statuette e lamine metalliche, e riportano il nome della divinità a cui l’oggetto è dedicato, accompagnato da una formula di offerta. Un esempio particolare di testo religioso è il *Liber Linteus*, un lungo testo rituale scritto su un telo di lino, oggi conservato a Zagabria. Le divinità erano una parte importante della vita degli etruschi.
La perduta letteratura etrusca
Oltre alle iscrizioni funerarie e religiose, sappiamo che esisteva una *letteratura etrusca*, di cui, però, non ci è pervenuta alcuna testimonianza diretta. Fonti latine, come Tito Livio e Varrone, accennano all’esistenza di *libri* etruschi di carattere storico, religioso e divinatorio, ma di queste opere non è rimasta traccia. La perdita della *letteratura etrusca* è una delle lacune più gravi nella nostra conoscenza di questo popolo e ci priva di una fonte preziosa per la comprensione della loro cultura e della loro visione del mondo. Una delle poche testimonianze indirette di opere letterarie etrusche è la menzione, da parte di fonti latine, di tragedie scritte dall’imperatore Claudio in lingua etrusca, purtroppo andate perdute. La *letteratura etrusca* rimane quindi, ad oggi, un mistero, che alimenta la curiosità e lo studio di questo affascinante popolo dell’Italia antica.
Fonte immagine: *Pexels*.