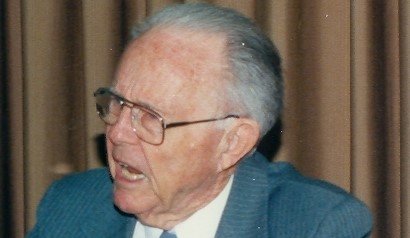Dalla lettura alla produzione, fino alla pubblicazione: dietro a ogni libro pubblicato si nascondono tante fasi e tante figure dell’editoria chiamate a destreggiarsi tra le intenzioni dell’autore e quelle dell’editore.
Per inquadrare la figura dell’editore iperlettore è utile prendere in prestito una citazione del critico e studioso di teoria letteraria Stanley Fish: «È il lettore che fa la letteratura».
L’espressione, per quanto provocatoria, ha una sua verità; facendo appello al concetto di «comunità interpretativa», Fish sostiene che la «produzione di significato» della letteratura è determinata dalla comunità dei lettori, i quali, per tacito accordo, decidono in che cosa consiste questa letteratura, cosa è interessante, quindi anche cosa è pubblicabile.
Se l’editore è colui che sa intuire quali «testi di autori» possono diventare «libri di lettori» – fiutandone la pubblicabilità – ed è il mediatore tra le istanze degli scrittori e la domanda dei lettori, è chiaro che, per valutare cosa sarà letteratura, deve farsi egli stesso lettore. Anzi, iperlettore, dal prefisso greco ὑπέρ, “per conto di”, secondo la fortunata definizione del Professore Alberto Cadioli.
Le figure dell’editoria: l’editore iperlettore
Nel campo dell’editoria, l’iperlettore identifica, per astratto, un lettore ideale che in sé racchiude tutte le caratteristiche della comunità reale di lettori, in vista della quale l’editore sceglie cosa pubblicare e cosa non pubblicare. Una scelta, quest’ultima, che non è determinata da un giudizio di “gusto”, ma da un giudizio di “valore” e che dipende dal potenziale che un testo ha di incontrare le esigenze dei lettori; Dominique Cartellier, in Figures de l’éditeur afferma a tal proposito «L’editore è colui che situa il valore e non colui che giudica».
Di questa lettura interpretativa l’iperlettore lascia tracce nel modo e nella forma in cui sceglie di editare un determinato libro. Tutti gli elementi correlati alla produzione e alla pubblicazione di un’opera rivelano qualcosa del significato elaborato durante la lettura editoriale. Ne deriva che il libro, nella sua redazione finale, viene a caricarsi di una duplice prospettiva; da una parte l’intentio auctoris quella dell’autore, il significato primo inscritto nel testo; dall’altro l’intentio editionis, il significato che l’editore scorge nel libro e il messaggio che, attraverso la pubblicazione, vuole veicolare. «Ogni edizione è interpretativa» riassumeva Gianfranco Contini.
Il testo dato alla stampa è il risultato delle due intentiones, quella dell’autore e quella dell’editore.
Tali intenzioni sono trasmesse ai lettori attraverso ogni aspetto, testuale e materiale, dell’oggetto letterario. Ad esempio, le scelte grafiche e tipografiche, tradiscono – al pari della confezione del libro – l’interpretazione che ne dà l’editore. Intorno al testo, invece, vi sono componenti testuali e materiali di varia natura, definiti nel loro insieme paratesti.
Esempi di editori iperlettori
L’intentio editionis e l’intentio auctoris possono coincidere oppure possono discordare tra loro. Quando nel 1942 Bompiani pubblicò I Musulmani in Sicilia di Michele Amari, eseguì sul testo una lettura interpretativa differente da quella dell’autore e ritenne opportuno modificarne formato e destinazione.
Rispetto al ristretto pubblico scientifico-accademico cui Amari riteneva che il suo testo dovesse essere destinato, l’editore, avendo colto nel libro un potenziale formativo e «pienamente poetico» fino ad allora inedito, intuì la possibilità di estenderne il pubblico di riferimento; la strategia fu eliminare tutte le note di cui il testo era corredato nella sua stesura iniziale, in quanto superflue per una lettura scorrevole da parte di lettori eterogenei. Al titolo iniziale Storia dei musulmani in Sicilia, Bompiani sostituisce I Musulmani in Sicilia, più immediato e privo del riferimento alla cornice storica dell’opera.
L’editore iperlettore per antonomasia è stato, però, Elio Vittorini, scrittore e traduttore italiano dello scorso secolo, che collaborò con la casa editrice Einaudi e, in questo contesto, fu spesso tacciato di arbitrarietà nella scelta dei testi da editare.
Le fasi di lavorazione e le figure dell’editoria
Ai due estremi vi sono gli autori e i lettori, nel mezzo l’intero ciclo di lavorazione che coinvolge numerose figure dell’editoria con un ruolo di mediazione.
Oltre all’editore, incaricato di stabilire la forma definitiva in cui l’opera sarà resa pubblica, indispensabile è il ruolo dell’intera direzione editoriale, cui compete la definizione della politica editoriale della casa e del programma editoriale fatto di titoli e scadenze; i titoli sono acquistati attraverso i contratti di edizione dall’ufficio diritti, mediatore tra casa editrice e agenti, autori, case editrici straniere.
L’effettivo lavoro di conversione di un testo in libro è di competenza della redazione che realizza, di fatto, il programma editoriale, lavorando sul testo; quindi revisione, editing, traduzione, correzione sulla base del manuale di stile.

L’ultima fase del prodotto finito è affidata all’ufficio tecnico che, a partire dal file consegnato dalla redazione, realizza materialmente l’oggetto da mettere in vendita.
Tutti gli elementi che concorrono alla pubblicazione, alla circolazione e alla pubblicizzazione dell’oggetto letterario sono gestiti dalla direzione marketing e comunicazione, intermediaria tra la casa editrice e i media, e quindi i destinatari del libro.
Se, come si è detto, un oggetto letterario diventa tale solo dopo essere stato letto da lettori che ne forniscono un’interpretazione condivisa, le campagne di pubblicità e le strategie di comunicazione hanno un ruolo fondamentale nella piena realizzazione del prodotto finito, poiché suggeriscono al pubblico una possibile chiave di lettura dell’opera, accompagnando quest’ultima al di fuori della sua casa di produzione.
L’editoria richiede processo lungo e delicatissimo che inizia con la lettura e termina con la produzione, in un equilibrio costante tra il riconoscimento del valore di un libro e la determinazione del giusto prezzo.
La funzione venosa e arteriosa della letteratura
Lo spiega meglio Vittorini, che in un’intervista sul lavoro e sulle figure dell’editoria rilasciata nel 1963 afferma: «Bisogna sempre ricordarsi che accanto ai libri che si possono considerare dei beni di consumo ci sono dei libri che invece hanno l’importanza di essere dei mezzi di produzione. E che a questi dobbiamo rivolgere l’attenzione maggiore perché sono quelli che ci interessano per la storia della letteratura e della cultura insieme perché finiscono per avere significato culturale proprio questi che hanno un valore di mezzo di produzione. Allora, qui sarebbe da spiegare cosa si intende come mezzo di produzione. Vi spiego meglio con una metafora più diretta. Facciamo una distinzione tra una letteratura che ha una funzione venosa – il sangue delle vene sfruttato che viene riportato verso i polmoni – una letteratura dunque priva di ossigeno, una letteratura che usa quello che è stato fatto da altri, e poi distinguo invece con una letteratura che ha una funzione arteriosa, quindi che ha una funzione di portare il sangue ricco a nutrire la vita degli altri».
Fonte immagini: https://pixabay.com/it/