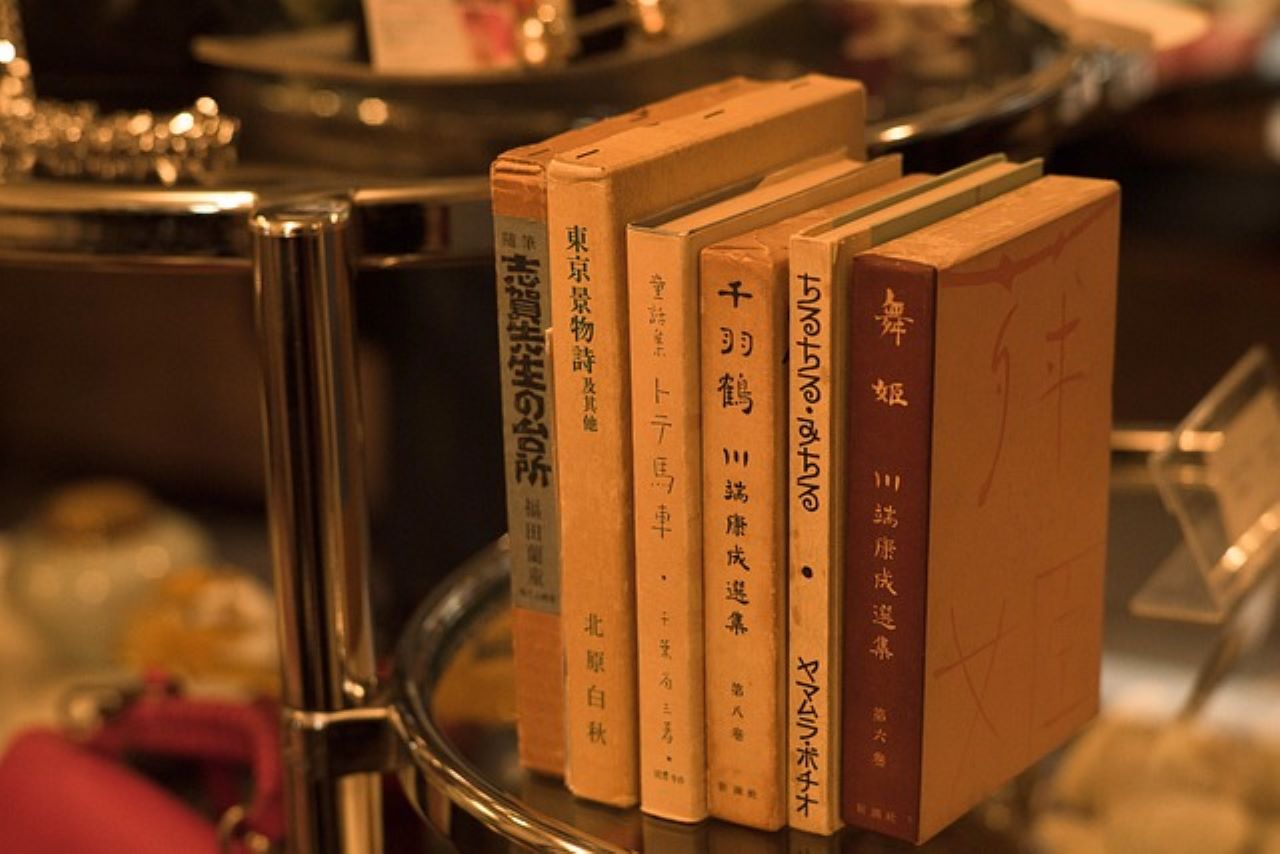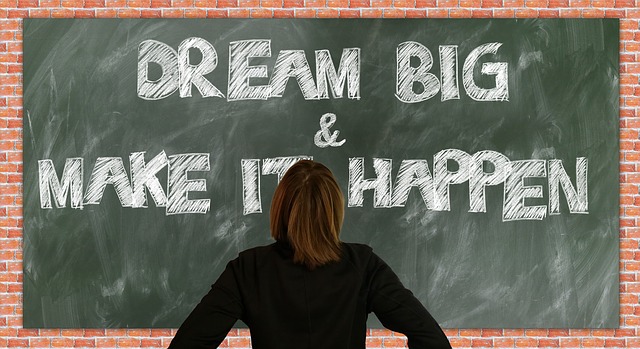Nella diversità e complessità della sottocultura giapponese, esiste un fenomeno complesso: quello delle gang criminali e studenti teppisti. In particolar modo, tra queste gang, le più particolari erano le cosiddette sukeban. Tradotto approssimativamente in «girl boss» o «ragazza delinquente», il termine sukeban fa riferimento a una sottocultura giapponese, particolarmente associata alle ragazze adolescenti delinquenti. La cultura sukeban è emersa nel Giappone del dopoguerra e ha raggiunto il suo apice negli anni ‘70 e ‘80, lasciando un segno indelebile nella società e nella cultura popolare giapponese.
Origine del fenomeno
Tale fenomeno è nato da una confluenza unica di fattori storici, sociali e culturali. All’indomani della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone ha subito una rapida modernizzazione e urbanizzazione che ha portato a significativi cambiamenti all’interno della società. Nel pieno di questa riconfigurazione sociale e culturale, le giovani donne hanno sperimentato, adottando nuovi ruoli e nuove identità, spesso in opposizione alle aspettative tradizionali.
Il prototipo delle sukeban era un’adolescente ribelle che sfidava l’autorità e abbracciava un’identità anticonformista. Queste ragazze, spesso provenienti da ambienti della classe operaia, formavano bande o gruppi di ragazze e adottavano stili di moda distintivi, caratterizzati da abiti dai colori vivaci, scarpe con plateau e acconciature elaborate.
Caratteristiche delle sukeban
Le sukeban erano spesso descritte come adolescenti ribelli che sfidavano le norme sociali, impegnandosi in attività come marinare la scuola o fumare. Erano conosciute per il loro stile di moda che tipicamente includeva uniformi scolastiche – il cosiddetto fuku alla marinara – modificate, accessori come catene e giacche di pelle. Inoltre, si dedicavano ad attività come la prostituzione, la violenza e il furto.
Stile di vita
Al centro della cultura sukeban c’era un senso di cameratismo, lealtà e responsabilizzazione: la lealtà dell’una verso l’altra era indiscutibile. Inoltre, la gerarchia all’interno di ogni clan era rispettata e ritenuta assolutamente inviolabile. In caso contrario, le ragazze ritenute colpevoli venivano punite anche con punizioni corporali, quali le bruciature di sigarette.
Le loro attività non si limitavano al mero malaffare; erano spesso coinvolte in reati minori, come il taccheggio, l’estorsione e le risse di strada.
Nonostante il loro comportamento delinquenziale, le sukeban erano note anche per il loro forte senso della giustizia e della comunità. Si opponevano alle ingiustizie e difendevano i loro quartieri dalle minacce esterne.
Oltretutto, il fenomeno delle gang femminili in Giappone era alquanto inconsueto: la cultura criminale giapponese è da sempre maschilista. Non a caso, la yakuza – organizzazione criminale tradizionale giapponese – non permette alle donne alcune autorità. Ed è da questo punto di vista che il fenomeno delle sukeban si arricchisce di discorsi sulla nozione di femminilità e di stereotipi di genere.
Influenza delle sukeban nella cultura di massa
Il fenomeno delle sukeban ha catturato l’immaginazione del pubblico giapponese ed è diventato rapidamente un tema ricorrente nella letteratura, nel cinema e nella televisione. Innumerevoli libri, manga e film hanno rappresentato le imprese delle sukeban, ritraendole sia come eroine che come antieroine. Uno dei film più iconici sulle sukeban è Sukeban Deka, diretto da Hideo Tanaka, che segue le avventure di una liceale reclutata dalla polizia per infiltrarsi nelle organizzazioni criminali. Inoltre, negli anni settanta, esplose nel cinema giapponese il sottogenere detto Pinky Violence, avente per protagoniste molte sukeban e di cui Girl Boss Blues è il film di rappresentanza.
Il fenomeno delle sukeban ha ispirato anche le tendenze della moda, oltre che la musica e la moda di strada.
Dal 1990 il termine sukeban è stato sostituito dalle enjo kosai, espressione che indica un fenomeno sociale del Giappone contemporaneo che vede come protagoniste ragazzine tra i 12 e i 17 anni le quali, per soldi, intrattengono rapporti (sessuali e non) con uomini adulti.
Sebbene questa cultura abbia perso importanza nel corso degli anni, continua a occupare un posto nella cultura popolare giapponese come simbolo della ribellione adolescenziale e della sfida contro la categorizzazione sociale. Abbracciando la loro identità di cattive ragazze, le sukeban hanno sfidato le norme dettate dalla società e hanno aperto la strada a un panorama culturale più inclusivo e diversificato.
Fonte immagine: Wikipedia