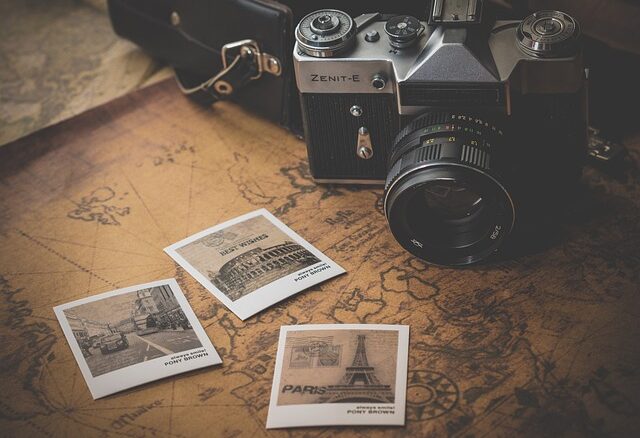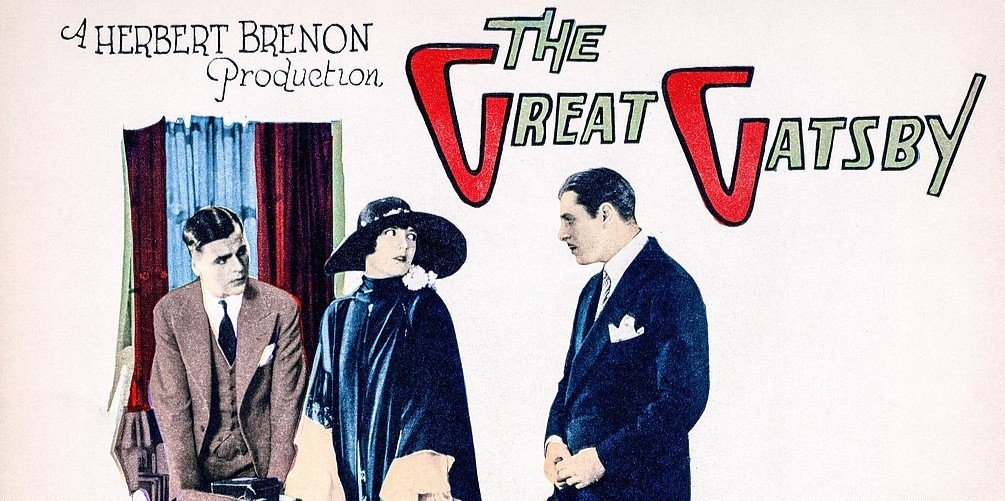Le Tre Grazie: storia, mito e rappresentazioni artistiche
Divinità poste tra il cielo e la terra, con l’unico, importante compito di diffondere l’armonia nel mondo attraverso le arti che nobilitano l’animo umano, le Tre Grazie sono tra le figure più positive e luminose della mitologia antica. Presso i Greci erano chiamate Cariti (in greco antico Χάριτες), mentre nella mitologia romana erano conosciute come Grazie (in latino Gratiae). Simbolo di bellezza, gioia di vivere e prosperità, queste dee benefiche infondevano la loro grazia nel cuore degli dèi e dei mortali. In questo articolo, andremo a conoscere meglio la storia e il mito delle Tre Grazie, analizzando le loro origini, i loro nomi, il loro significato simbolico e le loro rappresentazioni nell’arte e nella letteratura, dall’antichità fino ai giorni nostri.
Chi sono le Tre Grazie? Origini e nomi nella mitologia greca e romana
Le Tre Grazie, personificazioni della grazia e della bellezza, erano considerate figlie di Zeus, il re degli dèi, e della ninfa Eurinome. Secondo altre versioni del mito, erano invece figlie di Era, oppure di Elios (il dio Sole) e dell’oceanina Egle. Un’altra tradizione ancora le vuole figlie di Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, e di Dioniso, dio del vino e dell’ebbrezza.
Le Tre Grazie: figlie di Zeus ed Eurinome o di Afrodite e Dioniso?
La genealogia delle Tre Grazie, come spesso accade nei miti antichi, è incerta e varia a seconda delle fonti. La versione più diffusa le vuole figlie di Zeus ed Eurinome, ma l’attribuzione della loro maternità ad Afrodite o a Era, e della paternità a Dioniso o a Elios, sottolinea comunque il legame di queste dee con la bellezza, la gioia e la fertilità.
I nomi delle Tre Grazie: Aglaia, Eufrosine e Talia
Secondo Esiodo, nella sua Teogonia, le Tre Grazie erano tre e si chiamavano Aglaia, Eufrosine e Talia. Aglaia rappresentava lo splendore e l’ornamento; Eufrosine la gioia e la letizia; Talia la prosperità ed era anche nota come la “portatrice di fiori”.
Le Tre Grazie a Sparta e Atene: Cleta, Faenna, Auxo ed Egemone
Il numero e i nomi delle Grazie, però, variavano a seconda delle località. A Sparta, ad esempio, se ne veneravano solo due: Cleta, l’Invocata, e Faenna, la Lucente. Ad Atene, invece, erano onorate Auxo, la Crescente, ed Egemone, Colei che procede. Queste differenze locali riflettono le diverse sfumature di significato attribuite al concetto di “grazia”.
Il significato simbolico delle Tre Grazie: armonia, gioia e bellezza
Erano dee benefiche, associate alla gioia di vivere, all’armonia, alla bellezza, sia esteriore che interiore, e alla natura rigogliosa. Erano considerate le dispensatrici di tutto ciò che rende piacevole la vita, come l’eleganza nei movimenti, la gentilezza d’animo, la cordialità nei rapporti umani e il talento artistico.
Il legame con la natura e la vegetazione
Probabilmente, in origine, le Tre Grazie erano legate al culto della natura e della vegetazione, come suggerisce la loro associazione con la dea Afrodite, nella sua accezione di divinità della fertilità, non solo umana, ma anche vegetale. Si narra, infatti, che Afrodite facesse fiorire i prati al suo passaggio. Anche il nome di Talia, “la fiorente”, e l’epiteto di Egemone, “colei che guida”, che allude forse al procedere delle stagioni, confermano questo legame con il ciclo della natura.
Le Tre Grazie nel seguito di Apollo e Venere: banchetti, danze e arti
Le Tre Grazie facevano spesso parte del seguito di Apollo, dio della musica e delle arti, o di Venere (Afrodite), dea della bellezza e dell’amore. Si diceva che presiedessero ai banchetti, alle danze e agli altri piacevoli eventi sociali, diffondendo gioia e armonia tra dèi e mortali. Insieme alle Muse, figlie di Zeus e di Mnemosine, cantavano e danzavano per gli dèi sul monte Olimpo, al suono della lira di Apollo, allietando i loro conviti. Esse, come le Muse, donavano ad artisti e poeti l’ispirazione e la capacità di creare opere d’arte di grande bellezza, infondendo nei loro cuori la scintilla dell’estro e del genio.
Le Tre Grazie nell’arte: da Pompei a Canova, passando per Raffaello e Botticelli
Le Tre Grazie sono state un soggetto molto amato dagli artisti di tutte le epoche, che le hanno rappresentate in innumerevoli opere d’arte, sia in pittura che in scultura. La loro immagine è diventata un simbolo universale di bellezza, grazia e armonia.
Le Tre Grazie nell’affresco pompeiano del I secolo d.C.
Una delle più antiche raffigurazioni delle Tre Grazie giunta fino a noi è un affresco del I secolo d.C., rinvenuto a Pompei e oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In questo affresco, le tre dee sono rappresentate secondo l’iconografia classica: giovani e nude, due rivolte verso lo spettatore e una, quella centrale, voltata di spalle, in un tenero abbraccio che simboleggia l’armonia e la concordia.
Le Tre Grazie nella “Primavera” di Botticelli: un’interpretazione neoplatonica
Nel Rinascimento, Sandro Botticelli raffigurò le Tre Grazie nella sua celebre “Primavera“, uno dei dipinti più famosi degli Uffizi. Secondo l’interpretazione dello studioso Edgar Wind, le tre figure femminili del dipinto rappresenterebbero le tre forme dell’Amore: Castitas (Castità), Voluptas (Voluttà) e Pulchritudo (Bellezza). Le tre dee indossano abiti leggeri e trasparenti, che ne esaltano la grazia e la femminilità. La Primavera di Botticelli è considerata un capolavoro del Rinascimento italiano e un’espressione della filosofia neoplatonica, che vedeva nell’amore e nella bellezza una via per elevarsi al divino.
Raffaello e la riscoperta del modello classico delle Tre Grazie
Anche Raffaello Sanzio si cimentò con il tema delle Tre Grazie, realizzando un piccolo dipinto a olio su tavola, oggi conservato al Museo Condé di Chantilly. In quest’opera, Raffaello riprende fedelmente il modello antico, raffigurando le tre dee nude e abbracciate, con in mano i pomi delle Esperidi, simbolo di immortalità. La composizione è semplice ed essenziale, e le figure occupano l’intero spazio della scena, stagliandosi su uno sfondo neutro.
Le Tre Grazie nel Manierismo e nel Barocco: Rubens e la Controriforma
Con il Manierismo e il Barocco, la rappresentazione delle Tre Grazie subì alcune trasformazioni. Gli artisti iniziarono a sperimentare nuove pose e composizioni, allontanandosi dal modello classico. Un esempio è l’opera di Lucas Cranach il Vecchio, che nel 1531 dipinse le Tre Grazie con figure più allungate e sinuose, tipiche dello stile nordico. Durante la Controriforma, la Chiesa cattolica impose agli artisti una maggiore morigeratezza nella scelta dei temi e delle rappresentazioni. Pieter Paul Rubens, però, non rinunciò a raffigurare le Tre Grazie, ma le trasformò in opulente matrone dalle forme generose e dalle carni morbide, come si può vedere nel suo dipinto “Le Tre Grazie”, conservato al Museo del Prado di Madrid.
Canova e Thorvaldsen: il ritorno alla classicità nell’Ottocento
Nell’Ottocento, con il Neoclassicismo, si assistette a un ritorno ai modelli dell’arte classica. Antonio Canova, uno dei massimi esponenti di questo movimento, realizzò nel 1817 il gruppo scultoreo delle Tre Grazie, oggi conservato all’Ermitage di San Pietroburgo. In quest’opera, le tre dee sono rappresentate in una composizione armoniosa, abbracciate e con i corpi morbidamente modellati nel marmo. Anche lo scultore danese Bertel Thorvaldsen scolpì un gruppo delle Tre Grazie, ispirandosi ai modelli antichi e rivaleggiando con Canova nella ricerca della bellezza ideale.
Le Tre Grazie nella letteratura: da Seneca a Foscolo
Le Tre Grazie non hanno ispirato solo gli artisti, ma anche i letterati e i filosofi. Seneca, nel suo trattato De beneficiis, le descrive come simbolo della generosità e del triplice ritmo del dare, ricevere e ricambiare, rappresentato dall’intreccio delle loro mani. Anche i romani usavano l’espressione “gratias agere” per esprimere la loro gratitudine, sottolineando il legame tra le Grazie e il sentimento di riconoscenza.
Seneca e il triplice ritmo della generosità nelle Tre Grazie
Secondo Seneca, le Tre Grazie rappresentano il ciclo virtuoso della generosità: il dare, il ricevere e il ricambiare. Questo ritmo, simboleggiato dall’intreccio delle mani delle tre dee, è alla base dei rapporti umani e della convivenza civile. *Lo studioso Edgar Wind, nel suo libro Pagan Mysteries in the Renaissance, riporta la spiegazione di Seneca e la collega all’interpretazione neoplatonica della Primavera di Botticelli*.
Ugo Foscolo e il poemetto incompiuto “Le Grazie”
In epoca più recente, Ugo Foscolo dedicò alle Tre Grazie un poemetto, iniziato nel 1812 e rimasto incompiuto. Nell’introduzione, Foscolo scrive: «Alle Grazie immortali / le tre di Citerea figlie gemelle / è sacro il tempio, e son d’Amor sorelle; / nate il dì che a’ mortali / beltà ingegno virtù concesse Giove, / onde perpetue sempre e sempre nuove / le tre doti celesti / e più lodate e più modeste ognora / le Dee serbino al mondo. Entra ed adora». In questi versi, il poeta sottolinea il potere delle Tre Grazie di ispirare e preservare la bellezza, l’ingegno e la virtù nel mondo. Da ricordare anche l’Orologio delle Tre Grazie, opera di Etienne-Maurice Falconet del XVIII secolo, custodito al Louvre.
Le Tre Grazie, con la loro bellezza, la loro armonia e il loro significato simbolico, hanno attraversato i secoli, ispirando artisti, poeti e filosofi. Ancora oggi, queste dee antiche continuano a parlarci di gioia, di grazia e di armonia, valori universali e senza tempo.
Fonte immagine per l’articolo Chi sono le Tre Grazie: it.wikipedia.org