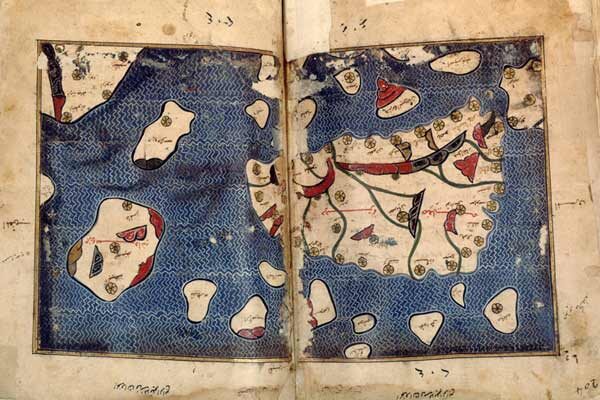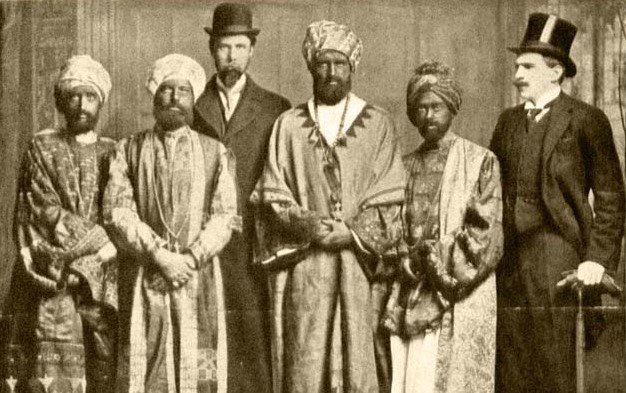Cos’è la malinconia, una riflessione sul tema
«Un desiderio di desideri: la malinconia».
(Lev Tolstoj)
Una sensazione bruciante, straziante, che si staglia come un macigno nel torace e nella mente. Un nodo alla gola e il respiro affaticato. Voglia di amare lasciata a metà, pensieri proiettati ad una stasi irrequieta. Senso di impotenza e di non credersi abbastanza, all’altezza. Insicurezza cronica e desiderio incessante di ciò che non si ha, che non si può avere, o che si è provato ma poi perso forse per sempre. Questa è la malinconia. Una sorta di tristezza di fondo, a volte inconsapevole, che porta a vivere passivamente, incapaci di prendere iniziative, adattandosi agli avvenimenti esterni con la convinzione di non poter osare, provare, lottare. La malinconia è quel desiderio, collocato in fondo all’anima, di una cosa, di una persona mai conosciuta o di un amore che non si è mai avuto, ma di cui si avverte incessantemente la mancanza o per raggiungere il quale non ci si sente all’altezza.
La persona colta da stato malinconico tende spesso ad escludersi dalla vita sociale e a negare il trascorrer del tempo, volgendosi verso un passato o un futuro idilliaco.
Cos’è la malinconia: definizione e origini storiche
Il termine malinconia deriva dal greco “melancholìa”, composto di “mélas, mélanos” (nero) e “cholé” (bile), dunque “bile nera”, uno dei quattro umori dalle cui combinazioni dipendono, secondo la medicina greca ippocratica, il carattere e gli stati d’animo delle persone. I caratteri umani e i loro comportamenti deriverebbero dunque dalla varia combinazione dei quattro umori base, ovvero bile nera, bile gialla, flegma ed infine il sangue (umore rosso). Questi umori, ossia “liquidi” dal greco, significano appunto “stati d’animo”, e da essi etimologicamente derivano il carattere melanconico, il collerico, quello flemmatico e quello sanguigno.
La malinconia nella storia: da Ippocrate a Freud
Il concetto di malinconia ha attraversato la storia del pensiero occidentale, assumendo significati e sfumature diverse a seconda delle epoche e delle culture. Già Ippocrate, nel V secolo a.C., la considerava come una condizione patologica causata da un eccesso di bile nera. Aristotele, nel IV secolo a.C., la collegava al genio e alla creatività, sostenendo che tutti gli uomini eccezionali fossero malinconici. Nel Rinascimento, Marsilio Ficino riprese la concezione aristotelica, vedendo nella malinconia una condizione tipica degli spiriti elevati e contemplativi. Nel XVII secolo, Robert Burton pubblicò “Anatomia della malinconia“, un’opera monumentale che analizza in modo dettagliato le cause, i sintomi e i rimedi di questo stato d’animo. Nell’Ottocento, la malinconia divenne un tema ricorrente nella letteratura e nell’arte romantica, spesso associata alla solitudine, all’amore non corrisposto e al senso di inappartenenza. Nel Novecento, Sigmund Freud la interpretò come una forma di lutto non elaborato, in cui l’oggetto perduto viene interiorizzato e diventa parte dell’Io del soggetto. Altri autori, come Søren Kierkegaard ed Emil Cioran, hanno esplorato le dimensioni esistenziali della malinconia, collegandola al senso di vuoto, di angoscia e di finitudine che caratterizza la condizione umana.
Malinconia e creatività: lo “spleen” di Baudelaire e l’ispirazione artistica
Lo scrittore francese Victor Hugo scriveva che «la malinconia è la gioia di essere tristi». Questo perché si tende a crogiolarsi in essa, nonostante il sentimento di tristezza immane che reca con sé. Come provare un sottile piacere stagnandosi nei meandri di ricordi e desideri languidi. La malinconia di fatto non sussisterebbe priva di memoria e desiderio, perché un’anima malinconica è colei che soffre per qualcosa che le ha donato estasi e felicità in passato e che purtroppo sa di aver perso. Ma il malinconico soffre altresì nel desiderio di un qualcosa che manca, qualcosa di imprescindibile, di non ben definito, ma importante, verso cui inconsapevolmente tende, spesso un amore irrealizzabile o semplicemente bramato.
La malinconia tuttavia può essere anche un modo per non accettare il presente, manifestando il dolore per ciò che manca e la scontentezza rispetto a ciò che si ha. Dunque, proprio tale insoddisfazione può rendere la malinconia un sentimento fertile e non fine a se stesso, spingendo il cuore e la mente ad agire per tentare di cambiare una situazione scomoda. Quel sentimento di dolorosa mancanza può innescare parallelamente la voglia di agire. Si intraprende così un percorso interiore che amplia i confini della conoscenza di sé e del mondo, spingendo verso la curiosità e l’approfondimento. Dunque, tentare di fuggire la malinconia non sempre si rivela un percorso utile da intraprendere. Nel momento in cui il flusso malinconico riesce ad essere inquadrato ed incanalato può generare creatività. Si tratta dello “spleen“, termine coniato dal poeta simbolista Charles Baudelaire, che si realizza quando la malinconia si traduce in fertile produzione artistica, che dà sbocco alla sofferenza trasformandola in creatività. Tale creatività è esprimibile attraverso la pittura, la scultura, la scrittura, la composizione musicale, il canto e la danza. Affinché la malinconia si trasformi in ispirazione, è necessario lasciarla fluire, accoglierla e liberarla.
Esempi di artisti malinconici e delle loro opere
Molti artisti hanno saputo trasformare la loro malinconia in opere d’arte di straordinaria bellezza e intensità. Tra questi, possiamo ricordare il pittore romantico Caspar David Friedrich, i cui paesaggi solitari e suggestivi evocano un profondo senso di nostalgia e di mistero; il poeta Giacomo Leopardi, che nelle sue liriche ha espresso con insuperabile maestria il dolore dell’esistenza e il desiderio di infinito; il musicista Fryderyk Chopin, le cui composizioni per pianoforte sono intrise di una struggente malinconia; il regista Ingmar Bergman, che nei suoi film ha indagato con lucidità e profondità le angosce e le inquietudini dell’animo umano.
Malinconia e depressione: differenze tra uno stato d’animo e una patologia
Tra l’altro, la malinconia funge anche da campanello d’allarme, invitando l’anima e la mente stressate dalla frenesia quotidiana a rallentare, fermarsi un istante ed intraprendere un ritmo più fluente e consapevole. Purtroppo però la tendenza attuale risiede nel rifiuto alla sofferenza e nell’evitamento forzato verso l’umore malinconico. Sembrano contare solo il successo e l’euforia, la smania di sentirsi sempre e assolutamente in forma ed invincibili, facendo precipitare i sani sentimenti di tristezza ed inquietudine in una sorta di discarica emotiva. Ma la sofferenza e il dolore sono a volte i presupposti per cambiamenti importanti ed anche radicali della propria vita. Per questo motivo è doveroso dargli voce ed ascolto, concentrandosi sulla propria interiorità. Tuttavia, se il sentimento malinconico diviene cronico ed infruttuoso, rischia di far regredire l’anima, ostacolandone salute ed evoluzione e sfociando in depressione. La malinconia è uno stato d’animo, la melanconia è una sua degenerazione, che sfocia in vera patologia psichica. È infatti questa una forma di depressione, caratterizzata da forte abbassamento dell’umore, abbattimento, scoraggiamento, ansia. Più che eventi esterni (lutto, stress, ecc…), sono spesso fattori biologico-genetici ad intervenire nella predisposizione alla melanconia. Questa è un “mal di vivere”, a carattere endogeno più che esogeno. Uno dei sintomi al riguardo è il continuo rimuginare. Questo è uno stato mentale, mentre la sana malinconia è uno stato d’animo. Nel primo caso il pensiero domina ed assoggetta; nel secondo il pensiero resta sullo sfondo e si palesa solo con dolcezza e pacatezza. È qui che interviene la creatività a salvare mente ed anima.
“Appocundria”: la malinconia nella cultura napoletana
Nella lingua napoletana, la malinconia trova definizione nella musica intima e sofferta del grande talento partenopeo Pino Daniele, che racchiude in parte nel termine, intraducibile in italiano, “appocundria“. L’etimologia del termine è incerta, ma si pensa che possa derivare dal greco “hypochondria”, ovvero “ipocondria”, la zona sotto le cartilagini costali, dove si riteneva avesse sede la malinconia. L’appocundria però non è semplice malinconia, e qualunque napoletano sa come questa parola in realtà racchiuda in sé significati vari e complessi. L’appocundria indica infatti uno stato d’animo privo di contorni ben definiti, una tristezza lenta che si accosta appunto alla malinconia, ma che reca con sé anche la noia, l’insoddisfazione e la solitudine. Spesso il termine, data la sua complessità semantica, viene anche accostato al portoghese “saudade”, che indica lo struggimento per qualcosa di irraggiungibile, un sentimento di incompletezza e dolorosa nostalgia. «Appocundria ‘e chi è sazio e dice ca è diuno». Così recita la malinconica canzone di Pino Daniele. Se tuttavia l’appocundria è legata alla sfera intima e individuale, la saudade è un sentimento comune. Entrambe sono però nutrite di forte sentimento identitario, rispettivamente napoletano e portoghese. Solo un napoletano può comprendere il mistero e la complessità che il termine racchiude.
Come gestirla: rimedi e strategie per trasformarla in risorsa
Per combattere l’insana malinconia diviene magari necessaria la pratica psicoterapeutica, che consente alla malinconia di ergersi a equilibrio spirituale, una cura alla folle e frenetica routine, giungendo così addirittura a gustarla, abbandonandosi al dolce oblio di ricordi e al tenace genio dell’estro artistico che spinge il cuore a vomitare tutto quanto stoni e si discosti dall’armonia dell’anima con l’universo. Oltre alla psicoterapia, ci sono diverse strategie che possono aiutare a gestire la malinconia in modo sano e costruttivo. Tra queste, l’attività fisica, che aiuta a scaricare le tensioni e a produrre endorfine, gli ormoni del benessere; il contatto con la natura, che favorisce il rilassamento e la contemplazione; la socializzazione, che permette di condividere le proprie emozioni e di sentirsi meno soli; l’espressione creativa, che consente di dare forma e voce al proprio mondo interiore.
Conclusione: la malinconia come opportunità di crescita e consapevolezza
In definitiva, la malinconia, pur appartenendo alla sfera dei sentimenti cupi, si tinge in realtà di positività, perché il dolore è spesso strumento necessario ad acquisire consapevolezza e smuovere l’anima dal torpore dell’acuta tristezza. A tal proposito, Luca Carboni cantava «la malinconia sembra quasi la felicità, sembra quasi l’anima che va, il sogno che si mischia alla realtà. Puoi scambiarla per tristezza, ma è solo l’anima che sa che anche il dolore servirà». La malinconia, se accolta e compresa, può diventare un’occasione preziosa di crescita interiore e di scoperta di sé.
Foto di: Personale