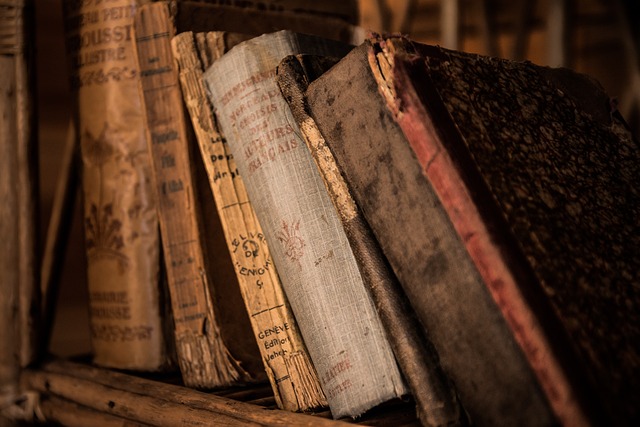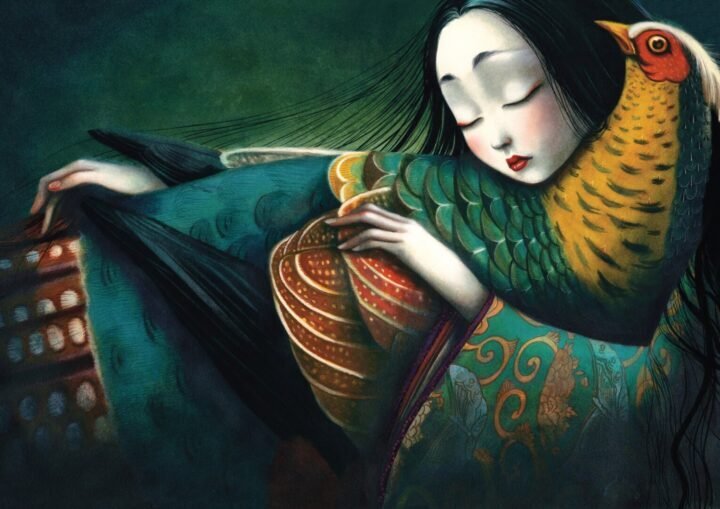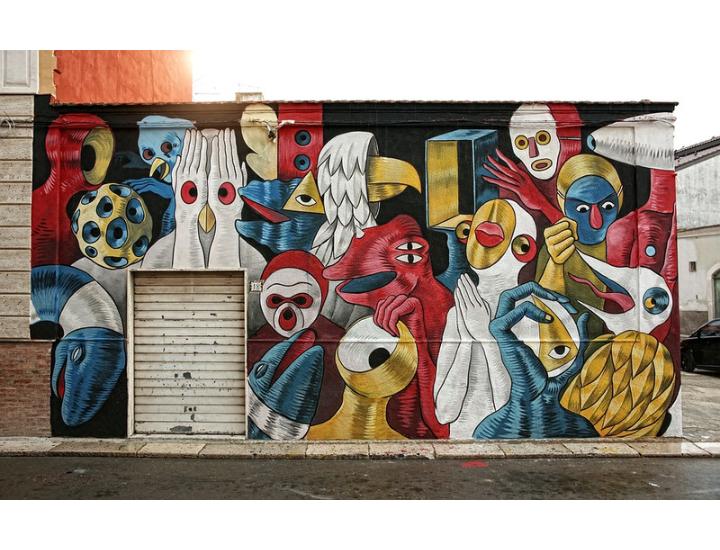Il Rinascimento è un periodo della storia d’Italia che ha lasciato un patrimonio inestimabile di arte, letteratura, scoperte scientifiche e molto altro. Non a caso, il nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo come “la culla del Rinascimento” e, ogni anno, musei e città d’arte sono visitati da turisti che ammirano le nostre bellezze. Il Rinascimento italiano ha visto fiorire le opere dei più grandi artisti del mondo, da Michelangelo a Botticelli. Ma non solo l’arte è stata al centro di questo periodo fiorente: anche la letteratura e le scienze hanno conosciuto importanti progressi.
L’arte nel Rinascimento italiano: un’esplosione di bellezza e innovazione
Il rinnovamento culturale iniziato con l’Umanesimo tra ‘400 e ‘500, durante il periodo rinascimentale, ha coinvolto tutti i campi del sapere, ma uno dei settori maggiormente interessati è stato quello delle arti figurative. Il Rinascimento mette al centro dell’universo l’uomo e anche gli artisti, nelle loro opere, cercano di raffigurare l’uomo in maniera più realistica, provando a far trasparire le sue emozioni. L’utilizzo della prospettiva, per rendere un’immagine tridimensionale, è stata una delle innovazioni artistiche che ha rivoluzionato completamente la storia dell’arte. Sulla base di questa tecnica, sono nati i più grandi capolavori dell’arte italiana, come gli affreschi di Raffaello nella Cappella Sistina o le Stanze Vaticane, senza dimenticare La Gioconda e Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Nel campo dell’architettura, il Rinascimento italiano ha lasciato al nostro Paese edifici di enorme importanza artistica, come la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze e, in particolare, la Cupola del Brunelleschi. Tra le figure più rappresentative del Rinascimento artistico ci sono artisti come Michelangelo e Leonardo, che nel corso della loro vita non si sono dedicati solo alla pittura. Michelangelo è stato un pittore, ma anche uno scultore e architetto; tra le statue realizzate da Michelangelo si ricordano il David e la Pietà, conservati rispettivamente a Firenze e a Roma (Basilica di San Pietro). Leonardo è ricordato per essere stato un pittore, ma la sua figura ha lasciato il segno anche in campo scientifico, ingegneristico e filosofico.
La letteratura del Rinascimento italiano: il trionfo del volgare e del trattato
Il Rinascimento italiano segna il trionfo della produzione in volgare. È in questo periodo che nasce la “questione della lingua”, il dibattito sulla scelta del volgare da utilizzare nella letteratura. Il tema era stato già affrontato da Dante Alighieri nel suo De vulgari eloquentia e viene riproposto da intellettuali rinascimentali come Machiavelli e Baldassarre Castiglione. Il primo preferiva il “fiorentino vivo”, il secondo la lingua delle corti. Infine, Pietro Bembo, nelle sue Prose della volgar lingua, identifica in Petrarca e Boccaccio i due modelli illustri per la lirica e la prosa. Il Rinascimento italiano si caratterizza per una tendenza al classicismo, che riflette un ideale di ordine e razionalità; la letteratura è intesa come qualcosa che deve elevarsi al di sopra del reale. Il genere principale del secolo è il trattato, con il quale l’intellettuale rinascimentale dà prova della sua formazione e offre anche un modello di classificazione del sapere per i suoi lettori. Durante il Rinascimento italiano c’è stato un rinnovamento nella storiografia; tra le opere più importanti si ricordano Il Principe di Machiavelli e Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione (e non *Il Galateo* di Giovanni Della Casa, che è un trattato di buone maniere, importante ma diverso), opere che rappresentano, rispettivamente, la figura del principe ideale e quella del perfetto uomo di corte. Il Principe di Machiavelli riflette sulla politica moderna e sulle sue caratteristiche. Rappresenta una svolta nella letteratura e nella visione della fede, nonché in quella della politica, che trova in sé stessa le proprie regole e i punti di riferimento. Per le opere storiografiche si è distinto Francesco Guicciardini, il quale, nelle sue opere, riflette sulla politica con un’ottica pessimistica, mettendo al centro l’operato individuale nella società. Le sue Storie d’Italia raccontano quarant’anni di storia di Firenze e dell’Italia. Ma una delle sue opere più rappresentative si intitola Ricordi; si tratta di una serie di aforismi e riflessioni di carattere politico e morale. I cortigiani, in questo periodo, influenzano il gusto, le scelte letterarie e le forme poetiche. Tra i poemi epico-cavallereschi più conosciuti vi sono L’Orlando innamorato di Boiardo, l’Orlando furioso di Ariosto e la Gerusalemme liberata di Tasso.
La scienza: rivoluzioni astronomiche e anatomiche
L’astronomia è uno dei campi che è stato rivoluzionato durante il Rinascimento italiano. Il sistema tolemaico (o geocentrico), che sosteneva la centralità della Terra e la rotazione degli altri pianeti intorno ad essa, fu sostituito dal sistema eliocentrico di Niccolò Copernico. Il perfezionamento del cannocchiale e il suo utilizzo scientifico sono invece attribuiti a Galileo Galilei, che grazie a questo strumento poté confermare la teoria eliocentrica e compiere importanti osservazioni astronomiche. Un altro settore che si è sviluppato durante il Rinascimento italiano è quello dell’anatomia. In questo periodo, grazie alla pratica della dissezione dei cadaveri (inizialmente osteggiata dalla Chiesa), sono state scoperte funzioni prima sconosciute degli organi umani e si sono fatti importanti progressi nella comprensione del corpo umano. Con l’Umanesimo, gli scienziati cominciano ad adottare un metodo di studio oggettivo e basato sull’esperienza (il metodo scientifico sperimentale), differente dall’approccio precedente, perlopiù religioso e magico.
Fonte immagine: Pixabay