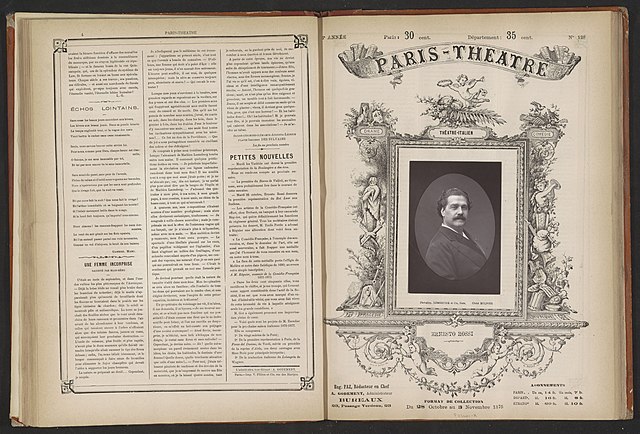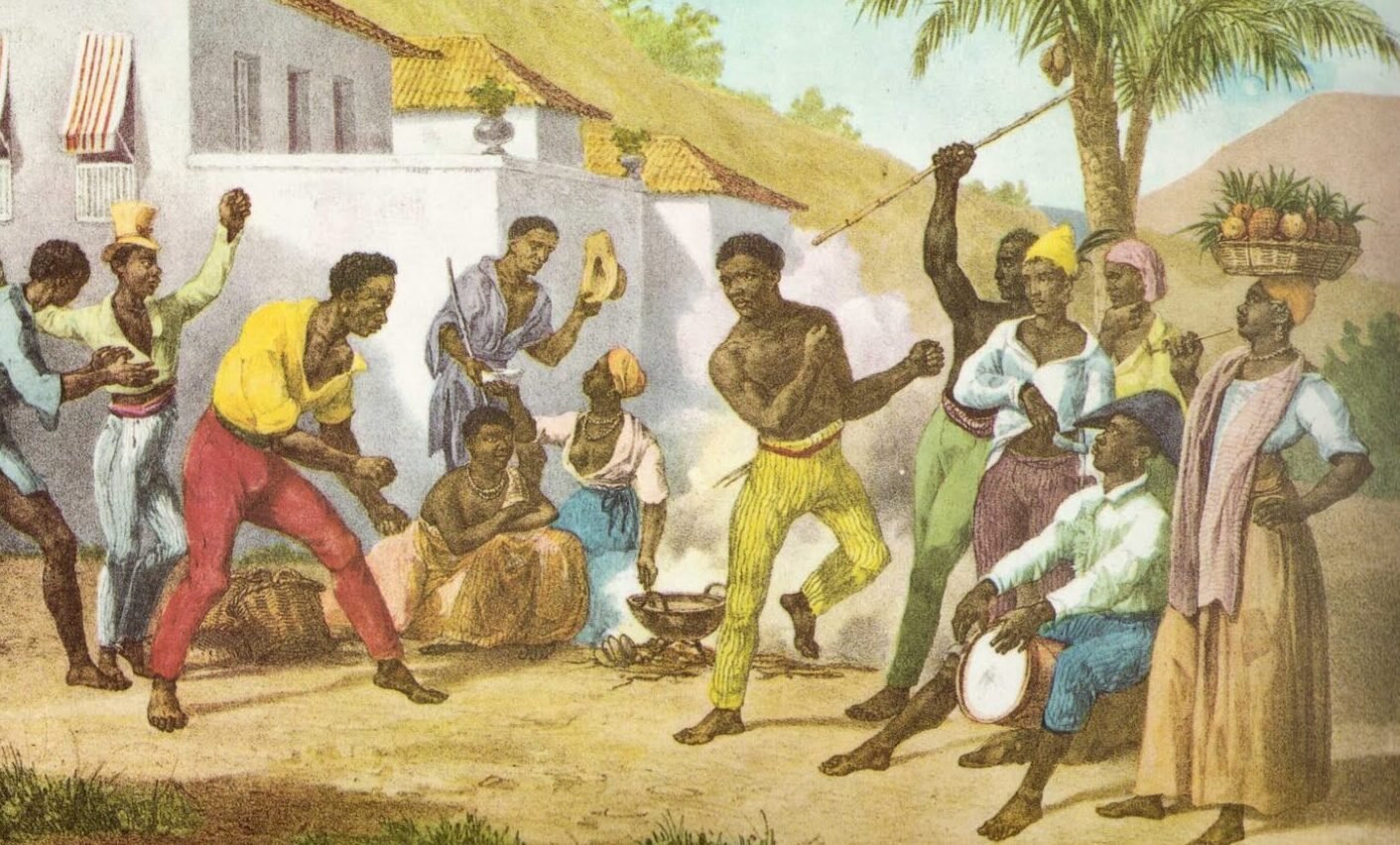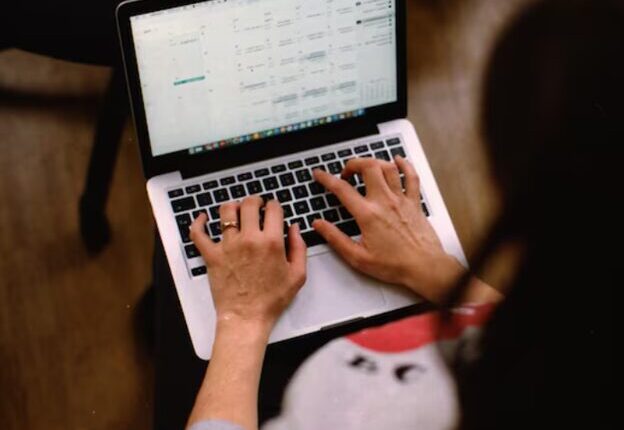La selva oscura è il potente simbolo allegorico del peccato e dello smarrimento morale in cui Dante Alighieri si trova all’inizio della Divina Commedia. Questi versi immortali, che aprono il Canto I dell’Inferno, rappresentano non solo la crisi personale del poeta ma anche quella universale dell’intera umanità e la profonda corruzione politica e religiosa dell’Italia del Trecento. Dante, che è considerato il padre della lingua italiana, costruisce un’allegoria universale del cammino dell’uomo verso la redenzione.
«Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.»
Indice dei contenuti
I tre livelli di allegoria della selva oscura
Per comprendere la profondità del capolavoro dantesco, è fondamentale analizzare i diversi piani di lettura. La tabella seguente riassume il significato simbolico della selva e degli altri elementi del Canto I.
| Elemento simbolico | Significato allegorico |
|---|---|
| La selva oscura | Rappresenta il peccato, la confusione morale e la corruzione (personale, umana e politica). |
| La diritta via | È la via della virtù e della grazia di Dio, smarrita a causa del peccato. |
| Il colle illuminato | Simboleggia la salvezza e la felicità terrena, irraggiungibile senza un percorso di purificazione. |
| Le tre fiere | Incarnano i tre principali ostacoli alla redenzione: lussuria (lonza), superbia (leone) e cupidigia (lupa). |
Il viaggio di Dante come exemplum universale
La Divina Commedia è un’opera che fin da subito stabilisce un doppio livello di lettura, personale e universale. Dante utilizza la prima persona («mi ritrovai», «io non so ben ridir») non per un atto di egocentrismo, ma per porsi come exemplum, un modello per tutta l’umanità. Ispirandosi alle Confessioni di Sant’Agostino, il poeta trasforma la sua esperienza personale in un’allegoria del cammino che ogni uomo deve compiere per abbandonare il peccato e ritrovare la salvezza. Il suo viaggio “nel mezzo del cammin di nostra vita”, a 35 anni, nell’anno del primo Giubileo (1300), diventa così il viaggio di ogni cristiano.

L’incipit del poema crea un’atmosfera onirica. La selva simboleggia una profonda confusione interiore, uno stato di torpore spirituale descritto come “sonno”. È il sonno della ragione, che porta l’anima ad abbandonare la “verace via”. Dante si ritrova nel sentiero più infido: quello del peccato. Questo smarrimento riflette la sua profonda crisi personale, segnata dalla morte di Beatrice e dall’esilio a causa degli scontri tra Guelfi Bianchi e Neri.
Il contesto storico e le fonti di ispirazione
Nel Medioevo, l’immagine della selva come luogo di perdizione era ricorrente. Una delle fonti d’ispirazione più significative per Dante fu l’abate e teologo calabrese Gioacchino da Fiore. Nella sua opera Visio Admirandae Historiae, un religioso si perde in una selva e il suo cammino è ostacolato da fiere. Tutta la Commedia è permeata dalla tensione profetica e dalla simbologia della Visio. Non è un caso che Dante citi Gioacchino nel Canto XII del Paradiso come uomo “di spirito profetico dotato”, riconoscendo il suo debito culturale. Entrambi trattano il tema della redenzione come un viaggio arduo che inizia dal profondo dell’oscurità.
Le tre fiere e la ragione come guida
Smarrito nella selva, Dante scorge un colle illuminato dal sole, simbolo di speranza, ma il suo tentativo di raggiungerlo è bloccato da tre fiere: una lonza (lussuria), un leone (superbia) e una lupa (cupidigia). Questi tre vizi rappresentano i principali ostacoli sulla via del bene. La lupa, in particolare, è la più temibile perché la sua fame è insaziabile, simbolo della cupidigia che affliggeva la Chiesa e la società del tempo.
Proprio quando la speranza sembra perduta, appare in suo soccorso il poeta latino Virgilio, allegoria della ragione umana illuminata dalla sapienza. Virgilio spiega a Dante che per raggiungere la salvezza deve compiere un altro viaggio, attraversando i tre regni dell’oltretomba. Sarà lui a guidarlo attraverso l’Inferno, dove incontrerà peccatori come Ulisse, fino alla dimora del male assoluto, Lucifero, e poi nel Purgatorio. Il doppio volto dell’amore in Dante, passione dannata e via per la salvezza, è un tema centrale del viaggio.
La selva come simbolo della corruzione politica e religiosa
La selva oscura non è solo il peccato individuale, ma rappresenta la corruzione dell’intera società. Dante invita a prendere coscienza della condizione negativa in cui versava l’Italia, segnata dal malgoverno e dalla decadenza morale. La sua critica si concentra sulla commistione tra potere spirituale e temporale. Nel suo trattato Monarchia, il poeta sosteneva la netta separazione tra Papato e Impero, accusando i pontefici di aver usurpato il potere politico, causando disordine. La “sella” del governo, secondo Dante, era vuota.
Questa critica ha un bersaglio preciso: Papa Bonifacio VIII, figura odiata da Dante per la sua spregiudicatezza e accusato di simonia, ovvero la compravendita di cariche ecclesiastiche. Sebbene il papa sia esplicitamente collocato all’Inferno nel Canto XIX, la selva oscura è il simbolo più ampio di quella “cloaca del sangue e de la puzza” in cui, secondo il poeta, si era trasformata la Chiesa. L’intera struttura della Divina Commedia, con la sua precisa numerologia, è concepita per denunciare questo disordine e indicare una via di redenzione. Fu proprio questa denuncia a costare a Dante l’esilio, un dolore che egli esorcizzò scrivendo il suo capolavoro, la cui eco risuona ancora oggi, come testimonia anche l’analisi del portale Treccani.
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 18/10/2025