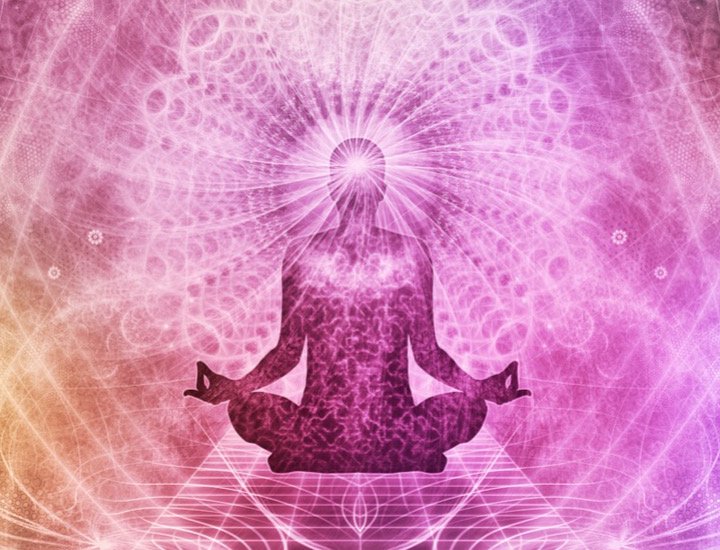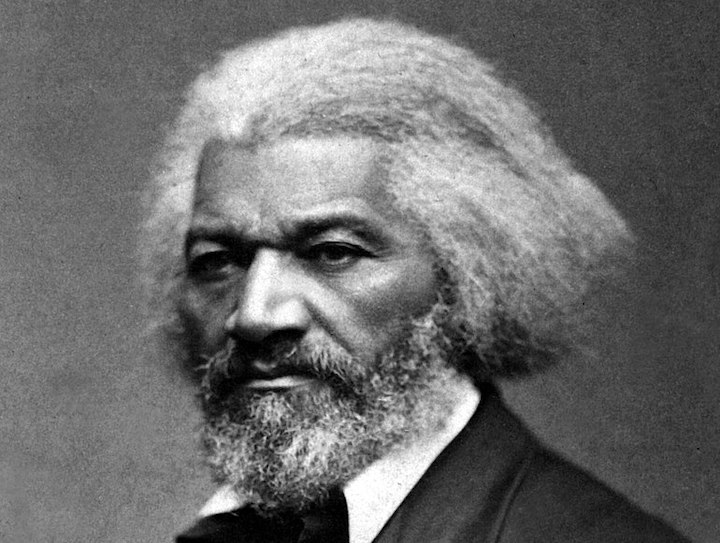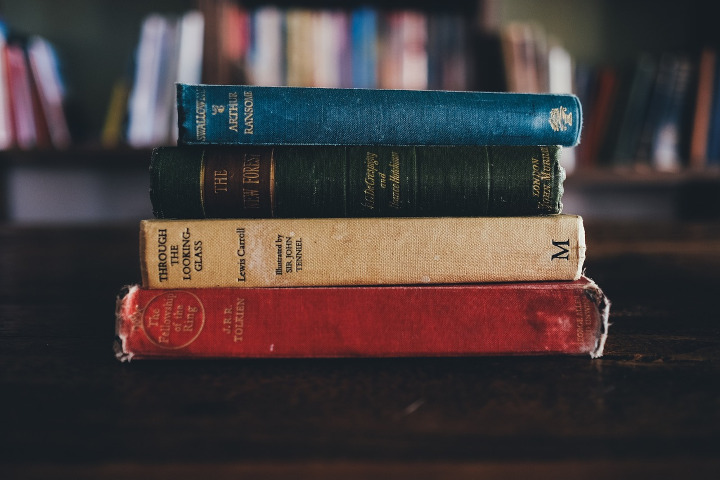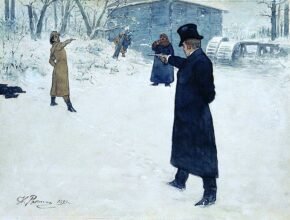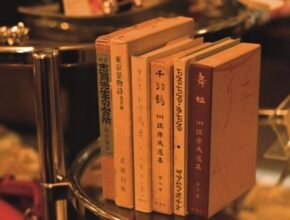Struttura della Divina Commedia: il capolavoro di Dante Alighieri
La Divina Commedia è il poema fondamentale della letteratura italiana, nonché una delle opere più importanti della letteratura mondiale. Scritto dal Sommo Poeta, Dante Alighieri, agli inizi del Trecento, diviene un componimento basilare, spesso citato con rimandi letterari anche in tempi moderni. La struttura della Divina Commedia segna il primo testo scritto in volgare fiorentino, divenendo così uno dei pilastri fondamentali per la costruzione della lingua italiana fino al riconoscimento mondiale. Questo poema epico-didascalico, di natura allegorica, narra il viaggio di Dante attraverso i tre regni dell’oltretomba: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un viaggio nell’aldilà che ha una precisa finalità: mostrare ai lettori come l’uomo possa giungere alla salvezza, seguendo un percorso di purificazione e di conoscenza. Dante, infatti, smarritosi nella selva oscura, simbolo del peccato e della perdizione, trova la forza di intraprendere questo viaggio grazie all’aiuto di alcune guide, che rappresentano anche delle figure allegoriche. Questo capolavoro della letteratura è ricco di significati nascosti e di riferimenti alla cultura, alla storia e alla filosofia del tempo.
Introduzione alla struttura della Divina Commedia: un viaggio ultraterreno
La Divina Commedia, il cui titolo originale è soltanto Comedìa, che fu poi battezzato da Boccaccio “Divina” per la straordinaria bellezza, appartiene alla corrente artistica del Dolce Stilnovo e ne riscontra i tratti salienti in più parti dell’opera. Tale periodo influenza le opere artistiche indirizzandole al cambiamento: si passa da una tipologia di poesie che esprimeva il sentimento di sofferenza verso l’amante a una nuova espressione di gratitudine verso l’ispiratrice delle opere artistiche. Nella struttura della Divina Commedia, questa tendenza viene influenzata dalla presenza di Beatrice, ovvero la donna amata da Dante, raffigurata nel Paradiso come guida, diviene la donna angelo che viene spesso citata nel Dolce Stilnovo.
La struttura della Divina Commedia: le tre cantiche
La Divina Commedia narra il viaggio allegorico che Dante, in prima persona, effettua nel mondo ultraterreno cristiano. Dunque, per comprendere al meglio la struttura della Divina Commedia, bisogna spiegare la divisione del viaggio stesso. La Divina Commedia è scritta in 3 cantiche (3 sarà un numero ricorrente), che corrispondono ai tre regni dell’aldilà: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Le tre cantiche sono suddivise anch’esse in 33 canti ciascuna, composti da terzine di endecasillabi a rima incatenata, ad eccezione dell’Inferno che ne prevede 34, in quanto il primo canto funge da proemio all’intero poema. I canti sono suddivisi anch’essi in terzine, designate da Dante come la struttura ideale per un componimento come la Divina Commedia.
Inferno: struttura a gironi e la legge del contrappasso
Nell’immaginario dantesco, la struttura dell’Inferno, all’interno della Divina Commedia, segue l’immaginario cattolico del tempo. Come riportato precedentemente, l’Inferno, unico capitolo con 34 canti, prevede un’introduzione nella quale Dante introduce il suo personaggio e racconta di essersi smarrito in quella che chiama selva oscura, che per successive interpretazioni simboleggia il peccato. Presenta la figura di Virgilio, il quale sarà la sua guida nel canto dell’Inferno e lo accompagnerà per tale tragitto. Dante, assieme a Virgilio, fa il suo ingresso sotto alla città di Gerusalemme, dove erano presenti le porte degli Inferi. L’immaginario dantesco dà come connotazione alla struttura dell’Inferno nella Divina Commedia quella di una fossa suddivisa in vari cerchi, detti gironi. In questi cerchi, egli pone i dannati, secondo la tipologia di peccato commesso e la gravità. Più grave è il peccato, più in basso sarà collocato il peccatore all’interno della voragine infernale. I 9 gironi nei quali vengono posti i peccatori, sono differenziati, oltre che per il peccato commesso, anche a seconda della punizione stabilita. Dante sceglie dei principi per stabilire la punizione adeguata, e un esempio è quello denominato come legge del contrappasso: si afferma che tramite punizioni simili o contrarie al peccato commesso, si ha un’esagerazione destinata alla punizione del peccatore. In ogni girone presente Dante spesso parla con alcuni dei peccatori chiedendo di spiegare la loro storia e come sono finiti lì; un esempio: Paolo e Francesca, collocati nel girone dei lussuriosi. Fino ad arrivare sul fondo dove egli pone Lucifero, con tre teste nelle quali tiene 3 traditori: Giuda, Bruto e Cassio.
Purgatorio: la montagna dell’espiazione
La struttura della Divina Commedia è ben definita anche per il Purgatorio, che come detto in precedenza contiene 33 canti. Dante conferisce la conformazione di un monte sul quale egli salirà per arrivare al Paradiso terrestre, il ponte per arrivare in Paradiso. La montagna del Purgatorio è divisa in Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso Terrestre. Ciò che differenzia le anime del Purgatorio da quelle dell’Inferno è la salvezza, dato che esse, risalendo la montagna, espiano i loro peccati, secondo un ordine che va dal peccato più grave al più lieve, e riescono a raggiungere il Paradiso. Nel Purgatorio, le anime purganti, pronte all’espiazione dei loro peccati, sono poste in alto, quindi al raggiungimento del Paradiso.
Paradiso: la struttura dei cieli e la visione di Dio
Il Paradiso viene considerato spesso come il canto più difficile, poiché la struttura della Divina Commedia ha un’evoluzione lineare. Il Paradiso, avendo una connotazione a sé stante, esprime la condizione dell’uomo, il quale è impossibilitato a raggiungere Dio. La descrizione che ne fornisce Dante riguarda molto spesso il piano sensibile; dunque annuncia un canto con molta luce, melodie angeliche che accompagneranno la fine del suo viaggio ultraterreno. La struttura del Paradiso è secondo il sistema geocentrico di Aristotele e Tommaso d’Aquino, nel quale viene disposto al centro Dio, contornato da 9 cieli concentrici nei quali sono posti angeli, arcangeli e anime beate. La cantica si conclude con la visione di Dio, della Trinità e dell’Empireo.
Struttura della Divina Commedia: personaggi e allegorie
All’interno della complessa struttura della Divina Commedia, i personaggi assumono anche un valore allegorico, in quanto simboleggiano concetti astratti o entità morali e spirituali. Attraverso di essi, Dante rappresenta vizi e virtù, dannazione e salvezza.
Beatrice e la teologia: la donna angelo
Beatrice, la donna angelo dello Stilnovo, amata da Dante, è la guida del poeta nel Paradiso. Rappresenta la Grazia, la Fede, la Teologia, colei che permette all’uomo di elevarsi a Dio.
Virgilio e la ragione: la guida nei primi due regni
Virgilio, il poeta latino autore dell’Eneide, è la guida di Dante nell’Inferno e nel Purgatorio. Rappresenta la ragione umana, la filosofia, la saggezza, che conducono l’uomo fino a un certo punto del cammino di purificazione, ma non possono sostituire la Fede per raggiungere la salvezza.
La lingua della Divina Commedia: l’importanza del volgare
Dante sceglie di scrivere la Divina Commedia in volgare fiorentino, a differenza delle opere dotte del tempo, che erano scritte in latino. Questa scelta rivoluzionaria contribuisce all’affermazione del volgare come lingua letteraria e alla nascita della letteratura italiana. Dante arricchisce il volgare con latinismi, neologismi e provenzalismi, creando una lingua nuova, potente ed espressiva. La Divina Commedia diventa così un modello linguistico per i secoli successivi e un punto di riferimento per la nostra identità nazionale.
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia.