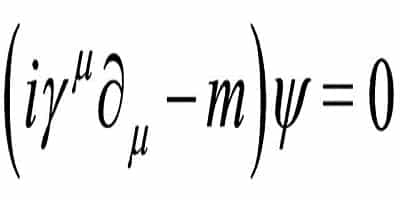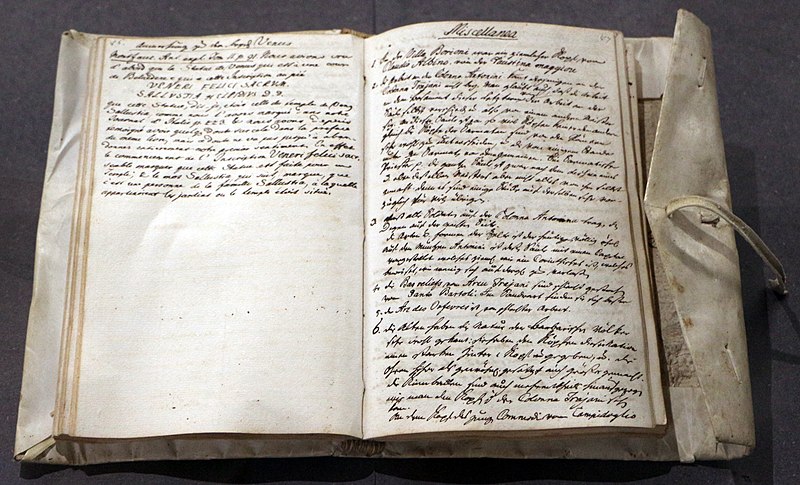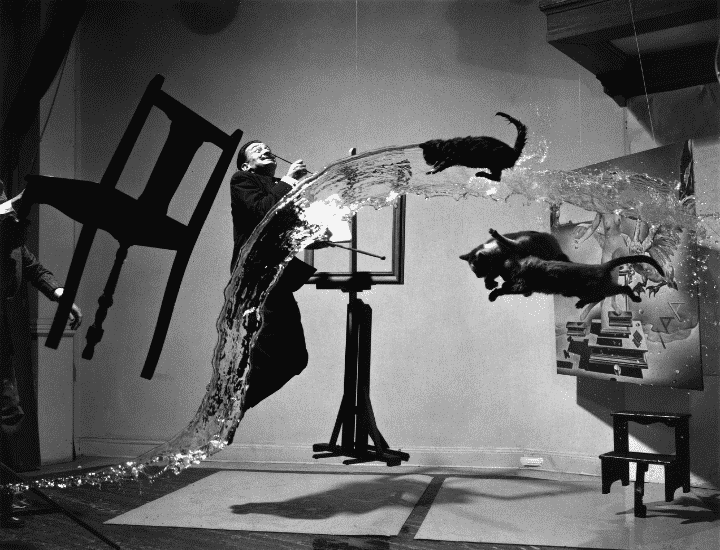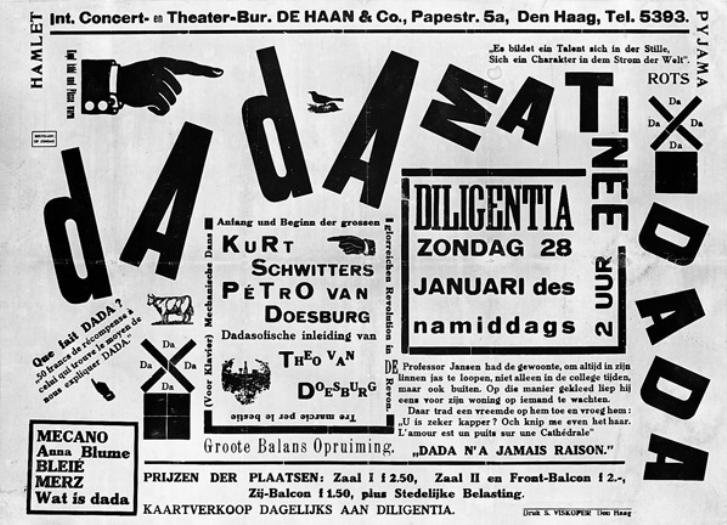Ulisse e Dante: l’incontro nell’Inferno della Divina Commedia
Nella Divina Commedia, il rapporto tra Ulisse e Dante assume una valenza particolare, diventando uno degli episodi più celebri e discussi dell’intera opera. L’incontro tra l’eroe greco e il Sommo Poeta avviene nel Canto XXVI dell’Inferno, all’interno dell’ottava bolgia, dove sono puniti i consiglieri di frode. La figura di Ulisse, avvolta in una fiamma insieme a Diomede, emerge in netto contrasto con i dannati incontrati in precedenza, rappresentando un’umanità complessa, un esempio di eroica grandezza e, al contempo, di dannazione. Proprio nel Canto XXVI si concentra l’attenzione sull’Ulisse dantesco.
L’Ulisse di Dante: tra dannazione ed eroica grandezza
In netto contrasto con i gruppi di dannati, rappresentanti di un’umanità mediocre e volgare, che popolano le bolge precedenti, spicca per la sua isolata grandezza, al centro dell’ottava bolgia, la figura dell’Ulisse dantesco. Il nome di Ulisse giungeva alla cultura medievale come quello d’un uomo famoso per la sua abile arte oratoria e, insieme, per gli inganni che aveva ordito: un personaggio contraddittorio, magnanimo e calcolatore, certo più vicino all’avventuroso protagonista dell’Odissea che all’eroe dell’Iliade. La figura di Ulisse, così come appare nel Canto XXVI, è frutto di una rielaborazione originale da parte di Dante.
Un personaggio controverso nella cultura medievale
Il nome di Ulisse era noto nella cultura medievale per la sua straordinaria abilità oratoria, ma anche per gli inganni che aveva ordito nel corso della sua vita. Si trattava di un personaggio complesso e contraddittorio, magnanimo e calcolatore, più simile al protagonista dell’Odissea che all’eroe dell’Iliade. L’Ulisse dantesco è un personaggio controverso.
Ulisse prima di Dante: le fonti classiche
Nel Canto XXVI dell’Inferno, che accoglie nella sua seconda parte l’incontro di Dante con l’Ulisse dantesco, l’eroe è fiamma che brucia tra i consiglieri di frode, insieme a Diomede. Le ragioni di tale pena sono brevemente ricordate da Virgilio: l’inganno del cavallo di legno per entrare nella città di Troia e concludere così il lungo assedio; l’inganno ai danni di Achille, dalla madre Teti celato in abiti femminili alla corte di Licomede, re di Sciro, ma di lì strappato da Ulisse e Diomede giunti travestiti da mercanti; e il furto del Palladio, la piccola statua di Atene dal potere prodigioso, trafugata da Ulisse e Diomede introdottisi nottetempo in città sotto mentite spoglie (Eneide, II, 162 sgg.), per indurre i Troiani a ritenere di non esser più protetti dagli dèi.
Il ruolo di Virgilio nella rappresentazione dell’Ulisse dantesco
L’autore antico che, per così dire, consegna a Dante questo Ulisse, è Virgilio, che lo definisce scelerum inventor, cioè inventore-ideatore di azioni delittuose. Sulla tradizione classica dell’eroe greco, demone dell’inganno, Dante innesta il suo Ulisse dantesco, che ha generato, a sua volta, una fascinosa tradizione di scienziato e di esploratore, costante nei secoli, e giunta fino ai nostri tempi. L’interpretazione di Virgilio influenzerà profondamente l’Ulisse dantesco del Canto XXVI.
Il rapporto tra Ulisse e Dante nel canto XXVI: la sete di conoscenza e la sua ambiguità
Nell’Odissea sono presenti due temi che avranno grande risalto nell’episodio dell’Ulisse dantesco: il primo è quello della conoscenza del tutto (la tentazione delle Sirene, alla quale, se libero, Ulisse non resisterebbe); l’altro è quello del viaggio per mare che l’eroe avrebbe compiuto in età avanzata e della morte che gli sarebbe giunta sempre dal mare. Ebbene, l’Ulisse di Omero non è dimenticato da Dante, ma interpretato in modo nuovo: dinanzi ad egli, l’alternativa fra ammirazione e condanna si fa più forte in quanto, attraverso la storia di lui, il poeta affronta il problema della conoscenza, che sente centrale nella vita dell’uomo e, di conseguenza, costituisce il nodo essenziale del suo poema. Nel Canto XXVI, Dante esprime tutta la sua ammirazione e al tempo stesso la sua condanna per l’Ulisse dantesco.
Hybris e dannazione: il folle volo di Ulisse
E proprio la sete di conoscenza, una hybris culturale, l’ardore di svelare con la propria intelligenza tutti gli aspetti della natura umana e delle varie forme del creato fa di Ulisse il simbolo del mondo antico nella sua coscienza più alta. Odisseo, però, non ha il contemplativo distacco degli «spiriti magni» del Limbo, ma appare travolto da una passione che cancella in lui la necessità di controllare le doti naturali: sicché assume un significato profondo l’immagine della fiamma, che lo avvolge e lo tormenta. L’ansia di conoscere, che porta l’Ulisse dantesco alla sua epica e tragica fine, si traduce poeticamente nel solenne monologo, in cui il protagonista racconta il suo ultimo viaggio, il suo “folle volo” narrato nel Canto XXVI: dalla partenza alla descrizione dell’itinerario interno al Mediterraneo, al drammatico inoltrarsi per l’alto mare aperto, al miraggio della montagna misteriosa, fino all’improvviso inabissarsi. Ulisse non appare, come il personaggio omerico, vittima di un dio, Nettuno, ma volontario protagonista di un destino che lo porta alla sconfitta. Il suo viaggio si traduce in un folle volo, in quanto affronta lo spazio sconfinato dell’avventura e del rischio.
Ulisse e Dante: scienza e morale a confronto
Nell’allontanarsi da Itaca, Odisseo si abbandona all’impeto d’un sentimento più forte, non legato a luoghi o persone, ma tutto spirituale. Egli vuole realizzare in sé l’uomo libero da ogni legame e da ogni responsabilità, che siano quelli che gli vengono dalla sua stessa natura di essere intelligente e avido di conoscenza. Con il suo Ulisse, Dante, sulla scia di tanti autori classici, pone il problema drammatico, e ancor oggi attualissimo, dei rapporti tra scienza e morale. Per Dante, pertanto, l’eroe diviene figura emblematica e complessa di un problema che lui stesso ha vissuto: il valore antitetico che può assumere la sete di conoscenza, ora spinta capace di nobilitare l’uomo, ora fonte di presunzione e di peccato. Ma ben avverte il fascino di questo personaggio, dell’Ulisse dantesco, che rappresenta uno dei miti umani più alti e in lui fa rivivere il contrasto fra la fiamma, che è luce del magnanimo intelletto, e il fuoco, che è pena del peccato di presuntuosa superbia. Il canto XXVI è anche una riflessione sul valore della conoscenza.
Il personaggio di Ulisse deriva, certo, dalla tradizione classica una dimensione eroica e magnanima, ma diviene anche l’esempio di un’etica del successo, che Dante, animato dal senso della misura tipico della morale cavalleresca, non condivide. Conoscere è, secondo Dante, il compito primario dell’uomo, ma esso assume un significato positivo per il fine che si propone: l’uomo si innalza quando si impegna a conoscere per amore.
Fonte immagine per l’articolo su Ulisse e Dante: wikipedia