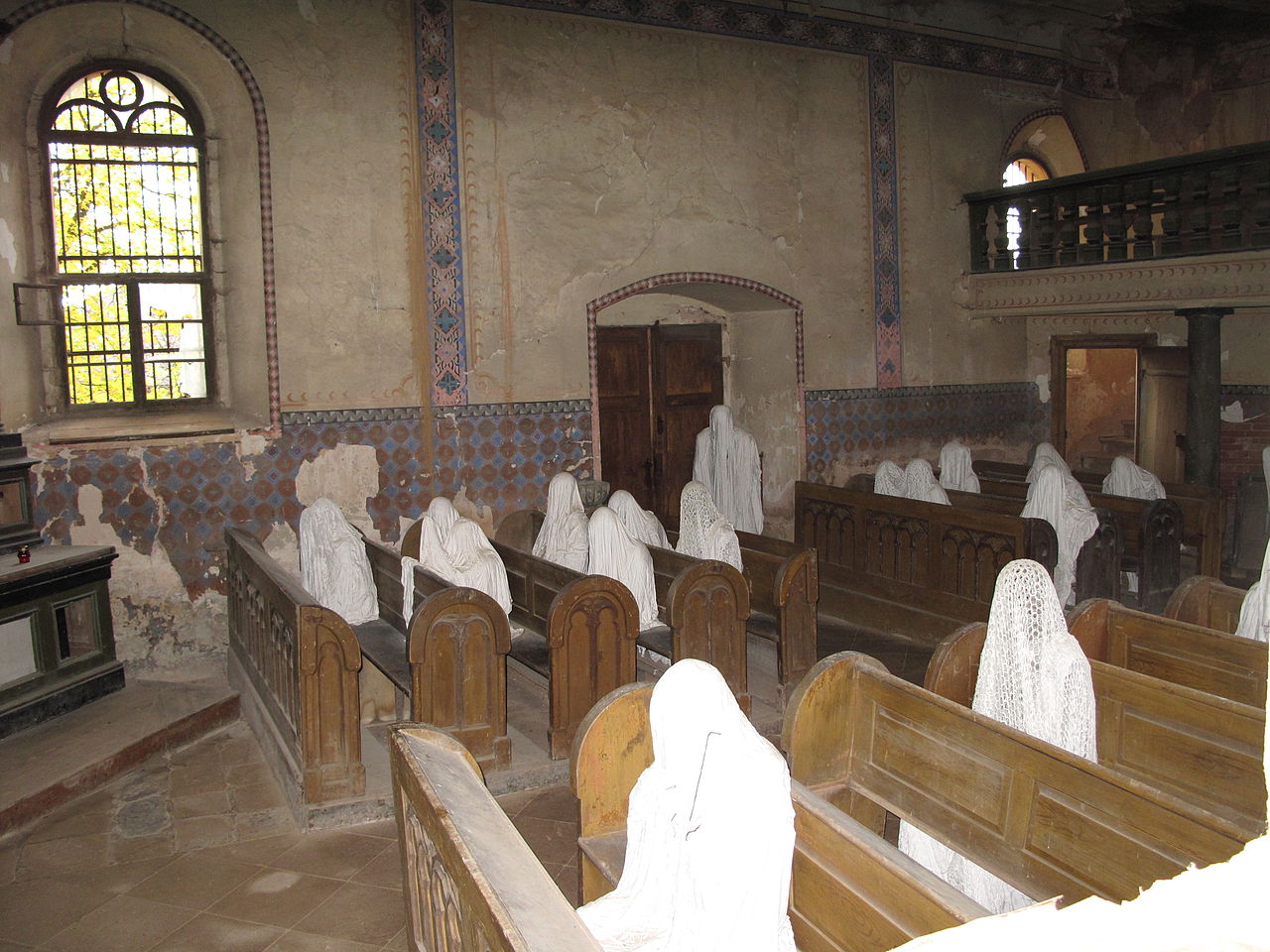Dal 2015 alcuni monumenti di Palermo e le cattedrali di Cefalù e Monreale sono stati inseriti nella lista dei patrimoni dell’umanità. In particolare, a Palermo il numero di beni artistico-monumentali in stile arabo-normanno ammonta a sette.
Stile arabo-normanno
Palermo vanta il maggior numero di monumenti in stile arabo-normanno in Sicilia. L’architettura che li distingue si caratterizza dalla commistione di stile arabo-normanno e di altri stili dell’area mediterranea. Tutti i monumenti sono stati costruiti nell’XI e XII secolo, quando i re normanni che governavano l’isola decisero di sfruttare la bravura delle maestranze arabe per far erigere nuovi palazzi in uno stile del tutto originale, che includesse le influenze artistiche delle maggiori civiltà mediterranee. Il nome arabo-normanno non rende giustizia a questo stile che, oltre all’arte araba e normanna, ha una forte componente bizantina. Gli elementi architettonici tipici di questo stile per le chiese e le costruzioni civili sono: pianta basilicale a croce latina o greca, torri e portale sulla facciata. Gli interni sono spesso abbelliti da mosaici in stile bizantino e ornamenti arabi. Suggestiva è anche la posizione in cui si trovano queste costruzioni, spesso circondate da meravigliosi giardini e rinfrescate da fontane.
I sette siti in stile arabo-normanno a Palermo sono: Palazzo Reale o dei Normanni, la Cappella Palatina, la Cattedrale, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o della Martorana, Chiesa di San Cataldo, Castello della Zisa e Ponte dell’Ammiraglio.
Palazzo Reale
È stato la residenza dei re normanni. Fu costruito nel X secolo dagli arabi, ma furono i normanni a renderla un palazzo sontuoso e raffinato. Ospita al suo interno la Cappella palatina, interamente decorata nella parte superiore da mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti scene bibliche varie, gli evangelisti e il Cristo Pantocratore.
Cattedrale di Palermo
È il principale luogo di culto della città, nonché simbolo di Palermo. Sul sito era presente una costruzione precedente che però venne distrutta nell’XI secolo. I normanni ricostruirono la nuova cattedrale sotto il regno di Guglielmo II in stile arabo-normanno. L’imponente struttura oggi ospita le tombe reali; tra le altre ricordiamo il sepolcro dell’imperatore Federico II in granito rosso, che è ornato da quattro leoni che sorreggono l’urna.
Chiesa di San Giovanni degli Eremiti
Si caratterizza per la struttura cubica sormontata da una cupola rossa. Quest’unità architettonica qui si ripete cinque volte. Al suo interno la chiesa è spoglia di ornamenti. Il chiostro al suo interno è a pianta rettangolare con gli archi a sesto acuto su colonnine binate.
Chiesa della Martorana
La sua edificazione si deve al grande Ammiraglio del Regno, Giorgio Antiocheno, che volle ringraziare la Santissima Vergine per l’aiuto e la protezione concessagli. Il vero tesoro della chiesa si trova al suo interno, che è interamente decorato da mosaici in stile bizantino. Il fulcro di tutta la composizione è il Cristo in trono, visibile sulla sommità della cupola. Oggi la chiesa officia la liturgia per la minoranza italo-albanese presente in Sicilia secondo il rito bizantino.
Chiesa di San Cataldo
Situata di fronte alla Martorana. Come in tutte le precedenti costruzioni in stile arabo-normanno, anche in questa chiesa è visibile l’incontro tra Occidente e Oriente. All’esterno è adornato da tre finestre per lato, sormontate da una merleggiatura arabeggiante che circonda la struttura. In cima alla chiesa, tre cupole a semicerchio danno alla chiesa un fascino esotico.
Castello della Zisa
Prende il nome dal termine arabo al-Aziz, che significa “splendido“. In passato era immersa nel grande parco reale di caccia. All’edificio rettangolare a tre piani si accede attraversando un cortile abbellito da un sistema unico di fontane. Alla Zisa è possibile vedere un bellissimo esempio di muqarnas, una decorazione tipicamente araba con volte a stalattiti. Oggi la Zisa ospita il Museo d’arte islamica, che raccoglie opere provenienti dalla Sicilia e dall’area mediterranea prodotte tra il IX e il XII secolo.
Ponte dell’Ammiraglio
È un ponte a dodici arcate con archi molto acuti, capaci di sostenere carichi elevatissimi. Oggi, sotto il ponte non scorre più il fiume Oreto, perché il suo corso è stato deviato a causa dei continui straripamenti. Privato del suo fiume, il ponte ha perso la sua funzione ma ha mantenuto il suo fascino.
Fonte immagine: Wikipedia