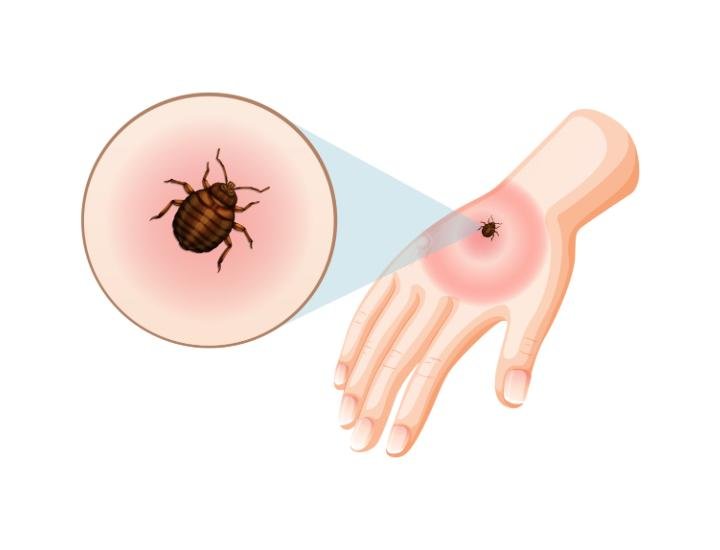L’eruzione dell’Ignimbrite Campana è stata una delle più potenti e sconvolgenti che l’Europa abbia visto. È un capitolo fondamentale nella storia geologica recente del nostro Mediterraneo. Accadde circa 39.000 anni fa, scatenata dai Campi Flegrei, quell’area vulcanica a ovest di Napoli che ancora oggi ribolle di vita, tra il famoso bradisismo, fuoriuscite di calore e gas. Questa eruzione è stata talmente violenta da meritarsi la classificazione pliniana ultrapliniana. Oltre 150 chilometri cubi di magma furono vomitati dalla terra.
Cronaca dell’eruzione: le fasi del cataclisma
L’eruzione non avvenne tutta in una volta, ma si sviluppò attraverso diverse fasi drammatiche. Tutto iniziò con un incontro esplosivo tra acqua e magma incandescente (fase freatomagmatica), che aprì la strada verso la superficie. Poi, l’eruzione vera e propria: fasi pliniane potentissime crearono una colonna di fumo, cenere e gas alta oltre 40 chilometri. Curiosamente, il vulcano stava pescando magma da due serbatoi diversi nello stesso momento: uno più superficiale ed evoluto, uno più profondo e primitivo. Questa camera magmatica, situata a circa 4 km di profondità, era enorme e stratificata.
Col passare del tempo, l’immensa colonna eruttiva non resse più il proprio peso e collassò. Da questo collasso nacquero fiumi incandescenti di cenere e gas incredibilmente veloci e mobili. Si spinsero fino a 50 km a nord, raggiungendo la zona del vulcano Roccamonfina, e dilagarono verso sud, attraversando il Golfo di Napoli e investendo la penisola sorrentina. Il collasso della caldera che seguì fu così violento da estrarre contemporaneamente entrambi i tipi di magma, aprendo nuove fratture e alimentando altri flussi piroclastici, così potenti da scavalcare montagne alte più di 1000 metri. Le fasi finali videro l’emissione del magma rimasto, quello meno evoluto, generando flussi più piccoli ma comunque capaci di stravolgere il paesaggio.
Ignimbrite Campana: le cicatrici sulla Terra e nel clima
L’impatto più diretto fu devastante: due terzi della Campania furono letteralmente sepolti sotto una coltre di tufo. In alcune zone, questi depositi piroclastici raggiungono ancora oggi i 100 metri di spessore, cancellando il paesaggio preesistente. Ma gli effetti andarono ben oltre la regione. L’eruzione lanciò nell’atmosfera quantità enormi di ceneri sottilissime e di composti di zolfo. Furono proprio questi ultimi che, una volta in quota, si trasformarono creando una specie di velo capace di riflettere parte della luce solare. Il risultato è stato un raffreddamento significativo su scala globale. Si calcola che le temperature medie nell’emisfero nord siano scese di ben 4°C.
Il freddo inatteso e le sorti dell’umanità
Questo inverno vulcanico si aggiunse a un periodo di raffreddamento già in atto nell’Atlantico, rendendolo ancora più intenso e prolungato. Fu una vera e propria perturbazione climatica su larga scala. Studiando gli strati lasciati da questo cataclisma nei diversi siti archeologici, è emersa un’ipotesi affascinante. L’eruzione potrebbe aver avuto un peso sulla storia dell’uomo. Quel periodo, infatti, coincide con il passaggio tra Paleolitico medio e superiore. L’epoca in cui i Neanderthal cominciarono il loro declino e l’Homo sapiens si diffondeva. Si pensa quindi che questo evento catastrofico possa aver giocato un ruolo in quel grande cambiamento.
Ignimbrite Campana: una firma indelebile nella roccia
Dal punto di vista geologico, l’ignimbrite è la roccia che nasce quando i fiumi incandescenti di cenere e gas si raffreddano e si solidificano. Gli strati lasciati da questa eruzione sono così estesi che oggi li riconosciamo in tutto il Mediterraneo. Funzionano come un segnalibro nel grande libro del tempo geologico, aiutando gli scienziati a datare altri depositi. E in Campania la storia non finisce: circa 15.000 anni dopo un altro evento vulcanico importante ha lasciato il segno nei Campi Flegrei: l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano. Non è raro trovare i suoi depositi proprio sopra quelli dell’Ignimbrite Campana, come pagine successive dello stesso racconto geologico.
Imparare dal passato per capire il presente
Studiare l’Ignimbrite Campana è fondamentale. Insegna come funzionano i supervulcani, aiuta a valutare i rischi vulcanici di oggi e racconta anche come le culture del passato hanno reagito a eventi così estremi. Capire questo evento del passato è cruciale per comprendere meglio i rischi che l’area flegrea corre oggi e potrebbe correre in futuro. Per la sua scala e le sue conseguenze, l’eruzione dell’Ignimbrite Campana rimane un evento simbolo nella vulcanologia mondiale e un punto fermo nella storia geologica del nostro mare.
Fonte immagine: Apple Maps