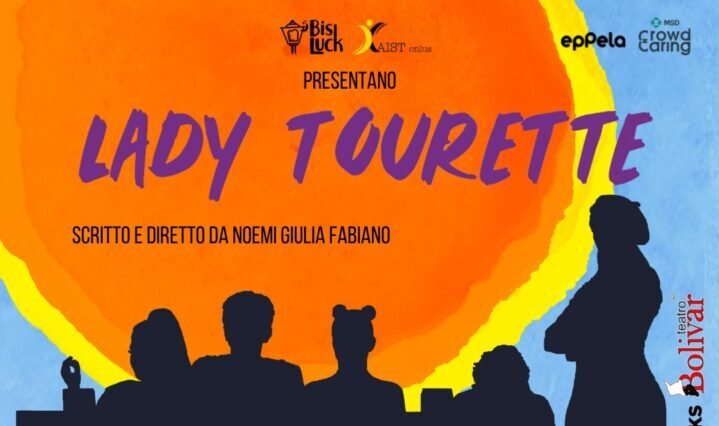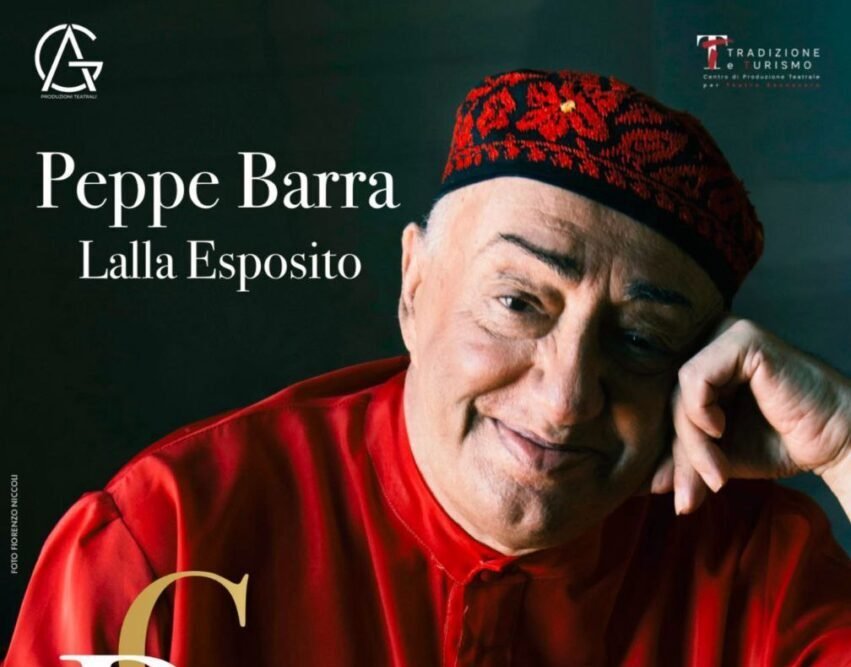Prosegue la stagione 2024/2025 del Teatro di Napoli con Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello, riadattato da Marco Tullio Giordana e Geppy Gleijeses, in scena al Teatro Mercadante dal 28 gennaio al 2 febbraio.
Il fu Mattia Pascal a teatro: dal romanzo che diede a Pirandello fama mondiale
Pubblicato nel 1904, Il fu Mattia Pascal ha restituito al suo autore Luigi Pirandello una fama mondiale, tanto da essere considerato un romanzo nevralgico nella poetica di costui. Attraverso una penna umoristica che dipinge maschere, viene affrontato e portato ad un suo potenziamento addirittura paradossale se non proprio surreale il tema del doppio, tanto caro a buona parte della letteratura novecentesca su personaggi apparentemente “inetti” alla vita. Dov’è il torto? Dov’è la ragione? Cos’è la realtà? Cos’è la finzione? Caos e razionalità si fondono fino a confondersi davanti a un Mattia Pascal ritenuto e dato come morto per anni, ma vivo inconsapevolmente sotto le mentite spoglie di Adriano Meis. Lo spettacolo, riadattato da Geppy Gleijeses e Marco Tullio Giordana (anche regista della pièce) viene messo in scena al Teatro Mercadante con la partecipazione attoriale di Geppy Gleijeses, Marilù Prati, Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Totò Onnis, Ciro Capano, Salvatore Esposito, Teo Guarini, Davide Montalbano e Francesca Iasi.
Si legge nella sinossi su Il fu Mattia Pascal: «Un uomo creduto e poi fintosi morto, quando “risuscita” s’accorge che non può essere riammesso nella società, nella famiglia, perché per la società, per la famiglia egli è morto davvero. Quale prova più scintillante del sentimento del contrario? Disonestà e purezza, vita-morte nel grande caleidoscopio della certezza sociale, che bolla come sicuro quello che non esiste e come inesistente quello che vive. E dentro una tessitura umoristica, elementi riflessivi e irrazionali sconvolgono quella quarta parete, che nel teatro come nel romanzo dovrebbe essere protezione d’impersonalità, come se l’autore stesso e il pubblico non esistessero. Il significato che Il fu Mattia Pascal assume nello sviluppo dell’opera pirandelliana è ben lontano dall’essere riconosciuto ancor oggi pienamente, pur trattandosi di un’opera che ebbe grande fortuna. E, incredibilmente, pur nascendo come romanzo (e che romanzo!) è uno dei titoli teatrali pirandelliani di maggior successo, se non quello di maggior “chiamata”. È una “farsa trascendentale” retta sull’assurdo» – Geppy Gleijeses.
Il Doppelgänger come sovrapposizioni di intenti e linguaggi
Il fu Mattia Pascal nel riadattamento scenico di Giordana e Gleijeses riesce a restituire un umorismo portato così tanto all’estremo da risultare surreale e paradossale. Vita e morte, principi arcani, non conoscono dicotomia, l’origine del caos ingloba la ragione, o meglio è nel caos stesso che si trova la ragione stessa. In questo sdoppiarsi e sovrapporsi non può, infine, che scaturirne un gioco metateatrale in cui è proprio il teatro a essere messo in discussione: la quarta parete viene abbattuta, forse addirittura annientata e ritenuta come ormai un velo riutilizzato per discutere e riflettere sull’apparenza e l’autenticità di ogni individuo, di ogni cosa. Le scene scorrono, quasi come un carrello cinematografico, e quel gioco teatrale vive ramificandosi in più stili e direzioni. Detto ciò, ecco che la recitazione apparentemente “eccessiva” trova un suo posto e il ritmo scenico viene scandito e sostenuto con parsimoniosa eleganza, non facile data la complessità dell’opera e – da non sottovalutare – la durata della messinscena.
Eppure…riflessioni sui classici a teatro!
A proposito dei classici Italo Calvino sostiene che «I classici sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando si impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale» – e Il fu Mattia Pascal si annovera tra questi imponendosi, come detto anche prima, tra i classici di maggiore importanza della letteratura novecentesca. Ma questa permanenza memoriale comporta anche una capacità potenzialmente straordinaria di rinnovo e riadattamento a nuovi contesti, nonché a nuove generazioni e, dunque perché no, a nuove forme espressive. In questo caso, si assiste al passaggio dal romanzo – di certo già molto teatrale – alla drammaturgia procreata per la scena. È sempre un’operazione interessante, ma il punto non è soltanto la riuscita dello spettacolo, che esso sia godibile e ben strutturato, altrimenti diventerebbe un discorso celebrativo del classico stesso. Piuttosto, è sempre bene riflettere su una domanda tanto semplice quanto poco scontata: perché? Per far sì che quella natura sempre “inedita” del classico, possibilmente accessibile, venga fuori, come interrogare un classico? È sulla modalità, sulla scelta di estrapolare e potenziare un’idea, uno spirito del classico, su cui forse è molto più utile e funzionale interrogarsi criticamente per riflettere – l’obiettivo di cui non ci si dovrebbe mai stancare.
Fonte immagine di copertina: Ufficio Stampa